


 |
 |
 |
Diritti di autore:
Copyright 2005 Andrea Lomartire
La presentazione di quest’opera è proprietà dell’autore. Diritti riservati
conforme alla legge e alle convenzioni internazionali.
Proibita la riproduzione parziale o totale, senza permesso scritto dell’autore.
PIAZZA DELLE CINQUE LUNE:
FILM STORICO O RACCONTO DI FINZIONE?

ANALISI DEL FILM DI RENZO MARTINELLI
ALLA LUCE DI NUOVI ELEMENTI STORICI
Relazione di Andrea Lomartire
Indirizzo/i di posta elettronica:
lomandc@yahoo.it
INTRODUZIONE
Un film è sempre un fatto narrativo, un racconto formato da un intreccio destinato alla soluzione finale, composto di eventi e di esistenti[1]. Lo statuto è in primo luogo estetico e non politico o storiografico. Tuttavia esiste una narrazione cosiddetta “impegnata” che ambirebbe a divenire cinema politico e che si riferisce ad una serie di opere profonde e minuziose, le quali rifletterebbero, ineccepibilmente, il contesto storico sociale da cui provengono. Si tratta di racconti legati agli uomini della contemporaneità. In questo ambito si può affermare che il primo film politico della cinematografia italiana è quello di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano che partendo da un piccolo fatto di cronaca, la morte di Turiddu, il re di Montelepre, inizia un’indagine del contesto politico del periodo, attraversando circostanze e nomi che hanno preso realmente parte in quella intricata vicenda. Da Salvatore Giuliano a all’ultimo Piazza delle Cinque Lune, il cinema italiano ha proposto una serie di opere “politiche” che hanno contribuito fortemente alla formazione di una coscienza storica, morale e nazionale del pubblico italiano. Il fruitore dell’opera cinematografica, lo spettatore, è colui che assume un ruolo importante ancora prima di entrare nella sala e vedere un film. Tale definizione riguarderebbe proprio il film politico, in quanto, l’atto stesso di raccontare una storia si completa nella mente dello “spettatore civile”. Non è soltanto un atto percettivo, un puro meccanismo formale, di relazione tra significato e significante. È molto di più: è in questo modo che lo spettatore dilata la sua consapevolezza sociale, e acquisisce una coscienza critica della modernità in cui egli si trova. Appartenere ad una comunità democratica e civile significa, prima di tutto, vivere coscientemente il ruolo di cittadino.
Esisterebbe, quindi, un cinema politico, un cinema che guarderebbe senza troppe velature, alla società in cui viviamo. Lo scopo di questo cinema è quello di ampliare e approfondire la visione storica di quegli eventi che hanno caratterizzato la vita pubblica e civile del paese tentando, al tempo stesso, una interpretazione-sensibilizzazione su alcuni temi scottanti ancora oggi irrisolti: il caso Mattei, l’omicidio di Pasolini, il sequestro Moro, la scomparsa di Matteotti, lo stragismo, il terrorismo, la bancarotta di Michele Sindona, la vicenda di Ambrosoli, la strage di Ustica. Il cinema di questo genere avrebbe, per tanto, una funzione sociale e politica nel senso più filosofico del termine: diverrebbe specchio e memoria di un percorso storico fondamentale per il cittadino e che altrimenti rischierebbe di essere travolto dal magma indistinto e, molto spesso, confuso dell’informazione. Senza la possibilità di studiare il passato, non esisterebbe quella di realizzare un futuro psicologico, sociale e politico.
Dunque il cinema è la memoria, il supporto storico e sociale, è la possibilità di sviluppare una coscienza storica e culturale, necessaria per il progresso di una Nazione o Paese, che dir si voglia. Tuttavia, come affermavo all’inizio, non bisogna dimenticare che il cinema è prima di tutto un fatto narrativo, una finzione scenografica, formata da attori e stampata su di una pellicola e riprodotta a 24 fotogrammi al secondo. Nondimeno non si può negare una sorta di autentico impulso di ricerca storica che costituisce uno dei suoi aspetti peculiari: se il cinema è svago, spettacolo, emozione, è anche ricerca storica, indagine, proprio come i film summenzionati, proprio come Piazza delle Cinque Lune, film quasi passato in sordina all’interno del panorama cinematografico italiano. A tale proposito, il regista afferma: «Quando sento parlare di "rinascita del cinema italiano" mi viene da ridere. Su 50 film italiani prodotti, 45 sono commedie. Noi viviamo in un paese che ha avuto 18 anni di terrorismo con 540 morti. Ci sono stati 3 film. Tangentopoli ha prodotto un film. La società e il cinema seguono binari differenti, mentre il tanto criticato cinema americano affronta ogni segmento del sociale: la Cia, Kennedy, la Corea, le multinazionali del tabacco... Io sono cresciuto stimando il cinema di Petri, Rosi, Vancini, Pontecorvo, Damiani, decine di registi che attraversavano il sociale come delle locomotive. Perché è difficile fare un buon cinema civile in Italia? Io spero che questo film serva ai giovani per riflettere»[2]. Dunque un cinema la cui funzione è ricordare, sviscerare il passato rimosso, tentando di creare un dibattito acceso e produttivo. Da questo punto di vista il cinema di Martinelli, si veda l’esempio di Porzus o di Vajont, è certamente un alto contributo alla ricerca della verità storica, giudiziaria e al tempo stesso, opera di alto impegno civile e “politico”. Nel caso specifico, come metterò in evidenza attraverso l’ausilio di documenti giudiziari e il confronto semantico narrativo del film, l’impegno civile viene fortemente evidenziato dall’indagine proposta: i misteri di via Fani, le dichiarazioni ambigue di alcuni brigatisti, la dinamica balistica del sequestro. Si tratta di elementi specificatamente giudiziari che finiscono per avvalorare l’ipotesi investigativa del film. Il valore civile emerge nel tentativo di spazzare via la menzogna, l’occulto, e mostrare il possibile complotto.
Al centro del film c’è la vicenda di Aldo Moro[3], la cui storia ha continuato a ispirare alcune opere cinematografiche: Il caso Moro di Giuseppe Ferrara, quello grottesco e profetico di Elio Petri, Todo Modo, e in fine, anche se con un tono assai diverso, quello di Marco Belloccio, Buongiorno Notte. Tuttavia, soltanto nell’ultimo film di Martinelli si può iniziare a parlare di indagine giudiziaria in cui vengono rappresentati, con tanto di nome e cognome, i principali protagonisti di questa tragica vicenda. La verosimiglianza della narrazione costituisce un alto contributo del cinema di indagine, da divenire, un importante esempio di ricerca storica. Da qui, come analizzerò, prenderanno forma due racconti: quello dei personaggi che compiono l’indagine sul sequestro Moro e quello specifico del caso Moro. Si tratta di due racconti sovrapposti, da cui emerge la particolare struttura del film. Anche da questo, mi preme ricordare, che l’efficacia di un film, e di questo film, è data dalla costruzione narrativa ed estetica del racconto. Tale costruzione è il vero obiettivo del film, il compito di suggerire elementi inquietanti attraverso uno stile specifico e particolare. Solo se si comprende il valore estetico e semantico del film, possono emergere gli indizi inquietanti che lo stesso regista Martinelli ha messo in scena. Il trattamento di eventi storici, riferiti a circostanze esatte e documentate, offrono, indubbiamente, l’idea di un cinema impegnato e “politico”; ma è soprattutto la forma estetica del racconto, il montaggio, l’intreccio, la costruzione narrativa, la sua realizzazione che costituisce la fonte inesauribile del cosiddetto cinema politico e poetico.
1.
PIAZZA DELLE CINQUE LUNE, UN FILM POLITICO
«Quando si dice la verità, non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi». Si tratta della didascalia iniziale del film, una citazione dello stesso Aldo Moro. E Martinelli, sembra averla presa alla lettera: con questo film ha voluto «tentare un avvicinamento onesto alla verità […] il caso Moro rappresenta un mistero in assoluto […] gli anni di piombo hanno prodotto in questo paese, in 18 anni, più di 500 morti. Questa galassia del terrorismo ha prodotto 3 o 4 film. Quindi vuol dire che la cinematografia italiana è malata. Quando un cinema non interpreta il sociale, non lo vive attraverso i suoi cineasti è un brutto segno»[4]. La didascalia, in primo luogo, assume un ruolo fortemente “ideologico”: non soltanto attraverso il racconto che sta per svelarsi al pubblico, ma anche attraverso la scelta di un tema particolare e spinoso come il caso Moro. Il regista è inevitabilmente presente sin da questo livello verbale: la «verità» non è soltanto un punto di vista storico e giudiziario, ma è anche un punto di vista estetico e ideologico, che preme contro l’altro cinema italiano, quello che inconsapevolmente rimuove il dovere di descrivere la storia del paese, quello che dimentica il compito civile e sociale di un arte indirizzata verso l’impegno costruttivo della società. In questo preambolo, il regista introduce lo spettatore all’interno della storia e, al tempo stesso, gli indica una direzione precisa: la ricerca della verità.
In oltre, la didascalia si riferisce, inevitabilmente, ad un contesto storico e ad un contesto narrativo.
La funzione storica è indicata dalla ricerca di un difficile equilibrio politico sostenuto da Aldo Moro, spinto da un’opera di mediazione e di equilibrio tra le diverse forze del paese. Durante la sua prigionia, lo statista avrebbe analizzato, attraverso le sue lettere, l’assurdo comportamento di uno Stato che si era trovato lui stesso a servire e ad incarnare. Moro tenterà di trattare i suoi “segreti”, elaborando, in più di un’occasione uno scambio con altri prigionieri brigatisti. Sarà un tentativo inutile, scartato in principio dal suo stesso partito. L’unico esito della trattativa sarà quello del 9 maggio: Moro, il suo corpo, verrà ritrovato dentro il cofano di una Renault 5 senza che egli abbia potuto comprendere, probabilmente, la forza oscura di un certo livello della “politica” che lui stesso si era trovato a praticare e poi a interrogare. Dunque la «verità» della didascalia scelta dal regista Martinelli tende a ribadire il significato di ricerca, di mediazione e di accordo che ha caratterizzato l’attività politica di Aldo Moro, fuori e dentro la sua prigionia.
Insieme alla funzione storico-biografica, si può rintracciare la funzione narrativa che il film si propone di portare a compimento secondo la migliore tradizione cinematografica italiana. Il film può tranquillamente essere inserito in ambito del cosiddetto cinema politico[5]. Si tratta di osservare come il film tenti di raccontare il “caso” Moro anche attraverso gli “indizi” giudiziari, evitando di limitare la narrazione soltanto al puro intreccio. Il film, mentre racconta la storia del Giudice Saracini, un personaggio inventato, tratta la verità giudiziaria del misterioso sequestro dello statista, avvalendosi di una precisa e dettagliata documentazione e della consulenza del senatore Sergio Flamigni[6].
Dunque, il film argomenta la sua storia intorno alla ricerca di una verità possibile, di una verità giudiziaria tentando di mettere insieme i vari tasselli del caso e trarne un’immagine d’insieme quanto più vicina alla drammatica vicenda dello statista.
La ricerca della verità è presente anche attraverso il linguaggio verbale che culmina in molti dialoghi: l’esclamazione di Branco (Giancarlo Giannini), guardia del corpo del giudice, il quale considera il Memoriale un’ossessiva ricerca della verità; attraverso il misterioso agente segreto a Parigi (F. Murray Abraham) che imposta un discorso piuttosto sibillino sulla verità e il corso della storia; o ancora, caso più drammatico, attraverso il marito di Fernanda Doni (Stefania Rocca) che ironizza piuttosto pesantemente sulla ricerca di una verità impossibile che rischia di sfaldare tutta la famiglia. Dunque, da questo punto di vista, il film presume di raccontare la verità sul caso Moro.
Le inquadrature, i tasselli del puzzle Moro, sono gli indizi che tentano di ridare il senso di quella verità perduta e attraverso l’ausilio delle immagini girate: il caso estremo, ma verosimile si ha con il sequestro di Via Fani[7], o ancora attraverso i frammenti di flashback che si palesano improvvisamente sullo schermo durante l’indagine dei tre protagonisti (si pensi all’arresto di Curcio e di Cagol, alle scene di Via Gradoli, l’uccisione di Pecorelli, l’esecuzione del colonnello Varisco). In questa prospettiva, la verità, quella costruita dalla finzione scenica, finisce per divenire l’unico elemento storico giudiziario che mostra il crimine come oggettivamente avvenuto. In tal senso si può scorgere l’ambizione implicita del film, e cioè quella di divenire una sorta di resoconto giudiziario, la versione più verosimile degli eventi che dettero vita al caso Moro.
Da un punto di vista narrativo, quello che Seymour Chatman ha definito come la forma del discorso, si può osservare come sia fondamentale il rapporto che si stabilisce tra l’evento raccontato e il punto di vista della macchina da presa. Il film ricorre molto spesso all’inquadratura dall’alto (la panoramica) quasi ad indicare l’importanza di una visione globale che possa mostrare i tasselli del racconto, altrimenti non visibili. Non è certo un caso che il film si chiude con l’ennesima inquadratura dall’alto, la quale, oltre a schiacciare il personaggio del giudice colto di sorpresa dall’incontro con Branco, ribadisce il fatto che “sopra” alla visione provinciale del giudice, o “oltre” il punto di vista ideologico e terroristico delle famigerate Brigate Rosse, vi sarebbe stata una strategia più ampia, di livello internazionale che spiegherebbe la possibilità di un complotto ordito contro il fautore della politica di Solidarietà Nazionale. Il giornalista Willan descrive, nel suo bel volume, I burattinai, tutte le incongruenze dell’affaire: «e, infine, va sottolineata la profonda differenza che esiste – anche a livello psicologico – tra i due modi di muovere l’ “attore di legno”: il burattinaio costituisce un prolungamento della mano del burattinaio, una amplificazione dei suoi movimenti compiuta in positivo; esso prende corpo e vita dal braccio e dalle dita di chi lo manovra: la marionetta invece viene mossa come in negativo, in un modo indiretto, che da qualche marionettista ho sentito paragonare all’atto di suonare uno strumento musicale a corde: richiede dunque un attenzione di tipo razionale»[8]. L’interpretazione è presto data: i brigatisti sono stati delle marionette, mosse a loro insaputa da una serie di interessi nazionali e internazionali[9]. Il punto di vista, la veduta su Siena, la visione di Roma, spiega questa fondamentale impostazione narrativa del film. La teoria del complotto prende forma attraverso un’attenta analisi storica e giudiziaria, con precisi riferimenti collusivi tra Stato, servizi segreti e apparati militari. Per Willan il complotto esiste, non è soltanto una teoria, ed è quel movimento “negativo” che appartiene alle diverse marionette che hanno occupato la scena.
Lo stesso Sciascia, nel suo acuto scritto L’affaire Moro, aveva osservato che la “verità” e il “punto di vista” sono, in qualche modo, coincidenti: il lettore comprende che tutti i suoi sospetti sono erronei e per questo, sul finire del racconto (il punto di vista) è costretto a ri-iniziarlo, «il lettore, inquieto, rivede i capitoli sospetti e scopre un'altra soluzione, la vera»[10].
Dunque, il film nasce come ricerca della verità non più metaforica o simbolica, ma immagine diretta e immediata, come l’organigramma dei Comitati di sicurezza istituiti subito dopo il sequestro Moro, esibito all’interno di un’inquadratura, con i nomi degli affiliati alla Loggia Propaganda Massonica P2. La verità non è più allegorica o sottesa come avveniva in certe opere italiane. Si pensi a Salvatore Giuliano in cui Francesco Rosi evita di citare il nome del ministro degli Interni Mario Scelba che lo stesso Gaspare Pisciotta aveva chiamato in causa durante il processo di Viterbo[11]. Nel 1986 Il caso Moro di Giuseppe Ferrara fa un accenno, se pur minimo, alla loggia P2, ma evita di citare nomi importanti[12]. Il racconto di Piazza delle cinque lune mostra con estrema chiarezza la trama che ha generato l’affaire Moro, evitando di costruire il suo racconto attraverso complicate allusioni storiche o con l’ausilio di complesse forme simboliche. Il film parla chiaro e non risparmia accuse e sospetti. Dove esiste un margine per l’indagine, il racconto penetra la materia storica e tenta di approfondire gli eventi e i comportamenti degli uomini politici che, volenti o nolenti, hanno preso parte alla tragica vicenda.
2.
I PRIMI INDIZI

Fotogramma dell’agguato di via Fani
Il film costruisce il suo inizio con due elementi fondamentali: il sequestro di Via Fani e il Memoriale Moro. Si tratta di due aspetti estremamente importanti che, a livello narrativo, servono a ricostruire le circostanze storiche della vicenda Moro e di cui, ancora oggi, persiste un’imbarazzante ambiguità sulla loro dinamica. Sono i primi due “indizi” dell’indagine che il film si propone.
Il giornalista fiorentino Marcello Coppetti ricorda come lo stesso Licio Gelli, il capo venerabile della Loggia P2, facesse riferimento ad un filmino relativo al sequestro Moro: «loro erano abituati a filmare tutto, l’avranno anche filmato quando l’hanno ucciso, io credo. Non credo che lui si aspettasse di morire, almeno così mi hanno detto»[13]. Lo stesso Willan cita Flaminio Piccoli il quale aveva osservato la scomparsa della “pizza” delle riprese televisive a circuito chiuso che avrebbero registrato ogni attimo delle giornate del sequestro, «tale patrimonio è in possesso di non più di due o tre persone che lo renderanno pubblico, si presume, quando lo riterranno, per loro, più politicamente opportuno»[14].
Tale materiale, secondo quanto scrive Il Borghese (17 febbraio 1985) sarebbe stato recuperato in un baule durante l’arresto del terrorista Giovanni Senzani[15]. Forse i servizi segreti ne ebbero una prima visione onde farne un numero di copie. Il giornale ipotizza tre soluzioni: 1. i servizi decidono di tenere il film nei loro archivi senza informare il governo dandone una copia ai servizi di un paese alleato (CIA?); 2. i servizi mostrano il film ad un “personaggio” importante che lo mostra alla corrente politica e ai suoi dirigenti i quali decidono di nasconderlo; 3. i servizi informano l’ufficio della Presidenza del Consiglio della scoperta, e il video è tenuto nascosto come segreto di stato[16]. A presumere tale circostanza è anche lo stesso ex-brigatista Bonisoli durante l’intervista con Sergio Zavoli[17]. Bonisoli ricorda che tutti gli attimi della prigionia di Moro venivano filmati da una «telecamera a circuito chiuso», ma non da un «videoregistratore». Si è parlato anche del nastro magnetico con la voce di Moro, anche questo mai trovato[18]. Adriano Sofri cita la possibile esistenza del film che ritrarrebbe Moro durante la prigionia e dichiara «che i documenti dell’impresa contro Moro siano stati distrutti “per ragioni di sicurezza” è difficile da credere, per il feticismo brigatista di allora…»[19]. Tuttavia, ancora oggi non è dato sapere a chi siano state consegnate le presunte bobine audio e video. Il silenzio di Moretti, come ricorda Flamigni, non fa che ostacolare la ricerca di una verità giudiziaria e storica fondamentale. Tuttavia nessuna di queste testimonianze comproverebbe l’esistenza reale del filmato relativo al sequestro del 16 marzo.
Per la realizzazione del film, il regista Martinelli è stato colto da una circostanza simile e in particolare dalla frase sibillina di Gelli relativa al «rapimento del secolo» il quale molto probabilmente era stato filmato dalle stesse Br[20]. Questa ipotesi non fa che avvalorare la soluzione narrativa adottata dal regista, ovvero la messa in scena del rapimento di Moro come documento oggettivo e reale, realmente esistito. Le immagini sono lì presenti e colpiscono tanto il giudice quanto lo stesso pubblico che si sente violentemente catapultato nella tenebrosa atmosfera di via Fani e nella feroce esecuzione: gli eventi visivi, in questo senso, vengono percepiti come veri, come il reale resoconto di quel giorno. Tale funzione narrativa viene descritta eccellentemente da Lotman, attraverso la sovrapposizione di due codici: il livello cinematografico (quello della sala in cui si trova il pubblico o quello della finzione) e il livello filmico (quello della proiezione del super8 di via Fani). Questo fatto fa percepire come “vita reale” o “non-finzione” le immagini della strage proprio perché lo stesso personaggio della storia, il giudice Rosario, guarda quelle immagini proiettate sul muro della sua abitazione. Si tratta della rappresentazione all’interno della stessa rappresentazione, il cinema nel cinema, “lo scherno nello schermo”, per cui lo spettatore è indotto a percepire tutto il filmato del sequestro Moro come realmente accaduto[21].
Tutto il film si baserà sul “ritrovamento” di questo filmato e sull’indagine che i tre protagonisti, il giudice Rosario, la sua assistente Fernanda Doni e il caposcorta Branco, effettuano nelle diverse circostanze del racconto. Questo materiale visivo, inteso come documento storico all’interno della narrazione si basa soprattutto sullo studio di questo filmato, tanto da poter dire che il film Piazza delle cinque lune nasce e si costruisce su questa idea “estetica” particolarmente forte.
Il secondo elemento riguarda il misterioso Memoriale Moro di cui si hanno ufficialmente due versioni. Si tratta di analizzare le misteriose rivelazioni che Moro fece ai suoi carcerieri durante l’interrogatorio del “popolo”. Il primo Memoriale venne ritrovato in via Montenevoso a Milano nel 1 ottobre del 1978; il secondo verrà ritrovato nello stesso luogo il 9 ottobre del 1990[22]. Colpisce la strana coincidenza, due memoriali ritrovati nello stesso luogo a distanza di 12 anni: responsabilità dei carabinieri o manovra politica (?), «un muro alzato a regola d’arte», ricorda Sofri proprio mentre ne cadeva un altro, quello di Berlino. Si parlò, ma senza prove, di una consegna da parte del generale Alberto dalla Chiesa al ministro Andreotti.
L’elemento più importante riguarderebbe la differenza esistente tra i due memoriali. Nel secondo Memoriale risaltano le parti mancanti: sono evidenziati chiaramente i paragrafi relativi a Gladio (la segretissima struttura militare pronta per un intervento armato contro una probabile invasione dell’Unione Sovietica), i rapporti Andreotti-Sindona (i cosiddetti «pranzi americani» a cui seguiva l’esplicito disappunto di Moro) e i finanziamenti degli Stati Uniti diretti alla corrente democristiana attraverso la Cia [23].
Ovviamente i due “indizi” summenzionati non entrano in scena in modo autonomo, ma sono incastrati nella struttura narrativa attraverso la vicenda del giudice Saracini. Il film è dunque iniziato quando il giudice viene assalito fuori la sua abitazione: «non si tratta di una rapina […] voglio solo che dia un’occhiata a questo», dice l’aggressore che gli consegna un misterioso microfilm[24]. Rosario tenta una prima visione manuale, ma senza riuscire a distinguere gli elementi all’interno del fotogramma. La scena passa immediatamente alla proiezione del Super8, dove prendono forma le immagini della strage del 16 marzo 1978 (ancora una volta l’inquadratura dall’alto). Lo straordinario documento cinematografico ricostruito da Martinelli (in realtà girato in 16mm e in seguito rielaborato in postproduzione digitale) ripropone con particolare minuzia i particolari di quel tragico giorno: la macchina bianca dietro a quella della scorta, l’assalto da sinistra, un altro terrorista che attacca la scorta da destra, la presenza di un misterioso uomo con l’impermeabile e tutta la dinamica del prelevamento di Moro.
L’argomento centrale del film è dunque Aldo Moro[25] e la sua apertura al partito comunista di Enrico Berlinguer, iniziata sin dal 1964 attraverso la conciliazione con il partito socialista. Dietro la genesi di un nuovo corso politico che va sotto il nome di Solidarietà Nazionale, i gruppi eversivi di sinistra vedono la minaccia del Potere “imperialista”. Per l’estrema sinistra rivoluzionaria, Moro è il nemico del “popolo” e del progresso sociale di tutto il proletariato. Moro è bersaglio della rivoluzione comunista: «dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il "teorico" e lo "stratega" indiscusso di quel regime democristiano che da trent'anni opprime il popolo italiano», per i brigatisti Moro è il fautore della «controrivoluzione», artefice delle politiche «sanguinarie» degli anni ’50, «il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste». E nel secondo comunicato si legge «chi meglio di Aldo Moro potrebbe rappresentare come capo del SIM (Stati Imperialisti delle Multinazionali, ndr) gli interessi della borghesia imperialista? Chi meglio di lui potrebbe realizzare le modifiche istituzionali necessarie alla completa ristrutturazione dello SIM? La sua carriera però non comincia oggi: la sua presenza, a volte palese a volte strisciante»[26].
Al momento del sequestro Moro non era certo un politico particolarmente popolare, osserva Willan, poiché rappresentava trent’anni di governi corrotti e incapaci, guidati da un partito criticato. Moro era in oltre definito mister omissis per i suoi numerosi segreti di Stato imposti ai rapporti sugli abusi dei servizi segreti e per le dubbie attività dei compagni di partito per lo scandalo Lockheed. Le attività finanziarie del partito non l’avevano arricchito, poiché egli era effettivamente interessato più al bene pubblico che all’ottenimento del potere fine a se stesso[27]. La sua politica di mediazione lo fece salire al centro della politica italiana da divenire il principale obiettivo dell’eversione rossa e, contemporaneamente, politico poco gradito dalle correnti atlantiche.
Se l’argomento centrale del racconto è Aldo Moro, il film pone al centro della scena la storia di un giudice che in un altro tempo e in un altro spazio viene a contatto con il caso Moro. Il racconto è filtrato da un contesto narrativo “estraneo” alla peculiarità del caso Moro e per questo tutti gli elementi che entrano in contatto sono “indiretti” a differenza, per esempio, del film di Ferrara che tratta specificatamente il rapimento Moro dall’inizio alla fine, con tanto di nomi e cognomi seguendo una precisa ricostruzione temporale. Tuttavia il racconto di Martinelli finisce per avere una forte valenza “storica” proprio perché i protagonisti storici della vicenda sono ancora oggi presenti sulla scena giudiziaria e istituzionale del paese. Di fronte ad un evidenza così prorompente, come la strage di via Fani, si presenta il problema principale, lo scopo narrativo, del giudice Saracini. Attraverso il suo “problema”, si gettano le basi per l’intreccio della narrazione: se lo scopo del personaggio sarà quello di indagare sul misterioso filmato, lo scopo della narrazione sarà quello di analizzare tutti i misteri esistenti nell’affaire.
La formalità e il rigore che seguono nella scena del discorso commemorativo, fanno da contrasto allo stato d’animo del giudice. In tal senso le sue parole sembrano essere ancora più “vuote” e distanti da quel potere che fino all’ultimo giorno aveva servito, un potere che probabilmente nasconde ancora molti misteri. Sono parole che rivelano un presagio sinistro e oscuro: «oggi entro, ufficialmente nella categoria dei pensionati», un mondo, sembra dire il giudice, insidioso e pericoloso in cui si è soli. La citazione del poeta russo Joseph Brodsky, non è soltanto una semplice affermazione di copione; e non è soltanto funzionale alla struttura del racconto: la ricerca della verità e la necessità della passione sono l’espressione più vitale e civile della partecipazione al mondo e rappresentano un dichiarato “testamento spirituale” del regista: «solo il cercando la verità, solo comunicando la verità si dà senso alla propria esistenza»[28]. Tale discorso, inizia il percorso investigativo del giudice, e avvia definitivamente l’indagine del film.
L’ulteriore incontro con il misterioso aggressore, ha la funzione di chiarire gli obiettivi di questo secondo personaggio. Egli si identifica come ex-brigatista che prese parte alla strage di via Fani (dietro alla moto Honda) che a causa di un tumore giunto allo stadio terminale ha deciso di consegnare il filmino al giudice[29]. L’ex terrorista si fa portavoce di un importantissimo indizio relativo al Memoriale di cui sono state dette molte «bugie» e in cui «i punti cruciali non si conoscono ancora». In sostanza, attraverso il personaggio brigatista, di cui il pubblico non vedrà mai il volto, il racconto rivela che esisterebbe una versione intergale e originale del Memoriale Moro. Qui nasce una sorta di rapporto dialettico tra realtà e finzione. Il filmato e il Memoriale sono chiaramente due elementi narrativi, di fiction, ma finiscono per essere percepiti come elementi storici e reali. La loro presenza determina la narrazione, genera il racconto del film (finzione) e produce l’indagine sul caso Moro (analisi storiografica). È la caratteristica tematica del film, il quale nasce e si sviluppa su elementi immaginari, trattando al tempo stesso la storia reale di Moro. Su tale costruzione fa leva la verosimiglianza dell’opera. Da questo punto prende avvio la parte del film in cui si analizzerà la dinamica del sequestro di via Fani, in cui emergeranno alcuni elementi giudiziari delicatissimi che non si limiterebbero soltanto alla finzione del racconto.
3.
LA VISIONE DEL SUPER8
Una delle caratteristiche narrative del film è quella di trattare gli elementi giudiziari del caso Moro attraverso l’ausilio di un filmato completamente inventato per il racconto. Da questo confronto, tra la realtà oggettiva del caso e la fiction narrativa, emerge il valore tematico del film. La forza del racconto è offerta da un filmato di finzione che riesce a descrivere con esattezza storica gli eventi del sequestro Moro, senza modificare o alterare la presunta veridicità dei fatti. La realizzazione del filmato, costituisce un fondamentale esempio di costruzione “filologica” della strage di via Fani, da divenire la fonte principale non soltanto del racconto, ma anche della detection proposta dal film. Gli elementi evidenziati in questa prima parte sono tre: il mancato tamponamento, l’uccisione di Leonardi attraverso un misterioso quinto uomo e la misteriosa presenza di un superkiller.
La visione del filmato debutta con la descrizione di quella mattina del 16 marzo 1978. I vari indizi, oltre ad essere chiaramente visibili sullo schermo, sono evidenziati dal commento del giudice Saracini, Fernanda Doni e il caposcorta Branco. La scelta formale del regista è quella di supportare il linguaggio visivo del filmato con quello verbale, permettendo di far emergere più chiaramente gli elementi indiziari[30]. Rosario fa notare una Fiat 128 familiare, con targa diplomatica posteggiata all’angolo di via Stresa, guidata dal capo brigatista Mario Moretti[31]. Quando la Fiat 130 di Moro arriva da via Trionfale verso Via Fani insieme alla Alfa della scorta, una moto Honda li supera, dando così il segnale a Moretti[32]. Quest’ultimo fa marcia indietro parcheggiando la sua auto a circa 30 metri dello stop di Via Fani. Vedendo poi arrivare la Fiat 130 di Moro, riesce dal parcheggio ostacolando il suo arrivo. La prima novità emerge proprio in questa circostanza. La versione ufficiale dei fatti, riferita da Morucci, riferisce che la macchina di Moro fu costretta a tamponare quella di Moretti. Ma il filmato mostra una circostanza assai diversa: la macchina di Moro non tampona affatto quella di Moretti, ma si ferma poco prima, costretta dagli spari provenienti dal lato destro della strada. Durante la loro deposizione[33] (osserva il personaggio di Fernanada) Moretti e Morucci avevano dichiarato una dinamica completamente differente: il primo aveva affermato che lo scontro con la macchina di Moro era stato violento e che egli aveva dovuto tirare il «freno a mano» per fermare l’avanzata della macchina[34]; il secondo aveva affermato che il tamponamento era ripetuto[35]. Il filmato mostra inequivocabilmente che le due macchine si erano appena sfiorate (circa 20 cm), senza «nessun graffio […] nessun segno di frenata sull’asfalto», come osserva Rosario. Se ne deduce che rallentarono e poi si fermarono senza toccarsi. La forza semantica della scena, la descrizione minuziosa dei diversi momenti, rappresenta il punto più alto del film e forse il più riuscito. Le immagini sembrano uscite dalla cronaca di quei giorni per divenire storia. I gesti e le azioni raccontano con estrema precisione quelle drammatiche circostanze. Il filmato sembra essere, al di la della finzione scenica, un documento di altissimo valore storico. Ma questo avviene anche per la rigorosa costruzione dell’agguato, basato su un precisa documentazione e sulla logica consequenzialità degli eventi. La forza estetica del filmato è quindi supportata da una ragione filologica fondamentale[36].
Morucci dichiarerà di essere stato il quinto uomo sul lato destro della strada, quello che doveva colpire mortalmente il maresciallo Leonardi. In quello stesso frangente, un gruppo di quattro brigatisti, posti sul lato sinistro della strada, avrebbero avuto il compito di eliminare la scorta. Fu questo fatto a causare il tamponamento. Ma il film mostra un'altra dinamica, e non lo fa attraverso un atto deliberato e parziale, ma attraverso la stessa fenomenologia dell’evento[37]. Il regista conosce bene questa circostanza. L’uccisione di Leonardi sarebbe avvenuta in un tempo incomprensibilmente lungo, in cui il maresciallo sarebbe stato seduto ad osservare l’impatto: da questo si deluciderebbe già una strana dinamica balistica che forse si riferisce agli stessi attentatori. La 128 di Moretti, frena bruscamente allo stop: seguirebbe l’ipotetico tamponamento della 130 di Moro e dell’Alfetta della scorta. Dalla 128 sarebbero scesi due brigatisti, mentre quasi contemporaneamente, dal lato sinistro della colonna sarebbero giunti altri quattro terroristi preposti all’eliminazione di tutta la scorta. L’unico a reagire sarà Iozzino che, infatti, verrà trovato ucciso con 17 colpi sull’asfalto. E in tutto questo tempo, cosa fa il maresciallo Leonardi? Ricorda Martinelli: «lo stunt che è seduto nella posizione del maresciallo Leonardi, mi blocca l’azione… Renzo, ma io che ci faccio qui? Me ne sto seduto ad aspettare che quelli mi arrivino addosso?». Si tratta di una perplessità scenica che riflette quella della dinamica e lascia pensare sulle veridicità delle versioni. Probabilmente l’evento traumatico che avrebbe bloccato Leonardi in quella posizione non è l’impatto tra le macchine (falso) ma qualcos’altro. Leonardi venne ucciso da destra e quindi c’era un quinto sparatore oltre ai quattro di sinistra, un killer solitario. Leonardi viene trovato in una posizione rilassata e serena, come mostra la foto scattata dopo l’attentato, come se stesse parlando con Ricci. Il capo scorta sarebbe stato ucciso senza accorgersi di cosa stesse succedendo. Sei pallottole lo colpiscono dietro la schiena, provenienti dalla destra da uno sparatore che ha saputo muoversi in perfetto sincrono con l’incidente. Subito dopo, due pallottole avrebbero colpito il petto di Leonardi. Soltanto attraverso questa dinamica è stato possibile giare la scena: volendo anche seguire la versione di Moretti o di Morucci, sarebbe stato impossibile. Da questo punto di vista, la costruzione della scena, assumerebbe il valore di una perizia giudiziaria senza precedenti[38]. Si tratta di un caso formidabile in cui l’impegno civile dell’arte cinematografica si concilia con quello della verità storica: è l’esempio in cui il cinema, come immagine movimento può intervenire nella realtà sociale per rappresentare il suo più alto contributo etico ed estetico. La costruzione della scena costringe il film, per forza di cose, ad ipotizzare un'altra dinamica dell’evento e per questo scorge senza imbarazzo brigatisti e istituzioni dietro una versione troppo spesso superficiale[39].
Dopo l’eliminazione di Leonardi, il quinto uomo si toglie dall’azione per dare la possibilità agli altri quattro terroristi di continuare l’assalto. Ed è in questo punto del film che emerge il secondo indizio: il misterioso superkiller[40]. Il personaggio di Fernanda ricorda che secondo le deposizioni, il misterioso killer sarebbe giunto in via Fani insieme a Moretti. Qui si sarebbe appartato con gli altri tre brigatisti, sul lato sinistro della strada. Dopo l’esecuzione di Leonardi da parte di Morucci, sarebbe entrato in azione. Il commento del giudice descrive la perizia balistica. I bossoli ritrovati dimostrano che il lavoro militare fu di «alta specializzazione»: i brigatisti spararono da punti contrapposti e soltanto un brigatista, sembrerebbe, ne uscì ferito. Il gruppo riesce ad uccidere la scorta, senza colpire Moro pur essendo da mezzo metro dal maresciallo Leonardi[41]. Saracini osserva che in via Fani furono sparati 93 colpi in soli 90 secondi provenienti da sette armi diverse. I colpi furono soprattutto dei brigatisti. Soltanto 20 furono quelli della scorta mentre 49 colpi, andati tutti a segno, furono sparati da un arma unica, una pistola mitra calibro 9 Parabellum Stern o forse FNA 1943, appartenente al misterioso superkiller. Il teste Pietro Lalli, benzinaio di via Fani, esperto di armi, descrive l’agguato e la tecnica di questo superkiller con “autentica ammirazione”. Il terrorista spara con un’arma a recupero di gas, ha la mano guantata sulla canna per evitare i sobbalzi e colpisce con precisione: la prima raffica contro Leonardi e Ricci, poi un salto indietro per allargare il raggio di tiro e sparare contro l’Alfetta di scorta: «la professionalità criminale dell’attentatore è talmente elevata, a giudizio degli stessi periti, da non potersi ragionevolmente inquadrare in nessuna delle figure dei brigatisti noti»[42]. Rispetto a questo superkiller gli altri brigatisti fanno ben poco: sparano 4 colpi con un arma, 5 con un'altra, 3 con quella di Raffaele Fiore, 8 con la Smith & Wesson poi sequestrata a Prospero Gallinari. In tutto sei armi. Il racconto introduce le testimonianze oculari del tragico giorno e, naturalmente, lo fa secondo un criterio oggettivo e storico senza alterare la veridicità dei fatti. Pietro Lalli, racconta delle «raffiche complete contro la Fiat 132». Alessandro Marini, l’ingegnere civile in motorino viene addirittura bloccato da una mitragliata dall’uomo dietro la moto Honda. Egli vede Moro salire in macchina con un andamento passivo, dimesso e soprattutto illeso. Luca Moschini studente di medicina a bordo di una Fiat 500 vede la moto Honda e due uomini in divisa. Quella mattina era presente anche l’agente di polizia del settimo reparto celere di Roma, Giovanni Intrevato che vede distintamente il prelevamento di Moro.
Per raccontare la scena, il film adotta un montaggio alternato tra la ricostruzione delle testimonianze e la fiction degli eventi descritti. Tale commistione di tempi e spazi diversi, che il cinema conosce come flashback, sono potenziati dallo stile “sporco” e mosso della macchina da presa. Le inquadrature sembrano rubate da un archivio storico. Tuttavia il film evita di trattare l’identità del superkiller in maniera dettagliata e precisa.
Uno stranissimo elemento, non inserito nel film, costituisce un importane indizio. Questo si riferisce ai proiettili dell’agguato coperti da una speciale vernice impermeabile, adatta alla conservazione di munizioni in nascondigli sotterranei e normalmente in dotazione alle forze speciali[43]. Questo elemento, se provato, dimostrerebbe la possibilità di un’oscura strategia tra Moro e i suoi sequestratori e la possibilità di un intervento straniero o comunque estraneo al contesto rivoluzionario del partito armato[44].
In sede processuale emerge, poi, un'altra ipotesi inquietante: l’eliminazione di Leonardi sarebbe avvenuta non soltanto per l’attacco improvviso sul quel lato, ma anche perché nel commando terrorista vi sarebbe stato qualcuno che egli conosceva. Questo fatto, evidenziato dall’avvocato di parte civile della famiglia Moro, non è però trattato dal film, per ragioni prettamente narrative[45]. Tuttavia il resoconto di Rosario ricorda l’azione di questo brigatista il cui obiettivo è stato principalmente quello di eliminare l’autista e il maresciallo Leonardi: «lo fredda e si defila». A partire da questo elemento, il film inizia un’operazione investigativa che non collima con la versione ufficiale. Lo spettatore è colto dal dubbio: alcuni indizi discreditano le versioni dei brigatisti a tal punto che «le diverse verità potrebbero voler nascondere la partecipazione al blitz di uomini diversi dai brigatisti comunemente intesi»[46].

Foto originale, inserita nel film, relativa al mancato tamponamento tra la Fiat 130 di Moro e la Fiat 128 di Moretti.
4.
VIA FANI: INDIZI E MISTERI
Dopo aver trattato la dinamica del tamponamento, il film continua la sua indagine giudiziaria. Attraverso il dialogo incalzante del giudice Saracini e di Fernanda, il racconto fa emergere i nodi cruciali dell’eccidio di via Fani. Questi si possono riassumere in quattro punti fondamentali, non ancora chiarite dalle stesse indagini: le borse di Moro; la strage violenta e deliberatamente “spettacolare”; l’organizzazione del sequestro; il colpo di grazia alla scorta.
Il giudice Saracini ricorda che Moro possedeva cinque borse: una conteneva documenti riservati; una seconda, medicinali ed effetti personali; le altre tre contenevano articoli di giornali e tesi di laurea (Moro era professore di Diritto Penale). Come facevano i brigatisti a sapere quali erano le borse giuste, ammesso che siano stati loro ad effettuare il prelevamento? Durante la deposizione in Commissione, Eleonora Moro aveva dichiarato; «loro (i brigatisti [N.d.R.]) dovevano sapere quali e dove stavano nella macchina perché c’era una bella costellazione di borse, messe così, così e così, prendere a colpo sicuro quella…»[47]. Tuttavia Eleonora ricorda che quella mattina quando arrivò in via Fani si accorse che la borsa da cui Moro non si staccava mai era stata prelevata (se ne accorge attraverso il rivestimento pulito della automobile quando tutt’intorno era macchiato dal sangue delle vittime)[48].
Due borse, la ventiquattrore e una borsa diplomatica, saranno poi consegnate nelle mani dell’agente di pubblica sicurezza Otello Riccioni (uno degli autisti della scorta che quel giorno era in ferie). Riccioni a sua volta le consegnò alla signora Moro. Una terza borsa piena di libri viene ritrovata cinque giorni dopo nel baule della Fiat di Moro all’interno della questura. Un fatto piuttosto inquietante che rivela in ultima analisi le modalità di indagine in via Fani. Borsa “insignificante”, ma estremamente importante per comprendere quale giro strano avesse fatto, se di questo si è mai trattato.
In Commissione Parlamentare il mistero delle borse occuperà gran parte dei dibattimenti. Secondo le testimonianze, emerse che i brigatisti ne presero soltanto due: quella personale e quella con i documenti riservati. Dentro quest’ultima si sa di certo che contenesse una nota dello stesso Moro sulla crisi di governo, una nota sull’ordine pubblico, una nota sul terrorismo e una delicata relazione sul coordinamento tra polizia e carabinieri. Forse vi era quel documento sui collegamenti dei servizi dell’interno della NATO[49]. Dichiarerà il generale Dalla Chiesa: «io penso che ci sia qualcuno che possa avere recepito tutto questo… dobbiamo pensare anche ai viaggi all’estero che faceva questa gente, Moretti andava e veniva…»[50].
Il film di Giuseppe Ferrara, Il caso Moro, racconta tale episodio attraverso l’appropriamento della borsa da parte di un misterioso funzionario dei servizi segreti, che si scoprirà in seguito un esponente della Loggia Massonica P2. E’ in questa circostanza che la signora Moro inizia un colloquio piuttosto teso con il militare[51]. Si tratta della trascrizione del vero dialogo, relativo alla mattina del 18 marzo 1978, che Eleonora Moro depone in Commissione[52]. Il generale Dalla Chiesa avrebbe affermato che la strage e il sequestro sarebbero state opera delle Brigate Rosse.
Qui emergerebbe un altro elemento: Moro non era a conoscenza del “destino” di quelle borse: «bisognerebbe cercare di raccogliere le 5 borse che erano in macchina»[53], scrive nella quarta lettera a sua moglie; ovviamente ignorava che le valigette erano nelle mani dei suoi sequestratori[54]; nella lettera a Rana (suo segretario) scrive: «sono state recuperate delle borse in macchina? O sono sequestrate come corpo di reato?». Una curiosità viene dall’intervista a Bonisoli nel documentario televisivo di Zavoli: egli non sa chi ha preso le borse, «forse la colonna romana», afferma. La storia delle borse di Moro e del loro contenuto rimane quindi avvolta nel mistero, tanto nel film, quanto nella storia ufficiale del caso Moro.
L’altro mistero riguarda la modalità della “strage” che lascia pensare, senza ombra di dubbio, ad un episodio che vuole far parlare di se. Il personaggio di Fernanda si domanda perché è stato realizzato un colpo così spettacolare, quando vi sarebbe stata la possibilità di fare tutto più tranquillamente allo Stadio dei Marmi, dove Moro era solito fermarsi per fare una passeggiata insieme al maresciallo Leonardi. Il personaggio di Fernanda, con questa sua osservazione finisce per divenire una sorta di alter ego della vedova Moro che riguardo alla strage di via Fani affermò: «mi sono chiesta infinite volte perché li abbiano uccisi tutti, quando mio marito potevano prenderlo tranquillamente in altri posti… questa è una delle cose che la Commissione la scopre, secondo me scoprirà una grossa parte della verità»[55].
Le Br erano sicure del percorso che avrebbe fatto la scorta (si tratta di un ulteriore indizio di Fernanda) che il giorno prima erano andati in via Brunetti a tagliare le gomme di un furgoncino, di proprietà di un fioraio, che ogni mattina parcheggiava tra via Fani e via Stresa e che di fatto avrebbe costituito un ostacolo per le manovre di attacco delle Br. Anche questo episodio è raccontato nel film di Ferrara. Secondo le testimonianze dei brigatisti il giorno prescelto per il sequestro non fu affatto previsto con precisione: un «giorno probabile» affermò Morucci, una «coincidenza» dichiarò Moretti, «casuale» disse Bonisoli[56].
L’ultima osservazione di Fernanda riguarda il colpo di grazia inferto agli uomini della scorta che ripropone in maniera drammatica la necessità di eliminare ogni prova e ogni testimonianza di quel tragico giorno e, al tempo stesso, dimostrare la violenza e la determinazione di quell’atto “politico”. Nessuno doveva rimanere in vita perché nessuno doveva raccontare cosa fosse accaduto quella mattina. Si tratta di un’ipotesi portata avanti dal racconto.
Nel numero del 2 maggio, Mino Pecorelli[57] dava una chiara allusione al sequestro Moro. L’articolo era intitolato «Yalta in via Mario Fani» e analizzava il sequestro: «[…] l’agguato di via Fani porta il segno di un lucido superpotere. La cattura di Moro rappresenta una delle più grosse operazioni politiche […] L’obiettivo primario è senz’altro quello di allontanare il Partito Comunista dall’area del potere nel momento in cui si accinge all’ultimo balzo, alla diretta partecipazione al governo del Paese. È un fatto che si vuole che ciò non accada. Perché è comune interesse delle due superpotenze mondiali modificare l’ascesa del Pci, cioè del leader dell’eurocomunismo, del comunismo che aspira a diventare democratico e democraticamente guidare un Paese industriale»[58]. Il giornalista continuava affermando che la partecipazione governativa del Pci sarebbe stata «ancor meno gradita ai sovietici […] la dimostrazione storica che un comunismo democratico può arrivare al potere grazie al consenso popolare, rappresenterebbe non soltanto il crollo del primato ideologico del Pcus sulla Terza Internazionale, ma la fine dello stesso sistema imperialista moscovita»[59]. Si tratta in sostanza della logica di Yalta, la logica di guerra e di potere che decise il destino della politica italiana e le sorti di Aldo Moro[60].
Nello stesso numero di OP, ma in un diverso articolo dal titolo «E anche Renato Curcio fa il suo dovere», Pecorelli affermava: «i rapitori di Aldo Moro non hanno nulla a che spartire con Brigate rosse comunemente note. Curcio e compagni non hanno nulla a che fare con il grande fatto politico-tecnicistico del sequestro Moro». In tal senso Pecorelli prospettava un allargamento dell’affaire Moro. Nell’articolo del 12 settembre 1978, dopo aver ricordato l’interesse di Washington e Mosca nel porre fine all’eurocomunismo, scrive: «per essere sicuri che le Br hanno agito per conto di terzi, italiani o stranieri, italiani e stranieri»[61]. L’abilità comunicativa di Pecorelli, i codici linguistici e giochi verbali, attribuiscono al giornalista una profonda forza storica. Egli era in grado di predire fatti e avvenimenti grazie al suo inserimento nei centri nevralgici del potere e dello spionaggio. Si tratta del punto di vista del film, che insiste sull’aspetto segreto e internazionale della guerra di cui sarebbe stato vittima Moro.
Alle quattro evidenze, si aggiungerebbe quella della divisa di avieri che si ricollega alla presenza del superkiller[62]: si sarebbe trattato di un modalità di riconoscimento utile agli stessi brigatisti. Ma forse, tra loro, vi era qualcuno che non li conosceva personalmente e questo espediente avrebbe rappresentato un ottimo sistema di identificazione. Attraverso questa ipotesi, il film riprende il tema del superkiller. Egli sarebbe giunto a via Fani con la macchina di Mario Moretti, avrebbe attraversato la strada, e sarebbe andato verso il bar Olivetti, per incontrare il resto del comando, riconoscibili poiché tutti vestiti da avieri. Questo comportamento presume che il misterioso personaggio, che spara da solo 49 colpi, non conoscesse affatto il comando terrorista. E’ in tale circostanza, implicherebbe, secondo il persongaggio di Branco, la possibilità che si trattasse di un «professionista» assoldato dalle Br. Con la divisa di avieri sarebbe stato più facile essere avvistati e riconosciuti.
La testimonianza del giornalista Ernesto Viglione, depositata agli atti della Commissione Parlamentare, evidenzia la possibilità di gruppi militari presenti quella mattina in via Fani. Egli aveva contattato le Br per intervistare Aldo Moro durante la sua prigionia. Un anonimo brigatista gli avrebbe confidato che tutta la vicenda Moro sarebbe stata guidata «da due parlamentari e da una persona legata al Vaticano»[63]e che in via Fani vi avrebbero partecipato uomini dei carabinieri e della polizia[64]. Tale indizio, tuttavia, è apparso debole e ricco di lacune.
Un elemento importantissimo, non raccontato nel film, è rappresentato da una testimonianza diretta. La giornalista Cristina Rossi occupata presso l’Asca (agenzia stampa Dc) aveva scattato delle foto dalla finestra del suo appartamento sito in via Fani 109: «il 18 marzo consegnai al giudice Infelisi, nel suo ufficio a piazzale Clodio, il rollino dei negativi che il 16 marzo mio marito [Gherardo Nucci N.d.T.] aveva scattato pochi minuti dopo il tragico fatto… la cosa gli era stata possibile abitando proprio nel palazzo di fronte al quale viene consumato l’eccidio… ritenni che i sette-otto fotogrammi riguardanti la vicenda, uno in particolare avrebbe potuto essere di qualche utilità per le indagini: infatti, sebbene nel fotogramma si vedesse che già sul posto si trovava un’autovettura di PS… vi era un capannello di una decina di persone tra le quali gli inquirenti avrebbero potuto individuare la presenza di qualche terrorista nella eventualità che questi, invece di allontanarti, si fosse mischiato tra i primi curiosi»[65]. La giornalista affermò che il giudice Infelisi tagliò con una lametta i fotogrammi interessati, ma in futuro quei stessi fotogrammi sparirono. Il giudice fece sapere che i negativi erano stati «riconsegnati alla proprietaria», quando lei stessa non avrebbe saputo più niente. Quelle foto scompariranno misteriosamente e il tutto fu reso più complicato da strane incomprensioni tra la Rossi, il dottor Infelisi e il capo delle Digos Spinella che aveva convocato la testimone il 26 maggio 1978. Willan ricorda che quelle foto vennero ingrandite per identificare i primi passanti e di come, probabilmente, si finì per identificare qualche personaggio scomodo. Un’intercettazione telefonica, trascritta da Willan, datata il 1 maggio del 1978, tra Benito Cazora e Sereno Freato evidenzierebbe la presenza di un presunto uomo “scomodo”[66]. Dalla telefonata traspare la preoccupazione di certi ambienti malavitosi calabresi per quelle foto. Forse avrebbero potuto portare gli inquirenti su di un sentiero piuttosto pericoloso sia per gli stessi ambienti calabresi, sia per la precisa ricomposizione dello scenario di quella tragica mattina. Tuttavia, per quanto riguarda questo episodio, il film non ne fa accenno. Come si vedrà il coinvolgimento della malavita nel sequestro Moro avverrà, con il personaggio piuttosto ambiguo di Antonio Chichiarelli.
5.
PEDINAMENTI E MINACCE FUORI DAL FILM
L’inseguimento costituisce un elemento narrativo e cinematografico di altissima tensione. Attraverso la costruzione tecnica dell’inseguimento, il cinema classico ha prodotto un vero e proprio tema narrativo che va sotto il nome di thriller. Si tratta di uno schema narrativo che ha delle regole precise. In primo luogo, l’inseguimento o pedinamento, inteso come azione fisica e narrativa, deve essere realizzato da almeno due personaggi in chiaro antagonismo. In secondo luogo, questi stessi personaggi, o esistenti, debbono essere plasmati dalla forma del discorso o se si preferisce dall’estetica stessa: un montaggio serrato e veloce, inquadrature strette e rapide. In terzo luogo, deve emergere il senso di paura e di tensione psicologica degli stessi personaggi. Questa costruzione è finalizzata alla suspense. Si tratta di un momento peculiare del racconto filmico, in cui si concentra l’intreccio narrativo e costringe lo stesso spettatore ad una maggiore attenzione. Da questo momento emotivo dipende il destino stesso dei personaggi e di tutto il racconto.
Tale costruzione è presente anche nel film di Martinelli, a livello di racconto filmico, ovvero attraverso il rapporto che si stabilisce tra il punto di vista dei personaggi (soggettivo) e quello della macchina da presa (oggettivo del narratore). Ma gran parte degli eventi raccontati dal film, l’inseguimento in metropolitana, l’inquadratura all’interno del garage, la scena dell’attacco aereo, costituiscono un fatto narrativo ed esclusivamente di finzione: sono gli eventi che costringono il racconto verso una determinata direzione e portano i personaggi verso un determinato destino. Questa impostazione è data anche dal trattamento particolare che la vicenda storica di Moro subisce in ambito narrativo, per il solo fatto di dover essere raccontata. Ed è proprio per questo motivo che molti eventi storici non possono essere inseriti nel film.
La vicenda di Moro è costellata da eventi particolarmente inquietanti, che tuttavia non sono inseriti nel film, ma che potrebbero evidenziare maggiormente alcune circostanze storiche molto gravi. Si tratta di certi episodi, precedenti al sequestro di via Fani, che descrivono il clima teso di quei giorni e offrono una chiara descrizione del contesto politico in cui si sarebbe trovato Moro
Una serie di strani episodi costringono Moro a ipotizzare di essere pedinato. Lo statista era stato particolarmente impressionato per il sequestro del figlio dell’ex segretario del Partito socialista, Francesco De Martino nell’aprile 1977, da temere il peggio per i suoi stessi figli. Secondo la vedova Leonardi, il marito era stato particolarmente in ansia durante il periodo precedente il 16 marzo a causa di un’informativa che segnalava la presenza di elementi brigatisti a Roma provenienti da paesi stranieri[67]. La cosa sconcertante, affermò Leonardi ad Eleonora Moro, è che gli stessi organi di polizia avevano avuto l’ordine di non occuparsi di questa cosa e di lasciare stare. Questo fatto costituisce un primo indizio storico.
Particolarmente grave è il caso della richiesta della macchina blindata. L’istanza risulta agli atti ufficiali e indicherebbe che lo stesso Sismi avrebbe consegnato la domanda al ministro dell’interno Cossiga. Scarano – De Luca scrivono che questi avrebbe negato di aver mai ricevuto una tale richiesta direttamente da Moro come invece sembra sostenere Eleonora. Tuttavia la scorta e lo stesso Moro non ebbero mai una risposta e, cosa molto più importante, non ebbero mai una macchina blindata[68]. Particolarmente significativi furono gli eventi accaduti in Via Savoia 86, la strada in cui c’era lo studio di Moro dove lo stesso Moretti avrebbe acquistato delle armi. La porta dello studio di Moro venne forzata mentre la sua macchina venne manomessa almeno una decina di volte. Ma anche in questo caso, le indagini non aprirono nessuna pista rilevante.
Due vicende, non ancora chiarite, descriverebbero la situazione di tensione che avrebbe caratterizzato l’atmosfera in quella via. Si tratta del caso Franco Di Bella e del caso Francesco Moreno.
Nel novembre del 1977, Francesco Di Bella, direttore del Corriere della Sera, si era recato in via Savoia per un appuntamento con Moro. Alla sua macchina (una Fiat 125) improvvisamente si affiancarono due motociclisti armati. Leonardi denunciò il fatto. Il 15 marzo 1978, Spinella, capo della polizia, fece sapere che i motociclisti erano soltanto dei «volgari scippatori». Ma forse, la formulazione è troppo sicura: due scippatori in via Savoia che attirano l’attenzione della scorta di Moro e del giornalista Francesco Di Bella, indicherebbe, in qualche modo, una circostanza che andava quanto meno approfondita. L’evento è fatto passare senza particolari provvedimenti.
Secondo il lavoro di Scarano - De Luca, il caso Moreno è un elemento assai inquietante a causa di strani collegamenti legati al soggetto. Gli inquilini dello stabile avevano notano per più giorni una Bmw sostare troppo a lungo davanti allo studio di Moro. Dopo la segnalazione, si apre un’indagine e si scopre che il giovanotto a bordo è Francesco Moreno. Si tratta di un individuo misterioso, in contatto con i servizi segreti libanesi, imputato nel 1973 per spionaggio politico, vicino agli ambienti dell’estremismo di destra (in particolare con la Società Radiofonica dove sembra si producessero informazioni a scopo spionistico, frequentata da un certo Schuller «ex nazista in rapporti stretti con servizi tedeschi e svizzeri, ma soprattutto arabi»)[69]. Il suo contatto con il caso Moro avviene anche per una strana coincidenza. Scarano – De Luca affermano che la sirena, destinata all'auto di Moreno, era del tipo di quella usata da un'auto che partecipò al rapimento Moro[70]. Tuttavia una delle due è risultata acquistata soltanto nella mattina del 16 marzo 1978. Osserva De Luca: «in via Savoia non sembra che Francesco Moreno stesse per controllare Moro, ma proprio i brigatisti che controllavano Moro. Per contro di chi?»[71]. Si tratta di un ipotesi particolarmente grave, che è, tuttavia, in sintonia con il racconto filmico.
Alcuni elementi indiziari avevano in qualche modo anticipato l’eccidio che si sarebbe compiuto in via Fani[72].
Il primo riguarda un rapporto (6 marzo 1978) che giunge al Sismi da parte della Securpena, la struttura che gestisce la supervisione delle carceri: «comunicare subito che ci sarà un altro attentato, a grossa personalità di Roma»[73]. Ma obiettivamente rappresenta soltanto un indizio e per di più molto vago. Santovito, allora capo del Sismi si pronunciò argomentando le vie burocratiche: «la legge 108 stabilisce che noi Servizi informazioni arriviamo fino a un certo punto… una volta prodotta l’informazione e data all’organo operativo non possiamo nemmeno domandare che cosa ne fanno di questa informazioni»[74]. Un'altra informazione venne dal carcere di Matera da un certo Salvatore Senatore (16 febbraio 1978): «è possibile il rapimento di Moro»[75]. La velina viene passata al Sisde e li si ferma. Un altra informativa giunse da Silvano Maestrello, un informatore già conosciuto dai servizi, che venne ucciso il 12 maggio del 1978 durante una rapina a Venezia. Anche in questo caso il Sismi accolse l’informativa senza dare origine ad azioni preventive ed investigative[76]. Questi eventi sono di fatto indicativi per l’atmosfera che circolava intorno alla sorte di Aldo Moro. Ma gli elementi non si esauriscono qui. Particolarmente sinistre erano state le dichiarazioni raccolte da un’assistente, Giuseppe Eusebi presso la facoltà di filosofia a Roma, testimone di un dialogo tra due studenti: «hai messo tu la bomba all’Università?». La risposta: «queste cose io non le faccio, tanto rapiremo Moro»[77]. Giuseppe Marchi, altro testimone, sente in una piazza di Siena, un dialogo, con forte accento straniero tra due individui che dichiarano di aver rapito Moro e la sua scorta (siamo nel 18 marzo). Gian Gustavo D’Emilia, studente di 17 anni, dice ai compagni della scuola romana Merry Del Val: “oggi sequestriamo Moro e ammazziamo la scorta”, una confidenza che viene fatta prima dell’attacco terrorista[78]. Dunque, tante informative, molti nomi e testimonianze dirette che citano il nome di Moro. Ma nessuno che voglia ascoltare: «davvero troppi sapevano per non pensare a una lunga, inerte attesa, rispetto a un fatto che “doveva” accadere», scrivono gli autori Scarano e De Luca[79].
Il caso più eclatante si ha con la trasmissione radiofonica in diretta su Radio Città futura la mattina del 18 marzo. Renzo Rossellini parlerà in trasmissione della preparazione di un attentato e di una delle sue possibili vittime tra cui Aldo Moro. Quarantacinque minuti dopo, Moro veniva rapito. Si parlò di «supposizione metafisica», ma in seguito lo stesso Rossellini affermò che si era trattato di un ipotesi più che probabile: «noi sapevamo che il 16 marzo doveva presentarsi alle Camere il primo governo sostenuto dal Pci… Era evidente per noi che questa era l'occasione sognata dai brigatisti»[80]. L’ipotesi circolava già da tempo nei circoli dell’estrema sinistra, dichiarò in seguito Rossellini. Egli ricorre ad un elemento prettamente induttivo. Il Sismi, che solitamente registrava tutte le trasmissioni, dichiarò attraverso il suo generale Santovito che dall’archivio mancava proprio quella mezz’ora in cui Rossellini avrebbe fatto quella dichiarazione. Il nastro poi risulterà tagliato[81].
La presenza di strane convergenze è dato direttamente da un evento che il film mette nelle parole di Branco. Si tratta di un elemento storico evidenziato da un personaggio di finzione. Durante la visione del Super8, il capo scorta osserva: «c’è qualcosa che non avete notato […] il tipo con l’impermeabile non si muove e si limita ad osservare». È un elemento fondamentale del caso Moro che si ricollega con la presenza dei servizi segreti durante la mattina del 16 marzo.
Il nome dell’uomo, come rivelerà la scena seguente, è Camillo Guglielmi, colonnello dei servizi segreti, appartenente alle rete clandestina della Nato, responsabile dell’addestramento e della preparazione dei “gladiatori”. Anche in questo caso il film si riferisce alla riscostruzione giudiziaria di quel giorno. Nella Relazione della Commissione Parlamentare si legge che la presenza in via Fani di un colonnello del Sismi, Camillo Guglielmi, «non ha mai ricevuto una accettabile spiegazione […] il Guglielmi riferì di aver ricevuto un invito a pranzo presso un collega; quest'ultimo confermò di averne ricevuto la visita, ma non la circostanza dell'invito a pranzo, che comunque non avrebbe potuto giustificare la presenza del Guglielmi in via Fani alle nove del mattino»[82]. Tutti questi elementi costituiscono nell’insieme una sorta di disegno eversivo che probabilmente poteva essere debellato sul nascere. Tuttavia, soltanto a posteriori di questi eventi si riesce a comprendere il filo rosso che avrebbe descritto il progetto di destabilizzazione: l’eliminazione della politica di Moro che inevitabilmente sarebbe coincisa con l’eliminazione fisica dello stesso statista.
La presenza di un colonnello del Sismi, dopo i pedinamenti avvenuti in via Savoia, i strani passaggi del Moreno, i misteriosi “scippatori”, costituiscono una complessa struttura di rapporti strani e non ancora chiariti. Spie, poliziotti, servizi segreti e militari costituiscono la colonna portante dell’enigma Moro e contribuiscono ad ispessire il segreto. Ad aumentare il senso di mistero, contribuisce la figura di Antonio Chichiarelli, un personaggio appartenente alla malavita romana, che Martinelli decide di inserire nella scena seguente. Si tratta di un affiancamento non soltanto narrativo, ma molto probabilmente anche allusivo, riferito alle strane alleanze che avrebbero favorito il tragico destino di Moro.
6.
ANTONIO CHICHIARELLI
All’interno del sequestro Moro esiste un giorno, forse il più problematico di tutti, che costrinse le parti in causa, investigatori e brigatisti a confrontarsi con alcuni eventi particolari e piuttosto ambigui. Si tratta del 18 aprile, anniversario trentennale della Democrazia Cristiana, giorno in cui venne scoperto il covo di via Gradoli e consegnato il settimo comunicato dei brigatisti, poi risultato falso. Il compito narrativo del film è quello di analizzare la strana traccia che si era delineata in quel giorno e lo fa attraverso la figura misteriosa di Antonio Chichiarelli, oscuro manipolatore, falsario della banda della Magliana. Si tratta di un punto nevralgico della narrazione, in cui il regista tenta di analizzare le collusioni che avrebbero caratterizzato la perpetuazione del sequestro Moro, attraverso linguaggi criptati, molto spesso in codice e oscuri personaggi non meglio definiti.
La scoperta del covo di via Gradoli avviene in maniera piuttosto strana da mettere in dubbio la stessa verosimiglianza dell’evento. Uno sciacquone difettoso avrebbe causato l’intervento dei pompieri e quindi delle forze dell’ordine. Quando la polizia entrò nell’appartamento, trovò in bella mostra una serie di documenti scottanti[83]. Perché i brigatisti avrebbero commesso una tale ingenuità? È possibile che Moretti e Balzerani abbiano trascurato così superficialmente un guasto nel loro appartamento, rischiando di far saltare il sequestro di Moro?[84]
Si tratta di domande legittime che secondo alcuni giornalisti, i cosiddetti dietrologi, e secondo lo stesso Martinelli, troverebbero una risposta soltanto in un contesto più complesso. L’ipotesi accreditata è quella del messaggio in codice. È possibile che i servizi segreti abbiano “bruciato” il covo per permettere di recuperare alcune carte di Moro legate ai segreti Nato (P2, Gladio) e forse sulla stessa rete italiana del Kgb[85]. L’operazione sarebbe stata fatta in modo particolarmente evidente da permettere a Moretti e alla Balzerani di essere informati da radio e televisione e continuare così il loro sequestro, ma in modo sempre vigilato. In questo modo i brigatisti sarebbero stati avvertiti: possiamo prendervi quando vogliamo[86]. In questa prospettiva il falso comunicato, quello del lago della Duchessa, è servito a creare un potente diversivo per catalizzare l’attenzione sulla prigionia di Moro, piuttosto che sulla scoperta del covo di via Gradoli. L’autore del comunicato è Antonio Chichiarelli, personaggio ambiguo, falsario, pittore, il quale sembra occupare un ruolo di mediazione tra servizi segreti e malavita romana. Secondo Willan, Chichiarelli conosce e frequenta Luciano Del Bello (informatore del Sisde) ed è in possesso di numerose informazioni relative al sequestro Moro, all’omicidio Pecorelli e del sottufficiale dei carabinieri Antonio Varisco[87]. Come racconta il film, fu Chichiarelli a scrivere il settimo falso comunicato. Chi aveva commissionato il falso comunicato a Chichiarelli? Gladio? I servizi segreti? E perché? Sono le domande che offrono la pista investigativa del film.
Attraverso le parole di Fernanda, il racconto inizia la sua indagine. Fernanda ricorda che ad un giorno di distanza dall’omicidio Pecorelli, Chichiarelli “dimentica” su di un taxi un misterioso borsello. Questo conteneva una Beretta 9 mm, una serie di documenti, alcuni oggetti collegati alla vicenda di Aldo Moro da suggerire strane complicità tra servizi militari e civili. Probabilmente si trattava di un messaggio criptato, rivolto a chi poteva comprendere: undici proiettili calibro 7.65 e uno di calibro maggiore, una testina ruotante Ibm simile a quella usata dalle Br per scrivere i loro comunicati (light Italia numero 12), un portachiavi con nove chiavi (possibile riferimento ai possibili terroristi che avevano collaborato all’agguato), due flash Silvania (due come le Polaroid scattate durante la prigionia), un pacchetto di tovagliolini di carta Palma (tipo per tamponare le ferite del prigioniero), e tre piccole pillole bianche, forse un’allusione alle medicine di Moro[88]. Il film descrive direttamente questi elementi e relaziona tutti gli oggetti con il caso Moro. I documenti della borsa includevano dieci pagine dell’elenco telefonico di Roma riguardanti alcuni ministeri governativi, in cui comparivano messaggi in codice, simili a quelli usati dalle Br per il comunicato consegnato a Roma il 20 marzo 1978. In oltre, vi erano quattro documenti che trattavano un piano d’attacco a personaggi di rilievo (Pietro Ingrao, il figlio del magistrato romano Achille Gallucci, l’avvocato milanese Giuseppe Prisco). Sorprende l’appunto sulla morte di Pecorelli in cui si leggeva, “da eliminare”, con data martedì 6 marzo 1979, con alcune indicazioni di depistaggio. Probabilmente lo scopo del messaggio era quello di collegare l’omicidio di Pecorelli con quello di Moro suggerendo che lo stesso Pecorelli era in possesso di documenti riservatissimi. In questa circostanza compare un ulteriore indizio che fornisce il titolo alla storia. Si tratta del messaggio che descriveva il rinvio dell’omicidio di Pecorelli, causa «intrattenimento prolungato», presso Piazza delle Cinque Lune. Qui, il 6 marzo del 1979, come racconta il film, Pecorelli avrebbe partecipato ad un incontro segreto con alcuni esponenti del servizio segreto militare, il colonnello Antonio Varisco ed un altro altissimo carabiniere, probabilmente il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre fuori dall’edificio, alcuni killer avrebbero atteso la sua uscita. Ma il delitto venne rinviato per fine marzo, anche perché, come si legge nei documenti lasciati da Chichiarelli, «sarebbe problematico concedergli tempo»[89].
Dunque, la piazza rappresenta un passaggio obbligato nella vicenda di Pecorelli, di Varisco e inevitabilmente di Moro. Pecorelli doveva incontrare i servizi segreti. Ma chi aveva commissionato l’attentato? I stessi servizi segreti che Pecorelli stava incontrando? Probabilmente no. Il film precisa che Pecorelli voleva incontrare il conoscente Antonio Varisco, colonnello dei carabinieri, l’uomo che il 16 marzo 1978 aveva avvisato i servizi di sicurezza di cercare una Renault 4 rossa. Egli venne ucciso il 13 luglio 1979 per mano delle Br, ma la scelta dell’arma, un fucile a canne mozze, lascia pensare ad un esecuzione di tipo mafiosa. Uno dei colleghi di Varisco, il capitano Antonio Straullu, fece una fine analoga per mano dei Nar e anche lui aveva affermato, di saperne abbastanza per far saltare il “palazzo”[90]. Molto probabilmente gli attentatori non erano soltanto legati ad un “semplice” gruppo malavitoso. Il film ricorda che fu lo stesso Pecorelli ad aver collegato il falso comunicato del Lago della Duchessa con la scoperta del covo di via Gradoli. E per queste sue “rivelazioni” aveva probabilmente infastidito più di qualche “potere forte”, appunto la loggia di Gelli. E in questi termini si spiegherebbe l’eliminazione del colonnello Varisco. Tutti questi cadaveri eccellenti, sono legati da un unico destino: il legame con il Memoriale di Moro.
Inizialmente, attraverso alcuni articoli sibillini, Pecorelli aveva il compito di scoraggiare la politica di Moro. Per questo motivo, quasi sempre, il nome del segretario della Dc veniva associato a quella di “morte”. Osserva Willan: «è possibile che la cosa facesse parte di un piano orchestrato dalla P2 per mettere Moro sotto pressione e forzarlo ad abbandonare il suo programma politico»[91]. In seguito Pecorelli assume un comportamento contraddittorio, di allontanamento dagli ambienti dei servizi segreti e dalla stessa P2. La posizione di Pecorelli si fa ambigua: da uomo facente parte del presunto complotto (iscritto alla P2, amico di militari, politici e alta finanza), sembra improvvisamente chiamarsi fuori da questo coinvolgimento. È questo comportamento, il tentativo di trattare le sue informazioni con i servizi segreti e altri gruppi occulti, che sancisce la sua condanna. Nel numero del 18 marzo 1977 di OP, scrive una lettera indirizzata a Gelli per informarlo della sua intenzione di dimettersi dalla P2[92]. Una decisione che sembra derivare dalle difficoltà economiche del giornalista. Da questo momento in poi la figura di Pecorelli sembra divenire particolarmente fastidiosa per la stessa Loggia. Negli articoli di OP, la struttura di Gelli è descritta come macchinosa, misteriosa, pericolosa e potente. In un articolo datato una settimana prima della sua morte, Pecorelli scriveva: «attentati, stragi, tentativi di golpe, l’ombra della massoneria ha aleggiato dappertutto: da piazza Fontana al delitto Occorsio, dal golpe Borghese all’Anonima sequestri, alla fuga di Sindona dall’Italia». Si tratta dell’ultimo articolo di Pecorelli, in cui aveva promesso importanti notizie sul caso Moro. Tre giorni dopo, proprio quando doveva incontrare Gelli, come era appuntato nella sua agenda, Pecorelli veniva eliminato (20 marzo 1979). Sotto il suo ufficio in via Tacito, nel quartiere Prati, Pecorelli è colpito in bocca: «la punizione mafiosa per chi aveva parlato troppo»[93]. Tra gli appunti trovati sul taxi c’erano dei paragrafi relativi ai segreti Nato (il film cita i paragrafi 162, 168, 174 e 177) che corrispondevano alle pagine mancanti del Memoriale Moro in possesso di Pecorelli il giorno della sua morte. Con questa spiegazione il film collega inequivocabilmente l’uccisione di Pecorelli al sequestro Moro, e lo fa attraverso quegli indizi che Chichiarelli avrebbe intenzionalmente lasciato sul taxi. Questa informazione finisce per essere un indizio piuttosto compromettente per i presunti personaggi che avrebbero preso parte all’affaire Moro.
Gli eventi descritti dal film, che corrispondono perfettamente al livello delle indagini fatte fino ad oggi, finiscono per descrivere il gruppo brigatista in maniera misteriosa e complessa. Ed è la strada scelta dal racconto, la domanda assillante che percorre tutto il film. Osservano Scarano e De Luca: «la strage di Via Fani, il sequestro di Aldo Moro e infine l’assassinio sono stati “gestiti” a più mani. Sotto il drappo con la stella a cinque punte, accanto alla folta e più forte componente terroristica, si sono nascosti i maneggi e gli interventi di altre due componenti ugualmente aggressive: quella di una delinquenza organizzata tipo camorra e mafia, e quella più occulta di spezzoni di vecchi servizi segreti»[94]. Da questo punto di vista, la figura di Chichiarelli fungerebbe da collante tra la legalità e l’illegalità, in una situazione in cui non si è mai chiarita del tutto la relazione esistente tra i diversi elementi dei servizi segreti e alcuni esponenti della malavita organizzata.
Il film prosegue con un ulteriore evento che riguarda la biografia di Chichiarelli e che sembra apparentemente sganciato dall’affaire Moro. Si tratta della rapina Brinks Securmark, il 23 marzo 1984, dove sono lasciati, ancora una volta, alcuni oggetti che alludono ad un messaggio in codice. La sua funzione, come si potrà osservare, è quella di chiudere il cerchio e dare un senso preciso alla presenza di Chichiarelli all’interno del caso Moro. I rapitori, identificati come brigatisti, prelevano dall’edificio 35 miliardi di lire. Prima di legare le guardie, i terroristi enfatizzarono l’aspetto politico e rivoluzionario del loro gesto, fotografando una delle guardie davanti una bandiera rossa con la famosa stella a cinque punte. I rapitori abbandonarono un certo numero di oggetti di chiaro significato simbolico: una granata fumogena Energa (riferimento all’omicidio Varisco), sette proiettili Nato calibro 7.62, sette piccole catene e sette chiavi. Le chiavi e le catene vennero poi interpretate come riferimento al rapimento di Moro. Il giudice Saracini afferma che il ricorrente numero sette rimanda al falso comunicato del lago della Duchessa. Le granate erano di provenienza americana ed erano state originariamente conservate, secondo quanto scrive Willan, da Egidio Giuliano nel deposito del ministero della Sanità. Afferma Willan che le armi erano servite per l’operazione “Terrore sui treni” come depistaggio per la strage di Bologna[95]. L’abbandono delle grantate Energa avrebbe rappresentato una sorta di linguaggio cifrato: sappiamo chi ha ucciso Varisco e perché. Un ulteriore elemento, un documento politico redatto dal vertice delle Br, chiarisce la relazione con i terroristi.
Come afferma il personaggio di Fernanda, la mente della rapina è Antonio Chichiarelli, che dopo aver scritto il falso comunicato, e aver lasciato del materiale scottante in un taxi, riappare attraverso una rapina, lasciando strani indizi, quasi un’intimidazione a chi gli aveva garantito la libertà. Il film sostiene la tesi dello scambio: la rapina, consistente e molto facile, sarebbe stata una ricompensa per il lavoro svolto fino a quel giorno. Ma pochi mesi dopo la rapina, come ricorda il giudice Saracini, un killer munito di pistola con silenziatore uccide Chichiarelli. È il 28 settembre 1984. E’ l’ennesimo cadavere eccellente che articola l’affaire Moro e lo ammanta di un ulteriore mistero.
A collegare il caso Moro a quello di Chichiarelli esistono altri elementi che per motivi di narrazione il film non può raccontare. Willan ricorda che il 25 marzo Pecorelli avrebbe telefonato a Il Messaggero comunicando che in un cestino di piazza Gioacchino Belli, lo stesso luogo del falso comunicato numero 7, si troverebbero alcuni proiettili dello stesso calibro usato per la rapina della Brinks. Vi era, in oltre, un documento definito “allarmante”: c’era il riferimento alla presenza finanziaria di Sindona nella banca Brinks, cosa che non era affatto di pubblico dominio. Chiunque si addossasse la responsabilità della rapina del 1984 era indubbiamente l’autore del comunicato in codice del 1978 o gli era molto vicino[96]. Tra i documenti ritrovati in piazza Belli c’erano anche gli originali dei rapporti su Pecorelli, Gallucci e Ingrao, lasciati da Chichiarelli nel taxi. Il film non si sofferma, però, su un ipotesi inquietante: Chichiarelli aveva spedito sempre a Il Messaggero due frammenti originali di Polaroid fatte risalire alle due foto fatte a Moro durante la sua prigionia. Ne consegue che Chichiarelli, o qualcuno molto vicino, era venuto in contatto con la prigionia di Moro[97]. Si tratta di un fatto gravissimo: un membro della malavita romana in contatto con i servizi segreti si sarebbe introdotto nella prigione di Moro mentre questi era ancora vivo; dal che si deduce che i servizi segreti conoscevano l’ubicazione della prigione di Moro (e Pecorelli l’aveva detto) ma anche, nonostante questo, non avevano fatto nulla per assicurarne il rilascio.
È un’ipotesi inquietante che si collega nuovamente agli oggetti lasciati sul taxi. Il primo elemento riguarda la patente intestata a Luciano Grossetti priva di foto che probabilmente, secondo Willan, si riferiva all’informatore Luciano Del Bello. Il secondo riguarda un biglietto per Messina (Villa San Giovanni), che indicherebbe una possibile relazione con il mondo mafioso siciliano e che si riferirebbe alla presenza dei carabinieri nell’affaire Moro[98].
Con questa manovra, Chichiarelli sembra voler evidenziare tutta il lavoro svolto da Pecorelli. Anche Chichiarelli sembra spinto da una volontà “strana”: quella di svelare i collegamenti già descritti dal giornalista. Ma il suo vero obiettivo non sembra essere molto chiaro e forse, anche per questo, sarà eliminato in circostanze misteriose.
La morte di Chichiarelli, il falso comunicato e l’episodio della borsa finiscono per assumere, come sottolinea lo stesso giudice, un chiaro significato collusivo: la rapina di Chichiarelli era la ricompensa che i servizi segreti, legati agli interessi della P2, avevano offerto allo stesso falsario per la collaborazione al settimo comunicato. L’evento collusivo spiega, per tanto, la complicata alleanza che si era creata dietro l’affaire, dove servizi segreti e criminalità sembrano convergere sull’obiettivo di eliminare in ogni modo la presenza “politica” di Moro. Dunque il film, trattando il personaggio di Chichiarelli, costruisce un'altra pista indiziaria che si affianca al caso Moro e allude alle possibili collusioni: sono coinvolti Pecorelli, Varisco, Chichiarelli stesso, servizi segreti deviati e gruppi potenti e oscuri che fanno gli interessi di qualcosa che nel film ancora non si capisce chiaramente[99]. Fino a questo punto lo scopo del racconto filmico è quello di sollevare quanti più dubbi sulle versione ufficiale del sequestro Moro. E’ soltanto in questo momento che il film inizia ad affrontare il motivo del suo racconto, ovvero fornisce una prima spiegazione del suo titolo Piazza delle Cinque Lune. La Piazza è il luogo che spiegherebbe le strane alleanze che avrebbero dato origine all’eliminazione di Moro, che spiegherebbe la collusione tra terroristi, servizi segreti deviati e gruppi internazionali: le “cinque lune” possono assurgere al valore simbolico della vicenda di Moro, incastonata in una sorta di zona grigia che ancora oggi, malgrado i cinque processi, rimarrebbe misteriosa e irrisolta.
Attraverso l’inserimento di immagini brevi e verosimili (il bianco e nero dei Super8) e la descrizione di elementi indiziari riservati e compromettenti per la politica nazionale e internazionale, il film minaccia la fruizione passiva dello spettatore, portandolo ad un coinvolgimento emotivo e razionale. Rispetto alla struttura narrativa di Rosi, o ancora di Oliver Stone (si pensi a JKF) il film mantiene le unità di luogo e di tempo, concedendosi brevi flashback di forte impatto percettivo e storico, senza lasciare il “presente storico” dove si svolgono le indagini. I due livelli del film, l’indagine degli esistenti e l’affaire Moro, finiscono per sovrapporsi da dare l’illusione di un unico tempo storico. In realtà di tratta di due momenti ben distinti, sia per quanto concerne la collocazione temporale degli eventi, e sia per quello che concerne la costruzione estetica dei vari momenti. Tuttavia questa sovrapposizione di tempi diversi, può giustamente considerarsi un unico tempo narrativo, in quanto sono tematicamente legati al tema dell’indagine. Probabilmente è quello che intende Deleuze, quando tratta l’argomento “tempo”: si scopre un tempo interno all’avvenimento, fatto di simultaneità di tre tempi, passato, presente e futuro, contemporanei, e dunque «arrotolati», «simultanei», «inesplicabili». La narrazione consisterebbe, da questo punto di vista, nel distribuire i differenti presenti a seconda delle circostanze. Tuttavia, il film di Martinelli non costituisce una narrazione particolarmente destrutturata per quanto concerne l’ordine del tempo, come invece avviene nel film Salvatore Giuliano di Francesco Rosi o in JFK di Oliver Stone[100].
7.
INDAGINI E MASSONERIA
Dopo la prima indagine sul caso Moro scaturita dalla visione del Super8, il racconto punta l’attenzione sui protagonisti, Rosario, Branco e Fernanda. Qualcuno li sta spiando. La scena della metropolitana di Milano informa chiaramente che i personaggi sono al centro di un misterioso pedinamento. La conferma viene dallo stesso Branco che attraverso il vecchio trucco del cerino, incastrato nella portiera della macchina, scopre che qualcuno è stato li. Qualcuno ha aperto la macchina. Le immagini in bianco e nero fanno da contrappunto alla scena nel garage: l’inquadratura riprende gli stessi personaggi, ma cambia la qualità e il punto di vista di chi osserva. Se prima era il racconto del film a mostrarci il loro movimento, adesso è un punto di vista diverso, estraneo all’oggettività narrativa della macchina da presa. Quel punto di vista sembra indicare la presenza di un altro esistente, di un altro personaggio, che il racconto non ha ancora presentato. Il movimento “sporco” dell’inquadratura contiene una sorta di terzo senso[101], è offre un ulteriore significato semantico: è il punto di vista di qualcuno che sta spiando i tre personaggi, che li controlla in ogni piccola mossa.
Questo evento ha due significati narrativi: il primo, evidentemente, è di ordine informativo, cioè dice che qualcuno o qualcosa sta controllando le azioni del procuratore (brigatisti? servizi segreti? malavita?). Il secondo è di ordine prettamente narrativo in quanto tende a rafforzare l’intreccio del racconto: attraverso queste misteriose minacce, il film “ri-attualizza” il clima che aveva caratterizzato il caso Moro. Il “potere” è dunque sempre in agguato, intollerante e spietato. Chiunque ha che fare con il caso Moro, come ricordano le parole di Fernanda, è inevitabilmente coinvolto in un gioco molto più grande che sembra non avere scrupoli sull’incolumità delle persone e delle rispettive famiglie. È proprio questo tipo di intreccio che rafforza l’ipotesi del “complotto” contro Moro e quindi contro chi tenta di indagare sullo stesso affaire. Da questo punto di vista il tempo storico sembra non essere trascorso: il potere è costantemente presente, onnisciente, determinato, spietato, come racconta lo stesso film. La morte del marito di Fernanda, che il film racconta attraverso un “incidente” creato a regola d’arte, mostra l’estrema conseguenza di questo potere: uccide le persone, distrugge le famiglie, sopprime la società civile[102].
La scena della recita risorgimentale, impersonata dai figli di Fernanda, assume un valore simbolico. La bandiera dell’Italia che copre il corpo caduto del soldato oltre ad essere un evento narrativo, la recita scolastica appunto, è anche una rappresentazione simbolica di tutto quello che coinvolge il caso Moro. Durante la recita, Rosario viene raggiunto da un nuovo messaggio dall’anonimo terrorista (si tratta del quarto contatto all’interno del film): «controllate i rogiti di via Gradoli 96». L’espressione indica chiaramente la mancanza di chiarezza sul covo brigatista sito in via Gradoli. Il biglietto provoca una furibonda reazione di Fernanda, la quale inizialmente si scaglia contro Rosario nel tentativo di dissuaderlo da questa folle indagine, ma subito dopo è lei stessa che si immerge nei fascicoli del caso Moro. Tale costruzione del personaggio è senza dubbio contraddittoria. Se la sua funzione narrativa è quella di alimentare la “paura” che aleggia intorno alle indagini, che di fatto si tradurranno con la perdita del marito, e pur vero che l’integrità del personaggio, la sua costruzione, è poco chiara e sostanzialmente ambigua. Fernanda preme affinché la famiglia debba restare fuori, ma poi si lascia trasportare dal vortice delle indagini ed è lei stessa a conoscere l’esito delle indagini e dei vari processi. Da un punto di vista diegetico, il suo scopo narrativo è particolarmente debole o, comunque, subisce un’evoluzione che resta un tantino forzata.
Il messaggio ricevuto dal giudice Saracini durante la recita
La scoperta del presunto covo di via Gradoli 96 (scala A interno 11), nella zona nord di Roma, costituisce uno degli elementi più misteriosi del caso Moro in cui si può intravedere una sorta di “collusione” tra malavita, brigatisti e servizi segreti. Il covo, come ho accennato nel paragrafo precedente, viene scoperto durante la prigionia di Aldo Moro, esattamente il 18 aprile: la data coincide con il trentesimo anniversario della democrazia cristiana e con la diffusione del settimo “falso” comunicato[103]. Il film evidenzia che nella stessa via, al numero 89, sarebbe vissuto il sottufficiale dei carabinieri Arcangelo Montani, agente del Sismi e originario di Porto San Giorgio, luogo di nascita del capo brigatista Mario Moretti. Si tratta di una coincidenza significativa. Durante il sequestro Moro, l’agente Arcangelo Montani ufficialmente “non faceva parte del Sismi”, ma il 31 marzo 1978 lo stesso contrammiraglio Fulvio Martini (allora vice direttore del servizio segreto militare) era intervenuto a favore del Montani in seguito a un esposto presentato al comando dei carabinieri da alcuni inquilini del condominio di via Gradoli 89, i quali avrebbero lamentato di aver subito vessazioni da parte del sottufficiale. Si tratta di un primo elemento misterioso a cui seguiranno una serie di “indizi”. Attraverso uno scorcio veloce sul personaggio di Rosario, il film mostra una serie di nomi di società immobiliari di coperture del Sisde, presenti in via Gradoli ad incominciare dagli appartamenti della palazzina dove si trovava il covo. Le società sono l’immobiliare Gradoli, l’immobiliare Case Roma srl e l’immobiliare Monte Valle Verde srl[104]. Flamigni si chiede, come sia possibile che il Sisde, che aveva in locazione gli appartamenti accanto e di fronte al covo brigatista, non si sia accorto di niente. Come è possibile che il Sisde non abbia saputo della presenza dei brigatisti in una delle sue proprietà immobiliari?[105]
Questa parte del film è chiaramente ispirata al lavoro d’indagine del senatore Flamigni, il quale si è basato su due ricerche principali: «…1) ho voluto concentrare l’attenzione su uno degli aspetti principali del caso Moro, le vicende del covo di via Gradoli, da cui emerge che i nostri servizi segreti hanno controllato i brigatisti, ma li hanno lasciati agire indisturbati fino al 18 aprile 1978, quando hanno fatto scoprire il covo in concomitanza con il comunicato falso del lago della Duchessa. 2) Dato che alcune notizie pubblicate nel mio libro “Convergenze parallele” erano state contestate in particolare da Francesco Cossiga che aveva presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, ho voluto rendere noto che lo stesso Capo della Polizia, dott. Masone, ha ammesso la veridicità di quanto avevo scritto nel precedente libro Convergenze parallele a proposito dei legami con fiduciari del Servizio segreto civile di società immobiliari proprietarie di appartamenti in via Gradoli 96 (nello stesso palazzo dove vi era il covo delle Br), e a proposito del fatto che Vincenzo Parisi, già direttore del Sisde e capo della polizia, era proprietario di diversi appartamenti in via Gradoli»[106]. La tesi portata avanti dal film è quella della collusione tra servizi segreti, apparati della polizia e brigatisti: insieme, controllati da un’organizzazione per ora non meglio definita, avrebbero contribuito a determinare lo svolgimento degli eventi.
Rosario ricorda come il ministro degli interni Cossiga aveva istituito tre Comitati con una rapidità senza precedenti i quali, però, non produssero risultati determinanti. Questi furono il Comitato tecnico-operativo (presso il gabinetto del Ministero dell’Interno), il Comitato informativo (Sismi, Sisde, Cesis e Sios) e il Comitato “esperti”, di tipo informale composto da intellettuali, aggregato intorno al professor Vincenzo Cappelletti[107]. Il film non può “raccontare” ogni indizio giudiziario (non è il suo compito precipuo), ma tra le righe tenta di dare valore ad alcuni eventi. In effetti la questione relativa alla formazione e alla funzione dei Comitati è piuttosto recente: del Comitato di “esperti” si è avuta ufficialmente notizia solo il 15 maggio 1991, quando Francesco Cossiga, che lo istituì, ha deciso di renderlo noto, senza peraltro chiarirne fino in fondo, l’attività e le decisioni. Di questo gruppo parallelo facevano parte: Stephen Pieczenik del Dipartimento di Stato Usa e uomo di fiducia di Kissinger, e i professori Franco Ferracuti, Stefano Silvestri, Cappelletti, Conte Micheli, Dalbello, Mario D’Addio, Ermentini. Su questa struttura di consulenza, ha reso testimonianza uno degli appartenenti, Stefano Silvestri, ascoltato in Commissione Stragi nel giugno 1998. Secondo Silvestri non fu mai tenuta una riunione di questo organismo, ma ai singoli componenti venivano chiesti pareri su alcune questioni senza alcun coordinamento con strutture operative[108].
Il dato più importante riguarda il lavoro relativo al Comitato di esperti che risulterebbe, tutt’oggi, inesistente: mancherebbero i verbali e una precisa documentazione. La stessa Commissione ha concluso: «la mancanza dagli archivi del Viminale di tutta la documentazione concernente il periodo di prigionia dell’On. Moro e dei tentativi di liberarlo da parte delle forze dell’ordine non trova alcuna plausibile spiegazione». Le ipotesi in merito possono essere tre: «La soppressione dei documenti stessi, la loro sottrazione da parte di ignoti, ovvero il loro trasferimento dalla sede propria. Si conferma così una costante dell’affaire Moro: prove importanti sulla gestione della crisi sono state sottratte agli organi istituzionali, ma non è escluso che altri ne dispongano e le utilizzino, o minacci di farlo, nel momento più conveniente»[109].
L’elemento di spicco del Comitato “esperti” è senza dubbio Steve Pieczenik, fautore di una precisa linea strategica: occorreva dimostrare che Moro non era indispensabile alla vita del Governo e della nazione[110]. Per il comitato, Aldo Moro è affetto dalla sindrome di Stoccolma e quindi è inaffidabile. Tutto il contributo del consulente americano è quella di rafforzare la decisione del governo italiano a non negoziare la liberazione di Moro. Si tratta di una strategia che entra fortemente in relazione con la tesi portata avanti dal film di Martinelli.
Ad occuparsi del consulente americano è Pecorelli, nel suo ultimo articolo (16 gennaio 1979) intitolato Vergogna buffoni. Il giornalista minacciava di tornare in futuro su alcuni aspetti dell’oscura vicenda: «Parleremo di Steve R. Pieczenick vicesegretario di Stato al governo Usa, il quale, dopo aver partecipato per tre settimane alle riunioni di esperti al Viminale, ritornato in America prima che Moro venisse ucciso, ha riferito al Congresso che le disposizioni date da Cossiga in merito alla vicenda Moro erano quanto di meglio si potesse fare»[111]. Willan ricorda che la stessa presenza del consulente americano era stata tenuta nascosta alla stampa e perfino, come afferma Rosario, alla stessa ambasciata Americana. La sua presenza a Roma è dunque segretissima[112]. Se fosse vero, questo fatto proverebbe la particolare ambiguità del Comitato in cui faceva parte lo stesso Steve Pieczenik.
Ma non basta. Un altro comitato, quello tecnico operativo, dimostra strane incongruenze. Questo è composto dal Sismi, dal Sisde, dall’Ucigos, più i vertici dell’esercito e della marina. La struttura si rivelerà quasi subito impotente, perfino depistante: i verbali del 3 aprile, data che coincide con la presenza dell’amico americano di Cossiga e della nuova strategia relativa al sequestro Moro, spariranno misteriosamente[113].
Tutto il lavoro delle indagini è caratterizzato da un imponente sforzo investigativo basato sul movimento di mezzi logistici e posti di blocco. Come aveva osservato Sciascia, si aveva l’impressione di assistere ad una parata che voleva impressionare l’opinione pubblica. E si tratta di una tesi che il film sviluppa ulteriormente: tutte le indagini, secondo il giudice Saracini, sarebbero state manovrate da un misterioso gruppo di potere, la Loggia «ultrasegreta e clandestina» P2. La Loggia Massonica, come evidenzia il giudice, ebbe una funzione di collegamento tra l’esito delle indagini e il lavoro dei Comitati[114] con lo scopo di impedire la realizzazione della politica di Moro e «l’ingresso del partito comunista nel governo italiano». È la prima volta che un film italiano tratta in maniera approfondita la funzione specifica e strategica di questo gruppo massonico deviato.
Da questo momento in poi il film costruisce il caso Moro in relazione a questo gruppo di potere; per la prima volta nella storia del cinema fa il nome del suo capo e dei suoi appartenenti in relazione al caso Moro[115]. L’inserimento della P2 all’interno del film è quindi un evento importante anche da punto di vista strettamente narrativo. Giuseppe Ferrara aveva tentato l’inserimento della Loggia nel suo film con tanto di luogo fisico, un elegante salone dove gli affiliati si sarebbero riuniti (compreso l’uomo che avrebbe preso alcune valigie di Moro). Tuttavia il racconto di Ferrara rimane circoscritto in questo evento e non allarga l’indagine come invece fa il film di Martinelli. Lungi dal fare un confronto diegetico tra i due film, i quali se pur trattando lo stesso argomento sono film diversissimi, è doveroso osservare che Piazza delle cinque Lune è un racconto basato sull’ipotesi del complotto a partire dal compito che la stessa Loggia avrebbe perpetuato all’interno del caso Moro. Martinelli non esita a fare il nome del capo venerabile Licio Gelli compiendo un ulteriore passo verso il cinema cosiddetto impegnato, rompendo il muro di omertà e di autocensura che ha caratterizzato la cinematografia politica[116].
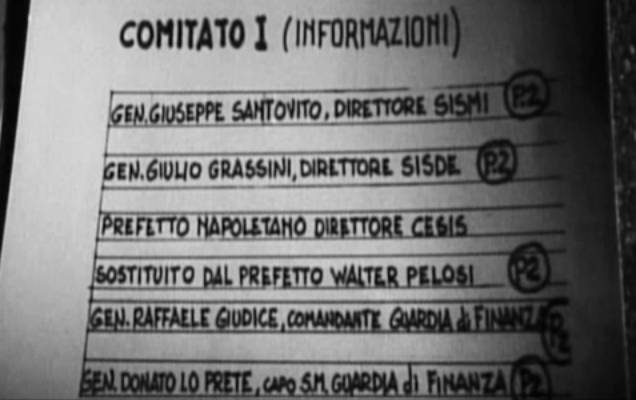
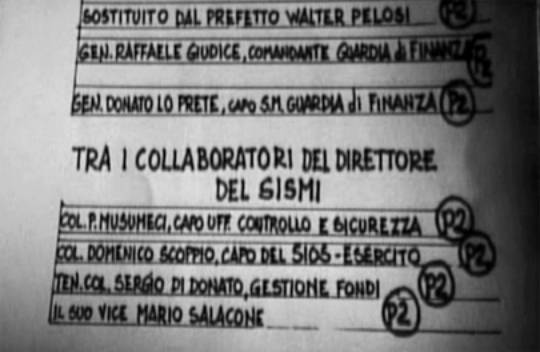
Fotogrammi relativi all’indagine compiuta dal persongaggio giudice Saracini
8.
VIA GRADOLI
Tutte le indagini portate avanti sembrano essere determinate da un potere che le gestisce, e al tempo stesso, ne impedisce lo sviluppo in senso definitivo. L’evento più indicativo, in questo senso, è il caso di via Gradoli, che costituisce uno dei punti fermi del racconto di Martinelli. La via nasconde molte contraddizioni. Una piccola via di città, sconosciuta, persa nella periferia nord di Roma, trova una collocazione “giudiziaria” che la pone al centro di un contesto internazionale complesso e delicato.
Le strane modalità di indagine avvenute in via Gradoli sono argomentate da Fernanda. Il 18 marzo del 1978, gli agenti di pubblica sicurezza erano già stati nella via senza conseguire risultati. Gli agenti del commissariato Flaminio capeggiati dal brigadiere Domenico Merola non apriranno la porta dove, in seguito, verrà scoperto uno dei covi delle Br. Fernanda evidenzia un fatto estremamente strano, un indizio inequivocabile. Si tratta della relazione firmata da Merola riguardo a quella perquisizione intestata su carta con il bollo Polizia di Stato. La nuova sigla, pero, è adottata con la riforma della pubblica sicurezza nel 1981. E’ una relazione “falsa” che mette in dubbio l’operato della polizia e delle perquisizioni. Il dirigente del commissariato, il dottor Costa, fornirà una versione dell’evento: la relazione era stata riscritta e fatta firmare al brigadiere Merola poiché l’originale era stato consegnato alla Corte. Per gli appartamenti non perquisiti lo stesso Costa affermerà che erano state prese «opportune informazioni» sugli inquilini occupanti[117].
Un ulteriore indizio viene dalla dichiarazione-denuncia di Lucia Mokbel datata 18 marzo, la quale sente provenire dall’appartamento in cui si sarebbe trovato il prigioniero Moro alcuni segnali morse, denuncia che consegnerà al suo amico vicequestore e funzionario del Sisde Elio Cioppa (P2) uno degli uomini del generale Giulio Grassini. In Corte d’Assise gli agenti sarebbero caduti dalle nuvole, e non avrebbero ricordato nessuna denuncia della Mokbel[118].
Altri fatti strani offrono uno spunto investigativo. Delle segnalazioni riguarderebbero alcune automobili viste passare nella via. Vengono annotate targhe automobilistiche e si pedinano persone come riporta un rapporto della Digos riscritto il 18 agosto 1978[119]. In particolare viene osservato un furgone Volkswagen targato Roma 589133 appartenente ad un certo Giulio del Petra, il quale si recherà in Calabria con il furgone stesso. In Calabria c’è nello stesso periodo (1975) anche Mario Moretti in circostanze mai chiarite. In una testimonianza di Enrico Triaca, si afferma che un furgone simile è utilizzato dalle Br per portare la stampatrice presso la tipografia in via Foa. Il numero di De Petra verrà trovato nell’agenda di Morucci. Ma tutto questo si scoprirà più tardi[120].
Un'altra informazione sul covo di via Gradoli era giunta anche dal parlamentare democristiano Benito Cazora in data 25 marzo 1978 da un misterioso emissario appartenente alla malavita calabrese di nome “Rocco”[121] Lo stesso Cazora afferma di essere stato portato sulla Cassia all’altezza dell’incrocio di via Gradoli dove gli sarebbe stato detto che questa era la “zona calda”. Cazora riportò immediatamente l’informazione al questore di Roma, dove si fermò. Ma l’elenco delle segnalazioni non finisce qui. Altre informazioni sarebbero giunte all’ex ufficiale del Sid Antonio La Bruna attraverso un suo informatore, un certo Benito Puccinelli in una notte di fine marzo 1978: in via Gradoli c’era un appartamento interessante che si nota anche per un “antenna” radio sul tetto[122]. Francesco Solimeno pentito ed esponente di Guerriglia comunista afferma di essere stato informato su via Gradoli da un certo Fritz (4 aprile 1978) durante un giro dalle parti di via Cassia. Secondo un appunto trovato nel covo, un certo “Fritz” aveva consegnato alle Br la mitraglietta Skorpion usata per il rapimento Moro[123].
E naturalmente come ogni indagine che si rispetti non poteva mancare l’elemento metafisico. Il nome di via Gradoli uscì durante una seduta spiritica a cui aveva partecipato il futuro presidente dell’Iri Romano Prodi. Tuttavia Andreotti e Cossiga hanno sempre affermato che l’informativa a Prodi gli sarebbe giunta, probabilmente, attraverso l’area dell’Autonomia Operaia di Bologna. Lo stesso Cossiga, in chiara polemica con le modalità delle indagini, ha poi dichiarato in un’intervista a Radio Radicale[124] del 18 aprile 2001: «nessuno di coloro che hanno partecipato alla seduta spiritica e che lo hanno ammesso, e che mi hanno passato l’informazione, sono stati minimamente incriminati, io sono stato sentito 68 volte, il presidente Prodi che mi passò l’informazione, non è stato mai chiamato di fronte alla Commissione Stragi, questo perché non è vero che tutti siamo uguali davanti alla legge»[125]. Malgrado le moltissime segnalazioni, l’appartamento verrà scoperto soltanto il 18 aprile del 1978 in seguito ad un evento definito accidentale: una perdita d’acqua provocata dal rubinetto della doccia appoggiato contro le screpolature del muro. Ciò nonostante Moretti dirà: «la scoperta di via Gradoli fu normale: io sapevo che c’era un sifone che perdeva in un alloggio vicino al nostro e l’amministratore ne era informato, dunque niente P2 ma la disonestà dei palazzinari romani»[126]. il contratto sottoscritto da Mario Borghi alias Mario Moretti, è datato il 31 dicembre 1975[127].
I primi inquilini brigatisti sono Lauro Azzolini e Carla Brioschi. Dal gennaio all’estate del ’77 ci abitano Valerio Morucci e Adriana Faranda. Le indagini di Sergio Flamigni, descritte nei diversi volumi (La tela del ragno, Il covo di Stato e la Sfinge delle Brigate Rosse), puntano l’attenzione su un elemento extrafilmico: la figura dell’ingegner G. F, locatore dell’appartamento. L’ingegnere, che secondo Flamigni sarebbe stato il proprietario dell’immobile affittato a Mario Moretti, avrebbe visto avanzare la sua carriera negli anni consegutivi al caso Moro[128]. Flamigni ricostruisce le vicende a partire dallo stranissimo contratto d’affitto, a suo dire, stipulato in fretta e furia, senza date di stipula e decorrenza. Flamigni evidenzia come non sia stato possibile dimostrare quanto l’inquilino Borghi-Moretti pagasse di canone d’affitto, e neppure se lo pagasse regolarmente. Per Flamigni, la strana dinamica che si sarebbe generata dietro la figura dell’ingegnere, rappresenta un valido elemento di indagine da gettare un ombra di sospetto sugli eventi di via Gradoli[129]. Ma si tratta di supposizioni e di indagini che non hanno trovato, per ora, una conferma giudiziaria e storica.
È ancora Pecorelli (aprile 1978) a puntare l’attenzione sulle strane circostanze relative alla scoperta del covo di via Gradoli: «l’allagamento è soltanto un pretesto di comodo inventato dalla polizia, allo scopo di depistare l’interesse della stampa da chi per ben due volte, da Roma e da Torino, fornì l’informazione sul covo. Informazione che usata meglio avrebbe potuto essere risolutiva». Nello stesso articolo Pecorelli non esita a inserire alcuni strani “errori”. Primo fra tutti il numero civico che è indicato erroneamente con il numero 92. Nello stesso articolo, Pecorelli chiama Mario Borghi con il nome di Vincenzo Borghi[130]. Sarà proprio il film a risolvere questi misteri. Questo nome era stato preso dal rapporto ufficiale redatto dal colonnello dei carabinieri, nonché amico dello stesso Pecorelli, Antonio Cornacchia. Riguardo il numero “92” il film chiarisce immediatamente il significato di quel messaggio: presso quel civico c’era un appartamento del Sisde. Fernanda afferma che Pecorelli stava collegando il sequestro Moro e le attività delle Br con i servizi segreti. Un altro articolo di Pecorelli affermava «la scoperta del covo si doveva ad una soffiata della malavita romana, malgrado Infelisi e la polizia abbiano sostenuto che l’allagamento fosse stato accidentale»[131]. Si scoprirà in seguito, come scrive Flamigni, che all’interno del covo Br era stato trovato il numero di telefono dell’immobiliare Savellia, società di copertura del Sisde e che in via Gradoli (civico 96 e 75) c’erano intestati alcuni appartamenti all’ex capo della polizia Vincenzo Parisi (Flamigni osserva che l’immobiliare Savellia risulta di proprietà del Sovrano militare Ordine di Malta)[132]. In tale contesto, è lo stesso personaggio di Fernanda che cita il nome di Vincenzo Parisi come destinatario del rogito del box al numero civico 75 di via Gradoli, «esattamente dove un anno prima il capo della Brigate Rosse parcheggiava le auto dei terroristi» e dei due «apparamenti al numero 96, esattamente dove si trovava il covo brigatista»[133]. Non solo: l’amministratore dello stabile (a cui evidentemente si rivolgevano le Brigate Rosse per la normale gestione delle spese), è un certo Domenico Catracchia «professionista di fiducia del Servizio segreto civile» come ricorda il personaggio di Fernanda.[134]. Il documento storico o l’indagine filmica, che dir si voglia, è quindi prevista in sceneggiatura con un’impostazione del racconto che non ha certamente precedenti nel cinema di inchiesta italiano. Anche da questo di evince il coraggio civile del film di Martinelli che si espone, probabilmente, a non pochi problemi giudiziari.
In questo ambito è doveroso ricordare che il senatore Flamigni riporta due documenti “riservati” che comprovano inequivocabilmente la presenza del Sisde in via Gradoli: una relazione e un appunto, datati entrambi il 7 maggio 1998, firmati rispettivamente dal capo della polizia Fernando Masone e dal capo del Sisde Vittorio Stelo, e inviati al ministro dell’Interno e al Cesis in seguito alla pubblicazione del libro Convergenze parallele[135]. La relazione firmata dal dottor Masone, conferma che la Fidrev srl, società di consulenza del Sisde era a sua volta controllata dall’immobiliare Gradoli. Ma non basta. Flamigni continua le sue indagini e scopre che il prefetto Parisi avrebbe acquistato, con atto notarile del 10 settembre 1979, un appartamento al civico 75 di via Gradoli e, successivamente, sempre al civico 75, altri due appartamenti e un box. Secondo lo studio di Flamigni, Parisi acquistò, altri due appartamenti nel 1987[136]. L’appunto del prefetto Stelo precisa inoltre che «la società Fidrev, azionista di maggioranza dell’immobiliare Gradoli, risulta aver svolto assistenza tecnico-amministrativa per la Gus e la Gattel [società di copertura del Sisde, ndr], dalla loro costituzione fino al 14 ottobre 1988[137]. Strane convergenze, dunque, per parafrasare l’inchiesta di Sergio Flamigni, strani accostamenti che lasciano il sospetto che qualcosa di strano sia avvenuto in quella zona di Roma[138].
Le ambiguità che gravano in un luogo frequentato dalla polizia, dai brigatisti e dai servizi segreti, portano nel cuore del Ghetto romano. Willan ricorda che Elfino Mortati, arrestato per l’omicidio del notaio Gianfranco Spighi (Prato, 10 febbraio 1978), chiede di essere ascoltato per alcune informazioni relative a questo covo. Ricorda il giudice istruttore Ferdinando Imposimato: «Io e il collega Priore caricammo Mortati su un pulmino dei carabinieri e girammo in lungo e in largo, anche a piedi, per il Ghetto, ma senza alcun risultato. Pochi giorni dopo il mistero s’infittì quando mi vidi recapitare in ufficio una foto scattata quella sera, e nella foto c’eravamo io, Priore e Mortati»; la foto, che ritraeva i tre mentre erano in via dei Funari angolo via Caetani, venne scattata da un osservatorio dei servizi segreti italiani. Di quell’intimidazione non venne informata la Commissione d’inchiesta sul caso Moro, né le foto risultano agli atti del processo Moro trasmessi alla Commissione. Dalle dichiarazioni di Mortati, dagli accertamenti svolti dai vigili urbani, dalle notizie delle fonti confidenziali trasmesse, gli inquirenti arrivarono a individuare un covo brigatista situato nel Ghetto ebraico di Roma durante il sequestro Moro in via Sant’Elena n° 8, interno 9. Ma a quel punto tutto si fermò: una speciale immunità protesse le Brigate rosse anche nel Ghetto ebraico[139].
Il film non trova spazio per inserire tale elemento ma il collegamento con il Ghetto, come ricorda Flamigni, continua. Nel covo Br di via Gradoli il 18 aprile 1978 venne trovata la chiave di un’auto con un talloncino di cartone sul quale c’era scritto su un lato «Jaguar 2,8 beige H 52559 via Aurelia 711», e sull’altro «FS 915 FS 927 porte Sermoneta Bruno». Era una traccia che portava nuovamente nel Ghetto ebraico, dove c’erano alcune basi e punti d’appoggio delle Br che tenevano prigioniero Moro, ma le indagini vennero avviate solo a partire dal 12 ottobre 1978 (cioè 5 mesi dopo l’uccisione del presidente Dc)[140].
A tale proposito la signora Moro ricorda una circostanza piuttosto inquietante. Quando Eleonora Moro suggerì che la parola “Gradoli” poteva riferirsi ad una strada romana, si sentì rispondere dal ministro degli Interni Cossiga che lo stradario di Roma non registrava quel nome. In realtà la strada esiste ed esisteva anche all’epoca. La signora Moro e altri membri della sua famiglia riferirono questo episodio nel corso del processo, ma Cossiga smentì recisamente la circostanza durante la sua testimonianza[141].
Nel covo vengono trovati volantini delle BR, numerose armi, esplosivo ed altri documenti. Vengono rinvenute patenti automobilistiche, carte di identità e tessere per concessioni ferroviarie per impiegati dello Stato in bianco, centinaia di volantini delle Brigate Rosse, rivendicanti attentati, tra cui quello al Procuratore Generale di Genova, dott. Francesco Coco (Genova, 8 giugno 1976), e quello al Maresciallo Rosario Berardi (Torino, 10 marzo 1978). Inoltre vengono sequestrati, una divisa da Guardia di PS; una divisa da aviatore di linee aeree, una tuta da operaio della SIP, un camice da impiegato delle PP.TT., nonché numerosi manoscritti, una piantina di un carcere imprecisato, matrici di ciclostile ed altro[142]. Ma la cosa più allarmante come ricorda Fernanda e che non venne fatto nessun rilevamento delle impronte, cosa che si fa nelle procedure più semplici relative ai furti d’appartamento. Insomma, la scoperta di via Gradoli come afferma Rosario è stata una «scoperta pilotata».
Sul collegamento del Sisde con Borghi-Moretti, emergono le conclusioni portate avanti dall’indagine di Flamigni. Fra il materiale trovato nel covo c’era un appunto manoscritto di Moretti: «Marchesi Liva – 659127 – mercoledì 22 ore 21 e un quarto» (la data corrispondeva a mercoledì 22 marzo 1978, sei giorni dopo la strage di via Fani e il sequestro), e un altro «foglietto manoscritto con recapito telefonico n° 659127 dell’immobiliare Savellia». Ancora la Savellia! La sede della Savellia si trovava in palazzo Orsini nella zona del ghetto romano a pochi passi da via Caetani. Il segretario della Savellia secondo Flamigni, risulta essere il ragioniere commercialista G. C[143]. Ma perché il manoscritto appuntava Marchesi Liva, marchesa Valeria Rossi in Litta Modigliani, nobildonna romana che si firmava anche Liva residente in palazzo Orsini? Flamigni evidenzia che il comercialista risulta essere responsabile di altre società immobiliari (Proim srl, immobiliare Palestrina III e l’immobiliare Kepos) tutte collegate al Sisde[144]. Altri nomi, altri individui e altre società immobiliari quasi sempre di copertura collegate al servizio segreto civile finiscono per rendere ancora più complesso l’affaire Moro. Si tratta di eventi che gettano un’oscura ombra su tutta la vicenda di Via Gradoli e pongono conseguentemente domande urgenti: quale alleanze trasversali si sarebbero formate dietro l’affaire Moro? A favore di chi? Perché Moretti avrebbe dovuto incontrare Liva? Che legame sarebbe esistito tra Moro, i brigatisti e il ghetto ebraico? Quale funzione avrebbe dovuto avere lo schizzo planimetrico di palazzo Orsini attribuito a Valerio Morucci, trovato nel materiale di via Gradoli?[145] Sono domande, ancora oggi, in attesa di una chiara risposta.
De Luca – Scarano ricordano che il 20 aprile, due giorni dopo la scoperta del covo, il perito balistico Ugolini avrebbe scritto al magistrato una lettera “riservata”, relativa alle possibili connessioni tra il materiale trovato nel covo di via Gradoli e la strage di via Fani. Il perito avrebbe puntato l’attenzione sul calibro delle pallottole: un bossolo 7.65 parabellum marca Sako con capsula percossa e un bossolo, anch’esso esploso, di calibro 30 M Winchester (carabina in dotazione ai carabinieri). Il bossolo Sako risulta essere uguale a quelli trovati a via Fani, probabilmente sparati dalla MAB P 15 e quindi testimonierebbe il legame tra via Gradoli e via Fani. Ma, inspiegabilmente, non vengono approfondite le indagini[146]. E siamo all’evento più complesso di tutto il sequestro: il settimo comunicato delle Br. In esso reso, noto lo stesso giorno del ritrovamento di via Gradoli, viene annunciato il «suicidio» di Aldo Moro e il recupero della salma nei fondali limacciosi («ecco perché si dichiarava impantanato» si legge) del lago della Duchessa[147]. In seguito si scoprirà essere un comunicato falso, elaborato dal già citato Antonio Chichiarelli. Il 20 aprile giungerà alla stampa il vero comunicato numero sette che smentirà categoricamente quello precedente, definito come «una lugubre mossa degli specialisti della guerra psicologica». Nella sua Relazione, l’intellettuale Leonardo Sciascia aveva visto giusto: il falso comunicato poteva essere indistintamente assegnato sia alle Br e sia al Governo. Il falso comunicato «serviva ed è servito ad entrambi: come ballon d’essai, come prova generale, come ovvio sistema per far scaricare su una notizia falsa – che sarebbe poi stata dichiarata falsa – quelle tensioni, emozioni e giudizi che si sarebbero scaricati sulla vera; e di rendere quindi la vera, che a distanza più o meno calcolata sarebbe esplosa, come ridotta, come devitalizzata»[148]. La notizia dell’esecuzione doveva avere una funzione strategica: annunciando la morte di Moro, avrebbe dovuto abituare l’opinione pubblica e le stesse istituzioni a tale evento.
In relazione al falso comunicato, emergono altri elementi indiziari non meno
importanti. Enrico Paghera (già incontrato per il caso Ronald Stark)
spiegherà alla Commissione Moro che si è trattato di uno stratagemma
per distogliere l’attenzione delle forze dell’ordine dalla città
di Roma, in modo da consentire la fuga indisturbata dei suoi compagni[149].
Tale ipotesi è avvalorata anche da Mario Moretti il quale è sempre
pronto ad allontanare dal caso Moro ogni possibilità di complotto e negando
ogni “altra” interpretazione[150].
Willan ricorda che lo stesso avvocato di Curcio, Giannino Guiso, ipotizzò
persino che Licio Gelli fosse implicato nel depistaggio del lago della Duchessa:
«quella fu la prova generale della morte di Moro… il fatto che un
falso fosse stato considerato autentico, quando in realtà era palese
la sua in autenticità, deve pur significare qualcosa. Di certo Chichiarelli
non lo preparò di sua spontanea volontà»[151]. Una testimonianza
del terrorista di destra Massimo Sparti, secondo Willan, dichiarò ai
magistrati che Chichiarelli gli aveva raccontato di aver preparato per scherzo
e divertimento il comunicato, versione poi confermata anche dalla moglie di
Chichiarelli, Chiara Zossolo[152]. Come si è visto, la funzione di Chichiarelli
all’interno del caso Moro era stata quella di distrarre l’opinione
pubblica sulla scoperta del covo di via Gradoli. Ma il film non si limita a
questa spiegazione: la figura di Chichiarelli serve ad ipotizzare legami più
profondi tra la malavita organizzata e i servizi segreti, da alludere ad uno
scenario più inquietante e più complesso. Tutto quello che accade
in via Gradoli, inevitabilmente, grava ulteriormente l’affaire Moro, da
divenire essa stessa luogo di strani incontri e oscure collusioni. Da questo
punto di vista, si rinforza la traccia proposta dal film, ovvero la possibilità
che la teoria del complotto non sia soltanto una teoria[153].
9.
MORETTI E HYPERION
L’incontro del giudice con il misterioso aggressore costituisce la continuazione del racconto. La scena si svolge nel duomo di Siena, all’interno di un confessionale. Da un punto di vista narrativo, molto probabilmente, la scelta della scena coincide con una sorta di sottotesto, di codice tematico che accosta il caso Moro con un ambiente principalmente ecclesiastico. Se questo elemento sia voluto o accessorio poco importa. Di fatto il regista sembra aver scelto questa traccia narrativa[154]. A rendere più misteriosa la scena è indubbiamente il cammeo del bravo scrittore e archeologo Valerio Manfredi, nella parte del vescovo nel confessionale. Ma ovviamente si tratta di una presenza scenica limitata soltanto a questa parte del film.
È in questa circostanza che prende forma l’identità piuttosto ambigua del temibile capo delle Br, Mario Moretti. L’anonimo terrorista definisce Moretti un «capo anomalo» giocando con un sillogismo evidente, quello con il covo di via Gradoli. Se Gradoli è stato un covo singolare, contiguo alle attività del Sisde, anche il ruolo di Moretti potrebbe indicare uno strano contatto “esterno” con altri gruppi di potere. Rosario è invitato ad andare dietro all’altare. Il terrorista prima di sparire allude alle simbologie misteriose del caso Moro. A questo punto Rosario si accorge di essere rimasto solo e trova un floppy per computer.
La consultazione del file si rivela carica di tensione. Il giudice clicca sul file Memoriale, ma non possiede la password per entrare. In un secondo momento clicca sul nome di Moretti. Come un videogioco, prende forma una catena di associazioni: la torre “Eiffel”, che allude chiaramente alla città parigina, e in fine una strada, Quai de la Tornelle 24, numero 7. E’ il luogo dove risiede la scuola di lingue Hyperion. Dopo qualche secondo compare il nome Entità. Da questo evento Rosario decide di partire per Parigi per incontrare tale “entità” e comprendere quale relazione vi sia tra Moretti e Parigi.
Cosa sia questa Hyperion è subito spiegato dal misterioso intermediario contattato da Rosario: Hyperion è una compagnia, una scuola di lingue, di centro di assistenza dove sono presenti un grandissimo numero di marxisti, quasi tutti collegati con gruppi eversivi e terroristici come l’OLP, l’ETA, l’IRA e le stesse Br. La vera essenza della società è quella della «lotta tra bande». Ma in realtà, continua l’entità, questa organizzazione faceva parte della Cia, infiltrata all’interno dei stessi gruppi eversivi per poterli strumentalizzare e manipolare a seconda delle necessità politiche. Obiettivo: cooptare i gruppi violenti e fornirgli aiuti e organizzazione. Attraverso una battuta esemplificativa di Rosario, il film prende dunque una chiave narrativa inedita attraverso un percorso storico giudiziario diverso da quello ufficialmente conosciuto: «trovo stupefacente il grado di infiltrazione, l’insidiosità della presenza americana nelle nostre azioni, incredibile». È il momento in cui il film incomincia ad allargare il caso Moro, elevandolo ad un contesto internazionale che ha come riferimento il trattato di Yalta[155]. Il trattato, che sanciva la divisione politica del mondo in due grandi blocchi, ha avuto l’effetto di determinare la politica nazionale e le scelte economiche di ogni governo del pianeta. In Italia, come osserva l’ex terrorista, esisteva il partito comunista più forte di tutta l’Europa occidentale e questo poteva rappresentare una seria minaccia per l’equilibrio mondiale. La nozione inserita nel film è offre una visione inedita e fino ad ora ignorata della vicenda di Moro e confermerebbe, in questo senso, una prima prova del complotto dietro la sua eliminazione.
Ma l’ipotesi portata avanti dal film, non sembra essere soltanto un’evidenza. La Commissione d’inchiesta parlamentare sulla strage di via Fani aveva evidenziato che la scuola di lingue disponeva «di locali di un certo tono, per la cui locazione viene corrisposto un canone di notevole importo che, aggiunto alle spese di gestione, comporta un impegno costante di spesa». Le entrate dichiarate dalla scuola, come rivela Flamigni, non potevano certo compensare gli impegni finanziari assunti. In relazione a questa scuola, secondo un rapporto della polizia evidenziato da Flamigni, si legge il nome di Duccio Berio (addetto alle pubbliche relazioni), Francoise Tuscher (presidente dell’Hyperion) e Corrado Simioni (consigliere culturale). Tutti avrebberp un reddito superiore alle loro entrate. Nelle fila della scuola si registrano nomi importanti e molti viaggi in Europa che evidenzierebbero una fitta rete di rapporti a livello internazionale[156].
Il coinvolgimento di questa struttura, che aveva sede in un prestigioso ufficio di Qua de la Tornelle, a pochi passi da Notre Dame, era stata analizzata dal giudice Pietro Calogero come organizzazione che avrebbe dettato le direttive strategiche a diversi gruppi terroristici. Hyperion sarebbe stata creata per dare rifugio e protezione ai latitanti di tutta Europa, secondo la deposizione del brigatista veneto Michele Galati. Per quest’ultimo le Br si sarebbero fornite dalla scuola Hyperion attraverso la figura di Moretti. Si tratta di un ulteriore elemento indiziario che mette in discussione la figura del capo delle Br, Mario Moretti. Il film, per motivi specificatamente narrativi non può inserire troppe nozioni e per questo si limita ad evidenziare la funzione proteiforme e sostanzialmente ambigua di questa organizzazione. Tuttavia esisterebbero delle prove sconcertati riguardo alla strana identità del gruppo brigatista.
L’Hyperion aveva altri protettori, ancora più potenti e sinistri come suggerisce il giudice Calogero attraverso le indagini su Toni Negri e l’autonomia operaia francese[157]. L’indagine del magistrato Carlo Mastelloni, incentrata sul traffico d’armi tra l’Olp e le Brigate rosse aveva analizzato l’insolita posizione della scuola Hyperion. La vicenda salì agli onori della cronaca nel 1984 con la clamorosa emissione di un mandato di cattura per Yasser Arafat, con l’accusa di aver autorizzato la vendita alle Br di numerosi carichi d’armi, un procedimento che non ebbe, però, conseguenze giudiziarie. Tuttavia il giudice affermò, anche se con una certa cautela, che tale traffico era, molto probabilmente, avvallato e protetto dai servizi segreti italiani e dalla stessa Cia. Il volume di Willan evidenzia come all’interno di questa vicenda si possano individuare eventi particolarmente gravi. In particolare emerge il ruolo del colonnello Stefano Giovannone, ufficiale del Sismi, la cui attività si sarebbe inserita tra alcune organizzazioni terroristiche come l’Olp, o le stesse Br e la Cia, sempre pronto a mantenere un costante equilibrio tra le parti[158]. Secondo Willan, l’ufficiale sarebbe stato coinvolto nel traffico di armi con lo stesso Moretti sul noto incontro sulla nave Papago. Sempre Willan ricorda un'altra strana circostanza: la funzione di un non meglio specificato “gruppo speciale” creato dal direttore del Sismi Giuseppe Santovito, sin dal’79 quando Moretti organizzava la consegna delle armi dal Libano che avrebbe sorvegliato tale operazione. Ambigua è anche la presenza del colonnello Silvio Di Napoli le cui missioni sarebbero rimaste coperte dal Segreto di Stato. Willan ricorda il caso sconcertante dell’archivio del generale Maletti in cui si leggerebbe con data 25 marzo 1975, di uno strano contatto tra brigatisti e Olp: «coordinamento Br – Olp, nostra brillante azione, relazionare». Nel dicembre del 1990 la corte d’Assise di Venezia assolse tutti i quattordici imputati accusati di complicità nel traffico d’armi. Il pubblico ministero minimizzò la tesi del giudice Mastelloni, chiedendo la condanna solo per quattro degli accusati. Tuttavia, come osserva Willan, «per la prima volta ufficiali dei servizi segreti e terroristi di sinistra si trovavano assieme in un processo, imputati per gli stessi fatti»[159]. Se tutte queste ipotesi giudiziarie fossero in qualche modo storicamente rilevabili, per quale motivo la Cia o i servizi segreti italiani, avrebbero lasciato campo libero alle azioni terroristiche dei brigatisti?
Hyperion dunque corrisponderebbe ad un disegno strategico assai complesso, con un preciso obiettivo politico. Duccio Berio, incaricato delle pubbliche relazioni della scuola, aveva affermato che dietro gli attentati della sinistra in realtà si sarebbe nascosto un disegno di destra[160].
Per una strana coincidenza, come ricorda l’Entità, la scuola aprì una sede anche a Roma, in via Nicotera 26 poco prima del rapimento di Aldo Moro (nello stesso edificio dove sono domiciliate alcune società di coperture del Sismi)[161] e una a Milano. Entrambe le scuole saranno poi chiuse l’autunno seguente. Dopo l’arresto di Moretti, avvenuto nel 1981, i contatti con Parigi furono affidati a Giovanni Senzani, un altro brigatista sospettato di essere in contatto coi servizi segreti, proprio come lo stesso Moretti.
Il compito narrativo del film è quello di scavare sotto il velo ufficiale e definitivo della storiografia, innescando un’indagine complessa e difficilissima. Tuttavia, se quanto detto corrispondesse ad una verità storica, sarebbe inevitabile pensare alle estreme conseguenze storiche e politiche di una simile organizzazione. Da questo presupposto, verrebbe spontaneo dubitare sui reali obiettivi di Moretti, che con i suoi comportamenti strani, quasi mai giustificati chiaramente, finisce per spiazzare i suoi stessi compagni di lotta. «Dove c’è Moretti, ci sono i servizi segreti», afferma il personaggio dell’ex terrorista, spingendo il ragionamento oltre a qualsiasi interpretazione scontata. E così facendo provoca una strana possibilità di costruzione del racconto, non solo nel giudice, ma soprattutto nel pubblico, che sin dall’inizio è costretto a mettere in dubbio tutte le versioni “ufficiali” delle indagini giudiziarie. Lo sconcerto di Rosario è placato dalla consegna di uno strano opuscolo: «se vuole sapere la verità, legga questo».
Quando il giudice Saracini arriva a Parigi, scoprirà il filo rosso che lega Moretti alla scuola Hyperion. Da questo punto di vista il film rivela la portata internazionale delle Br italiane. Il compito narrativo spetta all’Entità (F. Murray Abraham), di cui non viene fatto il nome e ne si mostrano indizi anagrafici da far pensare a qualcuno realmente esistito[162]. Da qui, la peculiarità della scena. Si tratta di una scelta narrativa precisa che attraverso un personaggio di finzione racconta chiaramente il “quarto livello” di questa vicenda. In questo modo la fiction viene a contatto con i documenti storici in modo da non tradire la veridicità dei fatti. Se il personaggio è inventato, è un esistente, lo stesso non si può dire dei contenuti che riferisce e del suo ruolo all’interno della vicenda. L’Entità, questo è il suo nome, è dunque un personaggio inventato, ma con una funzione narrativa e storica che poco si allontanerebbe dalla verità dei fatti proposta da Martinelli. La sua funzione è quella di spiegare, appunto, la vera ragione “politica” delle Br, sconosciuta ai stessi aderenti della lotta armata[163].
Nel 1980 il giornalista Guido Passalacqua sollevò la questione della vera identità dei capi delle Br in un articolo su La Repubblica (12 aprile 1980): «c’è qualcuno più in altro, una, due, tre persone, che decide le “campagne del terrorismo”… Una direzione decisamente impenetrabile se si pensa che, stando alle indiscrezioni, l’unico collegamento con gli operativi era costituito da Moretti»[164]. Il 7 maggio, Passalacqua venne gambizzato perché nemico di classe. Fortemente sospettosi sulla funzione di Moretti sono gli stessi compagni di partito: secondo Curcio, Moretti è sicuramente una spia[165]; anche per Giorgio Semeria, appartenente alla colonna milanese, Moretti è una spia[166]. E probabilmente Moretti non era l’unico elemento “anomalo”. Secondo una dichiarazione allusiva di Bettino Craxi, dietro la Brigate rosse e dietro la stessa Hyperion si sarebbe nascosto un “grande vecchio” ovvero, il già citato Corrado Simioni[167]. Flamigni ricorda che Corrado Simioni aveva catturato l’attenzione degli investigatori italiani per i suoi esili guadagni e le moltissime spese della scuola Hyperion. Il mistero di questa scuola si infittisce per una strana vicenda relativa ad un sequestro di persona. Un uomo di affari italiano (non viene specificato il nome) aveva donato circa 20 milioni di lire alla scuola poco dopo che il fratello era stato rapito dalla ‘ndrangheta calabrese. Avvicinarsi alla villa di campagna di Simioni, forse di proprietà della stessa scuola, era impossibile a causa del grande numero di guardie armate da cui era presidiata. Flamigni ricorda che il protettore ufficiale di questa scuola era un certo Henri Groues, conosciuto come Padre Pierre, un prete cattolico che aiutava in senzatetto, eroe della Resistenza, deputato e candidato nel ’89 al Nobel per la pace. Secondo la polizia italiana nel ’72, Padre Pierre si teneva in contatto con Renato Curcio e altri brigatisti che sosteneva come vittime della “persecuzione politica” (anche sua nipote, Francoise Tuscher, era un attivista politica che aveva militato nella Sinistra proletaria)[168]. Quando nel ’65 Simioni è espulso dal Psi, entra a far parte del Usis (servizi di informazione Usa), con un ruolo di provocatore e di indebolimento del Partito comunista e di rafforzo del sentimento filoatlantico. Una delle strategie proposte dall’Usis prevedeva la formazione di una nuova corrente socialista che avrebbe dovuto rompere con la linea marxista filosovietica e occidentalizzarsi. Funzione, secondo Flamigni, che ebbe il suo amico e compagno di partito Bettino Craxi. Nel 1969, Simioni aveva fondato e diretto il Cip, Centro informazione politica, composto su un doppio livello, uno ufficiale e uno riservato. Secondo la Commissione controinformazione di Avanguardia operaia, Simioni avrebbe avuto collegamenti con l’intelligence statunitense e sarebbe stato addestrato dalla stessa Cia in Francia[169].
Sono circostanze importanti che tuttavia non possono essere trattate nel film, per ovvi motivi di narrazione.
Il racconto sceglie di puntare su Moretti, sui suoi comportamenti strani e molto spesso superficiali. Molto spesso Moretti commette errori madornali, ma subito dopo non perde occasione per scusarsi, senza essere chiaro nelle spiegazioni date. Le circostanze sono diverse.
Nel 2 maggio 1972 la polizia scopre l’appartamento di via Boiardo e arresta Giorgio Semeria e Marco Pisetta. Gli altri terroristi riescono a fuggire grazie anche al sorprendente numero di giornalisti che si era appostato sul luogo con netto anticipo rispetto alla polizia. Moretti, secondo il suo resoconto, riesce a fuggire perché una “vecchietta” lo avrebbe informato sulla scoperta del covo pieno d’armi. Il noto giornalista Enzo Tortora, collaboratore del mensile Resistenza Democratica, si era appoggiato proprio alla macchina della moglie di Moretti, una 500 blu[170]. La macchina, che verrà sequestrata dalle forze dell’ordine quello stesso giorno, è uno dei primi indizi dello strano comportamento di Moretti. La polizia risalirà alla moglie di Moretti. Tuttavia anziché arrestare la banda al completo, Curcio, Cagol e lo stesso Moretti, l’operazione di via Boiardo può considerarsi un reale insuccesso. Ma un fatto è certo: siamo nel maggio del 1972 e «il futuro capo delle Br al momento è dunque conosciuto, latitante e ricercato e tutti – polizia, carabinieri, apparati di sicurezza, ministero dell’Interno, magistratura – ne sono informati, a Milano così come a Roma»[171]. Nel covo vennero trovati i negativi scattati all’ingegner Macchiarini, fotogrammi che avrebbero permesso di riconoscere uno dei terroristi, Giacomo Cattaneo detto il Lupo. Afferma Franceschini che quei negativi non dovevano stare li, «Moretti ci aveva garantito di averli distrutti […] si giustificò di essersi sbagliato in quanto i negativi si erano incollati tra di loro […] Giacomo Cattaneo, arrestato si era convinto che Moretti era una spia»[172]. Ma non basta. La polizia troverà una foto di Renato Curcio. Moretti si era dimenticato di distruggere la foto dopo aver preparato il falso passaporto al brigatista. Si tratta di un'altra dimenticanza del capo brigatista. Ogni volta, Moretti è pronto a chiedere scusa per le sue “sbadataggini” e a tergiversare immediatamente su altre questioni.
Durante il sequestro Mincuzzi (28 giugno 1973), dirigente tecnico dell’Alfa Romeo, Moretti lascia un comunicato con una stella a sei punte, la stella di David. Moretti disse di essersi sbagliato. Per pura combinazione il Mossad prenderà contatto con lo stesso Moretti e lo aiuterà a trovare l’informatore Pisetta nascosto a Friburgo. Ricorda Franceschini che il Mossad offrì, senza volere niente in cambio, armi e munizioni a patto che gli stessi brigatisti continuassero a destabilizzare il paese in modo che gli «Usa fossero costretti a far riferimento a Israele per il mantenimento delle posizioni nell’area del Mediterraneo […] avevano assicurato che avrebbero comunque sostenuto la lotta armata in Italia»[173]. Si tratta di un'altra ipotesi inquietante, molto spesso sorvolata dalle diverse versioni storiche del caso Moro, ma che costituisce un importantissimo riferimento dell’affaire, come ricorda lo stesso senatore Pellegrino[174].
Scarnado - De Luca ricordano il comportamento anomalo di Moretti. Primo fra tutti la misteriosa partenza per la Calabria, in una strana missione di cui non avrebbe offerto giustificazioni plausibili ai compagni di lotta. Il 12 e il 15 dicembre Moretti e la Balzerani sono a Catania. Il 6 febbraio 1975 è al Jolly Hotel Excelsior di Reggio Calabria. In questa città, come in buona parte del sud italiano, non ci sono colonne brigatiste da fondare come non ci sono progetti “rivoluzionari”. Semmai è l’epoca della nuova mafia. Eppure Moretti e la Balzerani se ne stanno in alberghi di lusso, senza informare il resto dell’organizzazione. Tra i due viaggi, Moretti stipula il contratto di affitto per il covo di via Gradoli, in una via ricca di strane convergenze[175]. Tutto questo confermerebbe un comportamento ambiguo e poco chiaro da far insospettire gli stessi compagni di lotta.
«È il tempo a determinare la verità della storia», afferma l’Entità. Di fronte allo sbigottimento del giudice Saracini, l’uomo incalza la dose, e attraverso questa frase sibillina, rende concreta la possibilità del complotto. Una frase che ha una forte valenza storiografica e al tempo stesso investigativa. Soltanto da una precisa prospettiva storica si possono comprendere certi eventi e giungere alla verità. Un’affermazione che sembra ribadire il punto di vista di chi conosce il retroscena dell’affaire. Il tempo e lo spazio, dunque, sono le coordinate del caso Moro raccontato da Martinelli. Il tempo che aggiunge nuove nozioni, piccoli indizi che gettano inquietanti dubbi sull’ultimissima costruzione dell’affaire; e contemporaneamente lo spazio, quello storico e quello scenico, rappresentato dalla scena finale della torre di Siena come metafora del punto di vista narrativo. Più si sale in alto e più il “complotto” e il suo obiettivo, prendono forma. All’interno di un contesto tutto interno e nazionale, il caso Moro appare come un episodio di importanza internazionale. Allargando la prospettiva, le cose prendono un significato diverso: la torre, la salita dei personaggi, le scale, sono la metafora di un allargamento dell’affaire ad un livello internazionale che avrebbe riguardato gli interessi e l’equilibrio dei governi mondiali. Da questo punto di vista, il film non solo sostiene la possibilità del complotto, ma diventa un primo abbozzo di tutte quelle dinamiche politiche e finanziarie che saranno decise a livello mondiale dai governi più potenti, attraverso una politica molto spesso oscura e belligerante, che sembra determinare gli interessi del cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale. Se il film di Martinelli può infastidire, e perché mira senza troppe scuse al cuore del problema storico e politico del mondo, inquadrando gli interessi delle potenze economiche e internazionali in un contesto dettato della legge del dominio e del controllo finanziario, e definendo, così, la necessità di mettere in pratica le perfide strategie militari e geopolitiche. Eventi molto spesso sottaciuti o nascosti alla maggioranza del mondo civile che, per forza di cose, non riesce e ne può comprendere la spietata strategia degli Imperi.
10.
LA FAMIGLIA DENTRO E FUORI IL FILM
Un aspetto in cui il film costruisce la sua narrazione è quello del contesto familiare. La famiglia è il gruppo elementare dove l’individuo nasce, si forma e cresce. Si tratta di un punto di riferimento particolarmente importante per le persone che la compongono, dove si formano le basi psicologiche e affettive del gruppo. In oltre, la famiglia è la struttura basilare su cui si costruisce la società, cellula fondamentale per lo stesso Stato. Ne consegue che sia da un punto di vista sociologico e sia da un punto di vista psicologico è un fondamentale snodo dell’individuo. In tal senso la famiglia riveste un ruolo centrale nel racconto, sia attraverso il caso Moro e sia attraverso i protagonisti che portano avanti l’indagine.
Il film costruisce una parte dell’intreccio sulla famiglia di Fernanda e, considerando lo stesso caso Moro, tale scelta narrativa non è data unicamente da questa necessità. Aldo Moro, come viene evidenziato nelle sue lettere, scriveva costantemente alla sua famiglia, con un calore e un affetto esemplare. I suoi interventi sono sempre mirati a tranquillizzare i suoi cari e la “dolcissima Noretta”, richiamandosi alle prove dure della sua vicenda. Per lo statista la famiglia assume un ruolo fondamentale come interlocutore intimo e a volte perfino poetico. Una famiglia che non ha smesso di soffrire la perdita del caro congiunto, ancora oggi incredule del tradimento di amici e del suo partito.
Il film, a suo modo, tenta la descrizione di questa sofferenza attraverso lo stato d’animo la famiglia di Fernanda. Quando suo marito viene a conoscenza degli eventi in cui sta indagando la moglie, minaccia di portare via i figli. È la parte narrativa del film che insiste sull’importanza degli affetti familiari e sulla loro incolumità e che bilancia il racconto dell’indagine. La libertà individuale rischia di essere messa in discussione a causa degli impegni improrogabili del lavoro, le indagini portate avanti dalla moglie. Il privato viene usurpato dalle necessità “pubbliche” (Fernanda è un magistrato) mettendo a rischio la cosa più importante: la famiglia e gli stessi figli. Tuttavia qui devo riscontrare una contraddizione sulla costruzione del personaggio di Fernanda, già summenzionata, la quale inizialmente fa di tutto per bloccare l’entusiasmo e le indagini private dello stesso Rosario e poi, in seguito, è mostrata nell’atto di studiare le carte processuali e i documenti delle varie Commissioni Parlamentari. Dunque, il personaggio di Fernanda si divide, con non poche contraddizioni diegetiche tra la famiglia e la carriera, tra la sfera privata (i figli e il marito) e la pista investigativa. Un dualismo sembra forzare un pochino le varie sfaccettature del personaggio e non sembrano offrire una sua perfetta costruzione narrativa e psicologica.
Tuttavia si può tentare un confronto tra la scelta narrativa del film e del personaggio di Fernanda con l’uomo Moro, che agisce tra l’importanza della sua famiglia politica e l’affetto della famiglia naturale. L’ultima lettera di Moro a Noretta, recapitata il 5 maggio, rivela tutta la sua intensità umana e intellettiva, una sorta di componimento poetico, un testamento che tocca il cuore e che confermerebbe l’importanza del fattore umano dietro l’affaire. Verso l’epilogo, verso la consapevole fine fisica del prigioniero, cruda e razionale, c’è spazio per una lucida analisi di quello che sta per avvenire, annuncio del «momento conclusivo»:
Mia dolcissima Noretta,
dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo ho sbagliato, a fin di bene, nel definire l'indirizzo della mia vita. Ma ormai non si può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi ragione. Si può solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti, noi e i nostri piccoli. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della D.C. con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Essa va detto con fermezza così come si deve rifiutare eventuale medaglia che si suole dare in questo caso. E' poi vero che moltissimi amici (ma non ne so i nomi) o ingannati dall'idea che il parlare mi danneggiasse o preoccupati delle loro personali posizioni, non si sono mossi come avrebbero dovuto. Cento sole firme raccolte avrebbero costretto a trattare. E questo è tutto per il passato. Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti e di ciascuno, un amore grande grande carico di ricordi apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio ricordo vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in una unica casa, anche Emma se è possibile e fate ricorso ai buoni e cari amici, che ringrazierai tanto, per le vostre esigenze. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienmi stretto. Bacia e carezza Fida, Demi, Luca (tanto tanto Luca) Anna Mario il piccolo non nato Agnese Giovanni. Sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile, quando non si vuole aprire la porta. Il Papa ha fatto pochino: forse ne avrà scrupolo[176].
L’affetto e l’emozione con cui Moro scrive le ultime parole alla moglie, lasciano comprendere quanto egli fosse premuroso e protettivo nei confronti della sua famiglia. In oltre emerge, senza troppe velature, l’intensa umanità dell’uomo Moro, che smentirebbe chiaramente la definizione di un uomo duro e freddo, come qualcuno lo avrebbe descritto. La lettera si comunica attraverso due livelli, quello famigliare e quello politico, dimostrando una sorta di inseparabilità, di coerente continuità tra la vita privata e la vita politica, un’integrità etica e morale, di “fare” politica e di “essere” politico. Tuttavia, quello che mi preme evidenziare è la presenza di un elemento, in un certo senso, estraneo al contesto familiare, che si riferirebbe ad una serie di indizi cifrati, che lo stesso Sciascia non aveva esitato a prendere in considerazione. Questo aspetto avrebbe dovuto attirare l’attenzione, se non della narrazione, che non può raccontare tutto, almeno degli investigatori.
Adriano Sofri aveva posto l’attenzione su quella strana espressione di Moro, «vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo». La frase indicherebbe, probabilmente, una sorta di luogo chiuso in cui lo statista sarebbe stato rinchiuso, luogo in cui era privato della luce del sole[177]. Da questo prenderebbe corpo l’ipotesi che lo statista avrebbe inserito dei messaggi in codice nelle sue lettere. La trasmissione televisiva di Enigma (Rai Tre, martedì 22 marzo 2004) ha messo in evidenza la particolare propensione di Moro per l’enigmistica e la possibilità che lo stesso abbia inserito alcuni anagrammi in alcuni passi “strani” nelle sue lettere.
Il giornalista Gianni Gennari, ospite delle trasmissione, riferisce della passione di Aldo Moro per l’enigmistica attraverso la testimonianza degli amici del politico, il professor Filippo Sacconi, Giorgio Bachelet (fratello di Vittorio), Alberto Malavolti. Fu proprio questo gruppo di amici che si sarebbe accorto della possibile esistenza di messaggi cifrati all’interno delle lettere di Moro attraverso frasi non molto chiare, le stesse frasi che aveva preso in esame Leonardo Sciascia. La prima lettera è quella rivolta a Zaccagnini, del 4 aprile. Si legge «se non avessi una famiglia bisognosa di me sarebbe un po’ diverso». Giocando sull’anagramma, di cui Moro è sarebbe stato un esperto conoscitore, gli amici di Moro avrebbero individuato «son fuori Roma, dove la Cassia in basso forma un asse, vedo pini e bimbi» (rimane fuori la lettera “g”). L’altra lettera è quella del 29 aprile che risalterebbe agli occhi per una strana caratteristica visiva. Improvvisamente dopo aver scritto a Misasi, Moro salta un quarto di pagina iniziando una frase strana. Si tratta forse di un'altra indicazione: «è noto che i gravissimi problemi della mia famiglia sono le ragioni fondamentali della mia lotta contro la morte». Anagrammando uscirebbe: «le Br mi tengono prigioniero nel Cottage a mattoni a somma della valle di Formello tra Flaminia e Cassia» (rimangono fuori “h”, “i” e “u”). Secondo la testimonianza di Gennari si tratta di una tesi che aveva una sua forza comprovata anche da un importante enigmista, Ennio Peres, il quale aveva notato la forte presenza della lettera “s” e la costante indicazione della parola “famiglia”. L’uscita di questo articolo presso il giornale Paese Sera (1983) non ebbe ripercussioni. Un evento stranissimo però accadde: un signore anziano, ex pilota della Raf, grafico e pittore si presentò alla redazione del giornale, raccontando allo stesso Gennari e all’allora direttore Claudio Fragassi, di aver conosciuto e visitato la prigione di Moro, in una cantina di un noto magistrato, escluso dal suo ruolo proprio da Moro poiché coinvolto nella vicenda Sindona. L’anziano pittore evidenziò le strane parole del magistrato in relazione a questo scantinato: «da qui salveremo l’Italia». L’anziano signore, racconta Gennari, venne trovato morto (morte naturale) 20 giorni dopo nella sua abitazione di Vertica di Amalfi. Il mistero si infittisce quando nel 1987 esce la nuova rivista Giochi in cui viene pubblicato l’articolo sull’enigmistica di Moro e le lettere anagrammate: la rivista viene fatta chiudere il giorno dopo. Si tratta di una storia che andrebbe presa con tutte le riserve del caso e su cui si dovrebbe fare più chiarezza[178]. Satta, da parte sua, ricorda che lo stesso fratello dello statista, Alfredo Carlo Moro, aveva fatto presente che lo statista non sarebbe stato un enigmistam. L’autore ritiene improbabile che Moro abbia inserito dei messaggi segreti nelle sue lettere[179].
Attraverso la famiglia, Moro tenta di stabilire un canale di comunicazione privilegiato e probabilmente sotto forma di codice. Per Sciascia, Moro darebbe due significati diversi al termine “famiglia”. Il bisogno di protezione e di affetto che porta alla sua famiglia non coincide con lo stato sociale della stessa: «peraltro, da meridionale, non credo potesse vedere come bisognosa – di denaro e di protezione – una famiglia come la sua. Un meridionale ai cui figli non manca il lavoro e le cui figlie hanno, oltre al lavoro, un marito; che lascia alla moglie una casa e una pensione e all’intera famiglia un buon nome, si considera come sciolto dal problema della famiglia e in regola con la vita e con la morte. È da pensare, dunque, che appunto perché trovavano immediata e oggettiva smentita, Moro continuasse, insomma, che voleva dire altro»[180]. Per cui Moro non avrebbe trattato la famiglia nel «sentimento, nella sentimentalità, nel pietismo in cui gli italiani lo usano», poiché questo fare «torto alla sua intelligenza, alla sua misura, alla sua lucidità». Dunque nel messaggio preso in esame da Sciascia, la lettera datata 29 aprile, Moro allude ad un’altra famiglia: «è noto che i gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione fondamentale della mia lotta contro la morte». Con il termine “noto” Moro intende sottolineare «quel che noto non è: e che dunque un'altra ragione bisogna riconoscere nella sua lotta contro la morte»[181]. Sciascia allude ad un'altra famiglia, probabilmente quella politica, quella all’interno del partito stesso, che si sarebbe trasformata durante il suo sequestro, e che forse è condizionata da altri eventi esterni. Probabilmente l’allusione dello statista è rivolta a chi dentro il partito conosce le priorità dell’altra politica.
Nel caso Moro, la famiglia assume in todo un aspetto importantissimo. E probabilmente grande importanza hanno i sentimenti, al di la dei possibili codici inseriti nelle comunicazioni. Tuttavia, questo aspetto non ha ancora smesso di incoraggiare un’indagine seria e rigorosa che possa far emergere qualche elemento importante. Insomma, anche nella chiara possibilità di vedere un uomo segnato dal suo destino, pronto a comunicare il suo dolore ai suoi cari, esisterebbe spazio per un Moro “diverso”, preciso, puntuale, che avrebbe cercato di comunicare in codice alcuni elementi utili alla sua liberazione. Si tratta naturalmente di un’ipotesi, ma ciò costituisce inevitabilmente un fatto storico importante che lo stesso Sciascia aveva indicato all’indomani della scomparsa di Moro e che non può essere dimenticato. Di fronte al Moro emotivo, debole, forse colpito dalla sindrome di Stoccolma, esisterebbe un Moro lucido, razionale pronto ad utilizzare con abilità e precisione qualsiasi spiraglio di comunicazione per tentare la sua liberazione. Sono due immagini quasi opposte, diverse che non coincidono affatto e che dovrebbero suggerire in qualche modo una possibile soluzione. Da una parte c’è la perfezione del sequestro, dell’azione militare di via Fani; dall’altra esiste una strana imperfezione dei terroristi, dei comportamenti di Moretti, degli arresti improvvisi, dove addirittura emerge il fattore umano e debole dei stessi brigatisti, come ricorda Sciascia. Nella perfezione del caso Moro, nell’ipotetico scenario del complotto, esiste la faccia imperfetta e debole del sentimento degli stessi personaggi che vi prendono parte, proprio come nella palese imperfezione dei protagonisti reali della drammatica vicenda. Il film Buongiorno Notte di Marco Belloccio, tratto dallo scritto della Braghetti, Il prigioniero, insiste molto su questa lettura del caso Moro, anche se si tratta di un’interpretazione legittima, storica e soggettiva. Probabilmente il caso Moro con le sue implicazioni politiche e strategiche è più complesso di quello che la Braghetti, dal suo punto di vista, ha descritto nel suo bel libro. E affermando questo, vorrei evitare di cadere nella facile dietrologia storica. E’ opportuno ricordare, che Anna Maria Braghetti ha continuato a rifiutare la tesi del complotto e senza troppi misteri, ha sostenuto che dietro le stesse Brigate Rosse «non c’erano potenze nazionali o internazionali che potessero influire sulla situazione, o aprire canali coperti di comunicazione e di trattativa»[182]. Si tratta di una visione semplice e lineare della vicenda Moro, che entra chiaramente in contrasto con le conclusioni sostenute dal film. Una recente trasmissione televisiva, L’infedele di Gad Lerner (20.9.2003), trattando l’argomento Moro, ha glissato su tutti i misteri che avrebbero generato l’affaire. Il programma ha invece scelto di argomentare altre questioni, come il rapporto tra gli intellettuali e il terrorismo, la militanza del marxismo – leninismo, la rivoluzione fallace e illusoria di molti giovani, brigatisti compresi. Nemmeno una parola sulla possibilità che gli stessi brigatisti potessero essere stati strumentalizzati, nemmeno una parola su Hyperion, o su Moretti. Nessuna parola è stata proferita per i misteri del caso Moro. In parte, questo dimostrerebbe che il tabù Moro sia piuttosto diffuso all’interno del panorama culturale e politico italiano. Dalla trasmissione è emersa un’immagine delle Brigate Rosse ingenua, lacerata, inconsapevole, edulcorata proprio come la racconta la Braghetti e come lo ha raccontato, seppur in modo diverso, il film di Marco Bellocchio.
Tuttavia, esiste un’imperfezione costante in tanti aspetti dell’affaire, una sorta di sviluppo illogico di alcuni eventi che, proprio per questo, finiscono per incrementare l’incerto sviluppo del caso. Un’imperfezione che inevitabilmente suggerisce un'altra pista investigativa, una serie di fatti che affiancati l’uno all’altro, suggeriscono un'altra immagine del sequestro. Da questo punto di vista, la strage di via Fani finisce per essere la fine di un lungo percorso che sembra partire molto prima. Il sequestro Moro rappresenterebbe, alla luce di questi eventi, una sorta di cappello conclusivo.
Sciascia osserva che non è soltanto l’incongruenza di alcuni indizi ad essere messa in discussione, ma esiste un’umanità che traspare negli eventi del sequestro che finiscono per ribadire la fragilità degli stessi terroristi di fronte ad un piano preciso e portato a termine. Un’imperfezione che Moro ribadisce alla «unanimità fittizia» della linea della fermezza, in riferimento ad un possibile scambio con i brigatisti: «…applicare le norme del diritto comune non ha senso. E poi questo rigore in un paese scombinato come l’Italia»[183].
La telefonata a Franco Tritto del brigatista Nicolai è uno degli esempi di questa umanità involontaria presente nel caso Moro. La telefonata, secondo Sciascia, è costretta alla terribile necessità del caso e, al tempo stesso, è intrisa di un’emotività incontrollata: la freddezza e la passione del terrorista indicano, nel suo divenire evento storico, un terzo senso, un significato nascosto, che richiederebbe una nuova valutazione dell’affaire. Attraverso la telefonata si comunicano dei piccoli particolari, forse insignificanti per un magistrato, ma fondamentali per uno scrittore: la titubanza del figlio del professore che inizia a piangere per telefono, l’esitazione del freddo Nicolai che in più di un’occasione si ripete perdendo l’obiettivo di quella comunicazione, una modalità anomala per una telefonata lunga più di tre minuti che si scoprirà fatta dalla Stazione Termini: «che cosa dunque trattiene il brigatista a quella telefonata, se non l’adempimento di un dovere che nasce dalla militanza ma sconfina ormai nella umana pietà? La voce è fredda; ma le parole, le pause, le esitazioni tradiscono la pietà […] forse ancora oggi il giovane brigatista crede di credere si possa vincere di odio e contro la pietà: ma quel giorno, in quell’adempimento, la pietà è penetrata in lui come il tradimento in una fortezza. E spero che lo devasti»[184].
La telefonata ricalca un’anomalia italiana, l’imperfezione di una organizzazione, quelle delle Brigate rosse che lasciano continuamente tracce e commettono errori madornali[185]. Al di la della straordinaria lucidità di Sciascia, viene da chiedersi ancora oggi, come è possibile che le Brigate rosse, ragazzi con qualche idea rivoluzionaria e un armamento piuttosto ridotto, abbiano potuto realizzare un attacco così preciso e determinante nel cuore dell’Europa[186]. Osserva Sofri: con Moro, qualcuno ha ancora sorriso della piccineria italiana e democristiana, del “tengo famiglia”. Tuttavia, attraverso le lettere di Moro, è la famiglia – e proprio la famiglia del più esemplare leader cattolico e democristiano – a contrapporsi fino alla rottura alla ragione di stato e di partito». Da questa spaccatura sono poi seguite le famiglie delle vittime delle altre stragi Ustica, Bologna, famiglie che ancora aspettano, nella loro dura lotta quotidiana, la verità sulla morte dei loro congiunti, figli e mariti, mogli e madri[187].
Il coinvolgimento della famiglia è dunque una scelta narrativa ma è anche un dato storico, un fatto reale. Sarà proprio la famiglia di Moro ad entrare in scena dimostrano la commistione tra vita privata e vita pubblica del presidente, attraverso un duro comunicato stampa del 27 aprile diretto al mondo politico italiano e alla stessa Democrazia Cristiana. Si tratta di un atto di accusa rivolto alla Dc per la liberazione di Moro, in riferimento al «comportamento di immobilità e di rifiuto di ogni iniziativa proveniente da diverse parti» che ratificherebbero la condanna a morte di Aldo Moro[188]. Il contatto tra il pubblico e il privato è quindi tanto inevitabile quanto evidente. La famiglia è tutto. Sarà proprio da questa comunicazione che prenderà origine la risposta di “pugno” di Andreotti, autore dell’incomprensibile fermezza. Così traduce Sciascia il comunicato di Andreotti: «il governo ha deciso di non trattare in nessun modo con le brigate rosse, per il rispetto che si deve alle famiglie i cui congiunti sono stati uccisi dai brigatisti»[189]. Inizia un lungo processo di deresponsabilizzazione che finirà con l’esplodere con la definitiva condanna a morte fine del prigioniero. Ma la condanna a morte siglata da chi?
La stessa domanda percorre il film in relazione alle indagini di Rosario, Fernanda e Branco: qualcuno li segue segretamente, li spia, li minaccia. Ma chi è? Quale scopo avrebbe? Perché?
Da un punto di vista prettamente narrativo, il pedinamento dei personaggi indicherebbe che il caso Moro nasconderebbe dei dettagli importanti, alcuni campi inesplorati che riaprirebbero il caso e metterebbero in discussione l’attuale verità giudiziaria. Questa struttura narrativa è basata, per tanto, sull’analisi critica delle versioni ufficiali, e sulla possibilità di delineare una vicenda assai diversa. Si tratta del compito narrativo delle prossime scene del film.

11.
LA MORTE DI ALDO MORO
Il racconto è giunto al punto finale, la morte di Moro. Il regista sceglie la nota telefonata del brigatista Nicolai al professor Franco Tritto, per narrare le circostanze relative all’eliminazione e all’ubicazione del cadavere di Moro. Anche in questa situazione il film utilizza uno stile particolare: attraverso il supporto sonoro originale, il film inserisce dei spezzoni di fiction che descrivono gli eventi drammatici di quella telefonata: c’e spazio per un inquadratura mossa in cui si intravede il presunto brigatista al telefono con il professor Tritto. Più avanti il film ricorre alle immagini del 9 maggio di Via Caetani, immagini indubbiamente vere, girate dai cineoperatori, cui vengono affiancante quelle di fiction dell’esecuzione di Moro dentro la Renault rossa. Questo tipo di linguaggio utilizza la commistione tra il materiale di repertorio, storico e autentico, e il repertorio di finzione, girato dallo stesso regista per supportare visivamente la descrizione che i protagonisti fanno degli eventi. L’effetto di una simile impostazione è di certo molto forte, ma forse potrebbe creare una qualche confusione nel pubblico. Dov’è la verità storica e oggettiva rispetto a quella proposta dal regista? Credo che si tratti di una questione di non poco conto su cui si giocherebbe il valore narrativo del film, il suo valore “investigativo”. Tale costruzione richiama inevitabilmente l’attenzione intellettiva e culturale dello spettatore, il quale deve saper scindere e analizzare il testo filmico, riconoscere il repertorio storico da quello “inventato” dal regista e, al tempo stesso, deve riuscire a comprendere quali sono le novità investigative proposte dal film, rispetto a quelle ufficiali e giudiziarie. Si tratta di un lavoro impegnativo che, in un certo senso, può essere facilitato dal presente studio, in cui si tenta di porre una linea di demarcazione tra la versione ufficiale e quella “nuova” proposta dal regista Martinelli.
Tuttavia un fatto è certo. L’eliminazione di Moro nasconde molte incongruenze e il film lo mostra con straordinaria lucidità, argomentando chiaramente il momento che avrebbe preceduto l’uccisione di Moro. Tutte le contraddizioni esistenti sono enumerate e analizzate dalle indagini portate avanti da Fernanda e il giudice Rosario. Esiste una versione dei brigatisti che non sembra essere molto esaustiva. Per i brigatisti Moro venne ucciso nel covo di via Montalcini con una raffica di mitra Skorpio (l’immagine di fiction ribadisce piuttosto violentemente l’evento) e in un secondo momento da una pistola Walther Ppk modificata a calibro 9. I brigatisti dichiararono che la morte dello statista sarebbe avvenuta tra le 6 e le 6.30 del mattino. Ma per Rosario si tratta di una menzogna palese[190]. In questo punto interviene l’energica relazione di Fernanda che evidenzia le incongruenze della deposizione dei brigatisti. Che Moro sia stato ucciso in via Montalcini è assai improbabile considerando che il tratto di strada da fare fino a via Caetani, luogo del ritrovamento del cadavere, sarebbe stato piuttosto lungo (7-8 km), rischioso e pieno di posti di blocco. Un rischio che le Br probabilmente non erano abituate a correre[191]. Dal rapporto della scientifica, in oltre, emergerebbe che la vittima sarebbe deceduta dopo l’ultimo colpo della pistola calibro 9. Considerando il tratto di strada tra via Montalcini e via Caetani e il traffico esistente, è quasi impossibile sostenere che il corpo della vittima, sia rimasto immobile fino alla fine del percorso[192]. In relazione alla balistica, Fernanda ricorda che le pallottole entrate sul fianco sinistro del prigioniero sono state sparate da dentro la macchina e non dall’esterno come invece sostengono Moretti e Maccari[193]. È per questo motivo che si sono trovati tre bossoli all’interno della macchina sotto il sedile ribaltabile. Fatto che non viene affatto citato nelle versioni di Moretti e di Maccari. Emerge il quarto elemento: che via Montalcini fosse stata l’unica e duratura base in cui Moro era stato recluso per tutti i 55 giorni è un'altra menzogna. L’elemento indiziario di questa incongruenza è evidenziato dalla presenza di sabbia e bitume nei risvolti dei pantaloni di Moro, il quale probabilmente avrebbe camminato in una zona costiera, in «bagnasciuga». I brigatisti hanno sempre sostenuto che il bitume, cosparso da loro, abbia avuto lo scopo di depistare le indagini. Insomma, e si tratta del quinto elemento, l’esecuzione di Moro sarebbe stata compiuta nel pieno centro di Roma, dove erano presenti i servizi segreti. Come afferma il procuratore Saracini dal rapimento fino all’uccisione compaiono i servizi segreti, «in via Fani, dove avviene il sequestro del Presidente… in via Gradoli, dove hanno il covo …in via Caetani, dove viene fatto ritrovare il cadavere»[194]. Dopo il delitto, il corpo di Moro non sarebbe stato spostato, ma sarebbe rimasto esattamente in quel luogo[195]. Si tratta di un’ipotesi inquietante che confermerebbe una diversa ricostruzione delle ultime ore di Moro. Tuttavia il film non tratta l’argomento di chi avrebbe ucciso Aldo Moro[196]. Molti elementi indiziari, oltre alle contraddizioni degli stessi brigatisti descriverebbero un contesto estremamente diverso e porterebbero nel cuore del ghetto ebraico, dove fu rinvenuto il corpo di Moro.
Nel covo di via Gradoli la polizia aveva trovato alcuni elementi che avrebbero portato nella zona del ghetto ebraico: un mazzo di chiavi di una Jaguar con un talloncino con su scritto Sermoneta Bruno, un telefono (grafia di Moretti) che portava il nome di Marchesi Liva con tanto di appuntamento, un altro recapito telefonico dell’immobiliare Savellia, altra sede di copertura del Sisde[197], uno schizzo planimetrico, attribuito a Morucci, di palazzo Orsini. Quale interesse avrebbero avuto i brigatisti per questo palazzo? Perché Moretti avrebbe dovuto incontrare Marchesi Liva, ovvero la marchesa Valeria Rossi in Litta Modigliani, nobildonna romana? Che legame sarebbe esistito tra il sequestro Moro, i brigatisti e il ghetto ebraico? Si tratta di alcune questioni fondamentali che il film non può trattare per una ragione essenzialmente narrativa. Tuttavia, emergono alcuni elementi essenziali che indicherebbero la strana tendenza di quelle indagini.
Le ricerche partirono in ritardo: soltanto il 15 maggio, il consigliere istruttore Achille Gallucci ordinò l’identificazione dell’immobiliare Savellia e i necessari accertamenti. Il tutto porterà al già citato commercialista G. C., che come scrive Flamigni, è il presidente e amministratore della società, in contatto con altre immobiliari tutte collegate al Sisde (l’immobiliare Palestrina III, la Kepos, e la Proim srl)[198]. Ma la relazione a quanto pare non produsse conseguenze giudiziarie.
Il già citato Sermoneta Bruno, (talloncino di via Gradoli) porta nel cuore del ghetto ebraico: è un commerciante di tessuti e possiede diversi automezzi tra cui alcuni autofurgoni. Quale collegamento esiste con Moretti e le Brigate Rosse? Le indagini vengono, inspiegabilmente avviate in ritardo (12 ottobre 1978) e senza soluzione di continuità[199].
Flamigni osserva che un gruppo di fiancheggiatori delle Br venne individuato in via Sant’Elena, proprio nel Ghetto Ebraico, abitato dai coniugi Raffaele De Cosa e Laura Di Nola, militanti della sinistra extraparlamentare. Emergerà poi che la stessa Di Nola, deceduta nel luglio 1979, figlia di un commerciante di tessuti, sarebbe stata legata all’intelligence israeliana[200]. Si tratta di una figura oggettivamente strana, che pur non costituendo un elemento giudiziario, va situtata in una strana zona di confine la zona il Mossad e l’estrema sinistra armata.
Il ghetto ebraico ritorna attraverso la figura di Igor Markevich, il “misterioso intermediario”, esponente della nobile famiglia Caetani, indicato da alcune informative come possibile capo delle Br, nonchè il possibile inquisitore che avrebbe interrogato Moro[201]. Le indagini sul direttore d’orchestra non offriranno nessun riscontro significativo. Tuttavia Flamigni osserva che il nome di Igor Markevich finisce per essere legato a Palazzo Caetani, sede di altre organizzazioni come l’ambasciata del Sovrano ordine dei Cavalieri di Malta, un ordine religioso- militare che ospitava diversi iscritti al P2 nonché il direttore del Sismi il generale Santovito[202].
Altro elemento riguarda palazzo Mattei, confinante con palazzo Caetani, ideale luogo per ricetto di autovetture: «la Renault delle Br avrebbe potuto entrare e uscire dallo spazioso passo carraio collocato in via dei Funari»[203], forse quel misterioso passo carraio di cui parla lo stesso Pecorelli. O forse questo passo carraio è quello di un edificio di via Paganica, adiacente con tre entrate. Una di queste porterebbe ai magazzini di Guglielmo Di Nola, padre della citata Laura. I tessuti rappresentato un elemento importante nell’indagine poiché vengono trovati sotto la suola delle scarpe di Moro, sui parafanghi e nel pianale delle Renault 4 e definiti come «strutture filamentose». Questo fatto potrebbe provare gli spostamenti che venivano imposti al prigioniero, indicando un’altra verità. Tuttavia il film preferisce evidenziare la sola presenza di “bitume” e del «materiale sabbioso misto a una formazione vegetale tipo cardo, con aculei non essiccati»[204] piuttosto che allargare l’indagine su ulteriori elementi indiziari. In oltre, palazzo Mattei è ricco di sotterranei con vari magazzini di tessuti, è sede di entri culturali e accoglie una sede del Sisde (quarto piano)[205].
Insomma la conclusione del sequestro Moro ha come scenario il ghetto ebraico circondato da strane coincidenze, personaggi misteriosi, di cui non si è fatta piena chiarezza: ma secondo il film e il senatore Sergio Flamigni, è anche molto probabilmente il luogo dell’uccisione di Moro.
Le perizie effettuate sul corpo di Moro, smentiscono la versione di Morucci, confermata da Moretti, dalla Braghetti e da Maccari. I brigatisti hanno sostenuto che il prigioniero sarebbe stato rinchiuso in una stanza di 90 centimetri per 3 metri in via Montalcini per tutti i 55 giorni del sequestro. Ma le risultanze peritali affermano che il corpo di Moro era in buone condizioni igieniche, senza nessun segno di anchilosi muscolare e che probabilmente il corpo di quell’uomo avrebbe vissuto in un luogo spazioso. Il materiale sabbioso presente nei risvolti dei pantaloni, giustificato dai brigatisti come depistaggio, potrebbe indicare il possibile luogo dove il prigioniero avrebbe trascorso una parte della prigionia. In effetti, ricorda Flamigni, che un covo brigatista era stato individuato nella zona Fregene – Focene. Secondo Flamigni, alcuni volantini trovati il 26 marzo confermerebbero tale ipotesi. Particolarmente rilevante è la testimonianza relativa all’episodio avvenuto il 6-7 maggio, in cui un certo Sergio Cardinaletti avrebbe visto lo stesso Mario Moretti, in zona Focene, riconosciuto subito dopo in una foto segnaletica[206]. Tutto questo getterebbe una luce sinistra sulle dinamiche del delitto e insisterebbe sulla necessità di riaprire il caso Moro. Lo scambio di battute tra Branco e Fernanda sintetizza la tesi portata avanti dal film: «dunque, stando a quanto dite, il Presidente sarebbe stato ucciso non nel covo di via Montalcini, ma nel centro di Roma, a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento del cadavere»[207]. Si tratta di un’ipotesi inquietante e rivoluzionaria, presa in considerazione da un articolo di Massimo Caprara, pubblicato presso la rivista Pagina (25 febbraio 1982), in cui si faceva riferimento al dubbio assassinio di Moro. Caprara aveva osservato come i pochi soldi trovati in tasca allo statista, avessero avuto una precisa utilità: «una somma pari a quanto occorre… per pagare un taxi dalla periferia urbana, dall’Ostiense, la Magliana, la Cassia o poco più là»[208]. Ma forse i soldi erano un trucco per illudere lo stesso Moro di un suo imminente rilascio[209]. Tuttavia, osserva ancora Caparra, che «la famiglia Moro non ha mai rinunziato a sottolineare questo dettaglio inquietante che porta ad una conclusione altrettanto torbida: Moro fu liberato dagli uni e trucidato da altri?»[210]. E come ricorda il senatore Dc, Giovanniello, probabilmente «Moro stava per essere affidato a criminali comuni per il terribile atto conclusivo»[211]. Si tratta di un’ipotesi che ravviserebbe la presenza di altri esecutori materiali, di altri gruppi misteriosi di cui ancora oggi non si conosce la vera identità[212].
Per la notissima immagine in cui Moro veniva fotografato con la stella a cinque punte, il film elabora una nuova location, modificando ancora una volta la versione ufficiale. Il racconto mostra la circostanza in cui sarebbe stata scattata quella foto, “ricreando” gli ultimi istanti prima di quell’evento: si vede il prigioniero (ricreato in post produzione), si sentono le voci fuori campo dei terroristi. Ma quello che colpisce è la costruzione di una location molto più ampia che sembra ribadire, attraverso un codice iconico, che il prigioniero non fu rinchiuso sempre e soltanto in un unico luogo stretto e inospitale come viene dichiarato dai brigatisti. Lo spazio di questo luogo, che appare attraverso un flashback per pochissimi secondi, evidenzia un’ipotesi diversa. L’autopsia fatta sul corpo di Moro, aveva evidenziato, come ho già summenzionato, la mancanza di anchilosi e contratture che avrebbero potuto testimoniare la costrizione in cui si sarebbe trovato il prigioniero: «il cadavere risulta curato, con indumenti in buono stato, le unghie non debordano dai polpastrelli e ne si rileva materiale ematico. È evidente, osserva il regista, che il prigioniero fu tenuto in un locale ampio, dotato di servizi igienici, che gli consentì di lavarsi, di scrivere e di radersi. Si tratta di una ipotesi avvallata anche dalla perizia calligrafica che riferisce una situazione comoda e rilassata e non stando sdraiato a letto con i gomiti sulle gambe come, invece, dichiarano le deposizioni dei brigatisti e di cui si può vedere una chiara rappresentazione nel film di Giuseppe Ferrara. Anche in questo caso ci si troverebbe di fronte ad un resoconto che non coincide con la versione ufficiale delgi eventi[213]. Si tratta di una sorta di ricostruzione spaziale che assurge ad una nuova dinamica del dopo sequestro e diverge dalla versione ufficiale. Il valore figurativo dell’inquadratura ha il potere di mettere in discussione la versione ufficiale della prigionia di Moro.
Le evidenze enumerate da Fernanda, continuano a smontare la versione ufficiale. Il luogo del ritrovamento del cadavere di Moro è contiguo a via Foa dove lo stesso Moretti aveva preso un immobile presso Via Foa per redigere i comunicati brigatisti. Si tratta del sesto indizio inserito nella scena. La vicinanza tra il luogo del delitto e via Foa indicherebbero una importante relazione tra le attività dei brigatisti e il ghetto ebraico di Roma. Ma il film punta l’attenzione sulla macchina topografica utilizzata dalle Br, la quale proveniva da un reparto definito Rus (raggruppamento unita speciale) dell’ufficio Sismi, in via di Forte Bravetta, sotto il comando del Generale Giuseppe Santovito. Si trattava di un reparto d’addestramento responsabile dell’allora organizzazione paramilitare Gladio[214]. Questo è un fatto certo, come afferma Fernanda: «una stampatrice appartenente ad un ufficio del controspionaggio militare viene usata per redigere tutti i comunicati relativi al rapimento del presidente all’interno di una topografia gestita clandestinamente dalle Br». È il momento in cui il film ammette la strana collusione che sarebbe esistita tra i brigatisti di Moretti e i servizi segreti militari. È quindi la conclusione di un percorso investigativo estremamente grave che espone i protagonisti a non pochi rischi.
La sentenza di Corte d’assise racconta che la Rotoprint A.B. Dych matricola 938508 era stata fornita il 31 gennaio 1972 dalla stessa ditta RUS del ministero della Difesa. Dichiarata “fuori uso” era stata venduta come rottame ad un commerciante di vecchi strumenti grafici, un certo Noto Stefano, il quale aveva trovato un acquirente nel brigatista Sebregondi Stefano per tre milioni di lire. Quel giorno risulta essere presente anche Triaca Enrico. È l’inizio di una vicenda contorta. Per il Sid esiste un'altra storia, declassata nel 1975, per la quale la stampante sarebbe stata venduta a Bentivoglio, il quale, però in Corte d’assise avrebbe negato[215]. Affermerà Eleonora Moro: «quando hanno scoperto la tipografia, mio marito era ancora vivo. E si doveva fare questa cosa prima della data che era stata fissata. La data stabilita per andare e prendere le persone della tipografia era molto interiore alla data in cui mio marito morì. Perché fu poi rimandata al 9 e poi rimandata ancora? Perché?»[216]. Risponde Sciascia: «tanta lentezza crediamo dovuta principalmente a quello che il dottor Fariello (dell’Ucigos) chiama “pedinamento a intervalli”: che sarebbe il pedinare le persone sospette, a che non si accorgano di essere pedinate, quando sì e quando no. Il che, afferma Sciascia, sarebbe come non pedinarle affatto, poiché soltanto il caso e la fortuna possono dare senso ad una simile pratica investigativa, «come se il recarsi in luoghi segreti, gli incontri clandestini e tutto ciò che s’appartiene all’occulto cospirare e delinquere, fosse regolato da abitudini ed orari»[217]. È sempre Fernanda a ricordare che in data 28 marzo, dodici giorni dopo la strage di via Fani, al Viminale era giunta un importante informativa riguardo Teodoro Spadaccini. L’informazione è precisa ma viene tenuta in “sonno” per oltre un mese. Verrà trasmessa alla questura soltanto 32 giorni dopo, il 29 aprile: «da questa data inizia il pedinamento del brigatista Teodoro Spadaccini, che faceva parte della brigatista universitaria che gestiva la custodia della Renault rossa utilizzata per l’uccisione di Aldo Moro. Ebbene nove giorni dopo la morte del Presidente, il pedinamento di Spadaccini porterà alla localizzazione della tipografia di via Pio Foà»[218]. Ma si tratta del giorno in cui Moro viene trovato morto.
La detection viene interrotta dalle necessità narrative, che pure fanno parte del racconto complessivo. L’indagine avanza vorticosamente e pericolosamente e gli effetti sui propri cari, sulla famiglia sono quasi immediati. Fernanda è avvisata da suo marito che i loro figli non sono ancora tornati a casa e questo è naturalmente fonte di preoccupazione per tutti, Rosario compreso, il quale sa benissimo che la sua indagine non è ancora autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L’intreccio del racconto porta a confronto il valore investigativo del film e quello umano dei personaggi, realizzando un pericoloso corto circuito. Come avevo osservato nei paragrafi precedenti si tratta di una scelta narrativa ma anche molto precisa che ha a che vedere, probabilmente, con l’inevitabile pericolosità dell’affaire che come una piovra stringe nei suoi tentacoli chiunque si lascia coinvolgere dal caso, colpendo gli stessi familiari.
L’uccisione di Moro trova un drammatico riscontro con un fatto: probabilmente nessuno era interessato a liberare un uomo che presumibilmente aveva parlato dei numerosi segreti di Stato, di un uomo che rappresentava la diretta testimonianza sul suo stesso sequestro e degli strani avvenimenti relativi al covo. La sua liberazione avrebbe avuto un effetto destabilizzante. Ricorda Pecorelli che lo stesso Cossiga era stato avvisato della presenza dei brigatisti in via Montalcini, alludendo, attraverso espressioni simboliche, alla presenza della P2 in tutta la vicenda[219]. Con i suoi scritti e il possibile Memoriale che gli sarebbe stato estorto, Moro annunciava cose gravi da non poter essere tollerate da un sistema politico fragile come quello italiano. Il messaggio di Pecorelli indicava chiaramente che il sequestro Moro rappresentava l’ulteriore continuazione di una strategia della tensione, attraverso mezzi nuovi[220]. Per questo motivo la liberazione e il reinserimento di Aldo Moro all’interno della politica italiana era pressoché impossibile.
Moro conosceva il comportamento finanziario e politico del suo partito, il potere di Governo che dal dopoguerra fino agli anni ’70 aveva dominato la scena sociale e civile. La sua politica filoaraba era in chiaro contrasto con la politica americana. Durante la guerra dei Sei Giorni, Moro si sarebbe opposto alla concessione delle basi militari, provocando le animose lamentele di Kissinger[221]. Moro sapeva e parlava del coinvolgimento americano nella strategia della tensione che aveva lo scopo di ricondurre alla “normalità“ l’Italia, dopo la destabilizzazione del ’68[222]. Moro, nel suo Memoriale, aveva rivelato dei finanziamenti Cia alla Dc e faceva riferimento a Gladio. Aveva descritto negativamente i suoi colleghi di partito, Andreotti, Taviani, Zaccagnini, e molti altri[223]. Era divenuto da vittima a pubblico ministero della politica italiana e della stessa Dc dei quali conosceva tutti i segreti. Come aveva osservato Pecorelli (24 ottobre 1978), Moro rappresentava una «bomba ad orologeria che avrebbe ancor più minato le già cotte strutture della repubblica». E per questo motivo non si sarebbe potuto tornare indietro, il prigioniero doveva essere eliminato. Esisteva un gruppo di potere contro Aldo Moro e la sua politica di solidarietà nazionale. Qualcun altro avrebbe poi pensato, inevitabilmente, alla sua “eliminazione”.
La genesi della linea della fermezza potrebbe trovare una valida interpretazione alla luce di quanto detto: la liberazione di Moro avrebbe potuto significare la fine di altri personaggi politici a livello di partito e forse anche a livello internazionale.
Tuttavia all’opinione pubblica, veniva descritto un Moro influenzato, alterato, drogato. Il culmine della linea di fermezza si sarebbe raggiunto con la notizia che lo statista starebbe scrivendo sotto l’influsso di un potente psicofarmaco, l’aloperidolo, «una medicina insapore e inodore che rende la persona facilmente dominabile e che modifica la scrittura rendendola incerta»[224]. I politici confermarono incredibilmente la tesi di scienziati e neurologi: Cossiga, «… missiva completamente estorta», Rognoni, «Moro è ormai uno strumento delle Brigate Rosse», Colombo, «non c’è niente del pensiero di Aldo, cose infantili, assurde»[225]. La linea della fermezza si sarebbe espressa anche attraverso questi particolari e non soltanto attraverso una logica politica e giustizialista. Così la spiegherà Andreotti «i rapitori hanno posto il preciso tema del cosiddetto “scambio di prigionieri”. L’inaccettabilità di un tale disegno è palese… Ancora: se gli agenti dell’ordine e ancor più le guardie carcerarie, che quotidiane soffrono disagi e dileggi e purtroppo in parecchi casi hanno pagato con la vita il difficile servizio di vigilanza e di prevenzione; se questi umili servitori dello Stato vedessero che per liberare un uomo politico si calpestano le leggi e si aprono le prigioni, la reazione sarebbe immediata, con conseguenze gravissime. E che dire delle vedove e degli orfani degli uccisi?» Sofri ricorda che Andreotti aveva più volte ribadito questa intenzione della linea della fermezza[226]. Nella relazione finale della Commissione Moro si legge che «la liberazione, anche di uno solo dei tredici, avrebbe imposto un gravissimo strappo alla legalità, incrinando profondamente le ragioni stesse della resistenza del Paese contro il terrorismo e offeso i valori di fondo di giustizia e di uguaglianza del nostro ordinamento». Ironicamente aggiunge Sofri: «tutto questo disastro sarebbe stato provocato dalla liberazione, per esempio di Paola Besucchio?»[227].
Il ritrovamento del cadavere di Moro è commentato dallo stesso Pecorelli attraverso uno dei suoi scritti più criptici[228]. Il 23 maggio 1978 pubblicò qualcosa di molto simile a una telecronaca: oltre il muro dove sarebbe stato trovato il cadavere, «ci sono i ruderi del teatro di Balbo, il terzo anfiteatro di Roma». E continua «ho letto in un libro che a quei tempi gli schiavi fuggiaschi e i prigionieri vi venivano condotti perché si massacrassero tra loro. Chissà cosa c’era nel destino di Moro perché la sua morte fosse scoperta proprio contro quel muro? Il sangue di allora e il sangue di oggi»[229]. Pecorelli parlava dei gladiatori riferendosi alla morte di Moro, ma fino a poco tempo fa pochissimi avrebbero capito il senso del messaggio. Sembrerebbe, però, che Pecorelli si riferisse anche a delle precise responsabilità dei gladiatori nella morte di Moro. Per Pecorelli, Gladio è certamente presente dietro all’affaire Moro come una delle organizzazioni che avrebbe determinato l’esito del sequestro. L’esecuzione di Moro, l’abbandono tra la sede nazionale della Dc (piazza del Gesù) e quella del Pci (via delle Botteghe Oscure) confermerebbe la strana guerra in cui si trovò lo statista e il motivo per il quale fu eliminato. Da questo punto di vista la sua eliminazione avrebbe significato la sconfitta violenta e traumatica della stessa democrazia, e affermato il valore subliminale di una guerra che si combatteva soprattutto sul piano psicologico e non più propriamente militare.
Scriveva nel 1944 il giovane Moro: «ciascuno accetti in pace, quando è la sua ora, di uscire dalla scena del mondo, con la gioia di avere costruito qualcosa per gli uomini e con la certezza di finire»[230]. Contro la sua stessa volontà, prematuramente, lo statista uscì drammaticamente di scena, senza aver potuto realizzare il suo progetto solidarietà nazionale, senza poter completare la sua missione. Come una marionetta «dai fili spezzati, come un fagotto», il cadavere di Moro è stato collocato all’interno di un’anonima automobile, ucciso insieme alla sua stessa idea di ricostruzione di una società probabilmente diversa.
12.
LA SCENA DELLA TORRE
In una lettera datata tra il 27 e il 30 aprile e indirizzata a sua moglie Eleonora,
Moro scriveva: «si trattava in fondo di uno scambio di prigionieri come
si pratica in tutte le guerre (e questa in fondo lo è) […]»[231].
L’interpretazione non lascia scampo e sottolinea fortemente lo stato di
«guerra» in cui il mondo politico italiano si sarebbe trovato. Moro
parla di scambio di prigionieri, come possibile “oggetto” della trattativa.
Analizzando tutto il contesto del sequestro, colpisce ineccepibilmente l’espressione «guerra» usata dallo statista. Nella ricerca effettuata sulle lettere di Moro, il termine “guerra” e “guerriglia” compare in tutto nove volte e quasi sempre ad indicare la possibilità di scambio tra prigionieri[232]. Moro cita esempi internazionali, il caso Lorenz, gli eventi Palestinesi, la Croce Rossa[233]. Particolarmente sibillina è l’ultima lettera in cui compare il termine “guerriglia”: si tratta di quella indirizzata a Riccardo Misasi in cui le parole di Moro descrivono la triste constatazione di questa guerra. Appellandosi al diritto umanitario, alla stessa Croce Rossa, alle procedure adottate in caso di scambio di prigionieri, Moro scrive che «c’è un rifiuto […] un allineamento su posizioni esterne», quasi a rilevare la presenza di una forza esterna che controllerebbe gli eventi e che impedirebbe la sua liberazione. Dunque, anche questo elemento insiste sul contesto bellico in cui il paese è coinvolto. In altre lettere Moro richiama l’attenzione sulle potenze straniere, evidenziando una possibile patologia della sovranità nazionale dello Stato Italiano: «vi è forse, nel tener duro contro di me, un’indicazione americana o tedesca?»[234]. Scrive Sofri: «la sensazione che fra i terroristi agisse una mano straniera, quella ossessione di una perfezione e di una ferocia “tedesca”, si ritrova nel sospetto che assilla Moro, che i democristiani siano a loro volta ispirati nella “fermezza” da una volontà esterna»[235].
Moro sapeva perfettamente che la sua vicenda non poteva limitarsi ad un ambito personale e privato. Sapeva che le sue scelte politiche avrebbero avuto un importante effetto sull’equilibrio nazionale e da poter alterare l’equilibrio politico di tutto il mondo e per questo, sarebbe stato inviso a molti capi di Stato. Sapeva, quindi della “guerra” che gli si sarebbe rivolta contro e intuiva, forse, che sarebbe stato colpito da una manovra politica di altissimo livello. Ma come sarebbe stato attuato il “colpo”? Chi sarebbe stato l’esecutore materiale di tale manovra? Quali interessi sarebbero entrati in gioco? Gli interrogativi sono sviluppati in questa parte del film.
La guerra può essere definita come il conflitto violento scaturito tra società e gruppi armati organizzati. Essa presuppone lo scontro tra due o più blocchi militari e politici fino alla sua estrema conclusione, dove una delle due parti, o schieramenti, sancisca la propria impossibilità di continuare il conflitto, e iniziando, così, il primo passo verso il trattato di pace. Questa definizione indicherebbe in primis la chiarezza degli obiettivi che scatenerebbero la guerra, e la presenza chiara e distinta di un nemico da combattere. Nell’affaire Moro, non si possono riconoscere questi elementi bellici. Per tanto, la guerra che avrebbe combattuto Moro non conserverebbe nessuno di questi tratti essenziali. Ma allora, di quale guerra sta parlando lo statista?
Moro è oggetto di una guerra strana, di un conflitto simbolico e criptato, una guerra invisibile, una guerra fatta tra idee e strutture politiche non proprio evidenti di fronte alla storia e alla stessa opinione pubblica. Si tratta di una guerra che, in primo luogo, si compie sul piano psicologico, quello personale, di una guerra che può essere compresa soltanto da chi aveva scritto quelle lettere. Si tratta della tesi sostenuta nel film.
La scena della torre di Siena argomenta il livello “occulto” della presunta guerra in cui sarebbe coinvolto lo statista, il cosiddetto quarto livello internazionale[236]. Le scelte narrative e stilistiche del film convergono sulla descrizione di un livello politico avanzato, in cui prenderebbero vita segreti rapporti politici e finanziari tra governi e lobby internazionali. Si tratta della teoria del doppio Stato, assai avversata dagli storici accademici secondo la quale, oltre allo Stato trasparente, fatto di istituzioni, di un governo e di un parlamento eletto dal popolo, esisterebbe in ogni Nazione, uno stato occulto, segreto composto di famiglie finanziarie, di massonerie e di potenti gruppi economici che possono determinare il ciclo storico. Al di la di ogni possibile veridicità sull’esistenza di questo livello, che per altro precluderebbe da questo lavoro, bisognerà ammettere che il racconto di Martinelli avanza una serie di elementi giudiziari e probanti, assai imbarazzanti per le stesse istituzioni.
Il film adotta uno stile storico e scenografico: molti elementi architettonici, edifici, chiese, palazzi e torri, divengono il luogo candidato per affrontare l’argomento Moro. Questa scelta, probabilmente, risponde a due ragioni narrative. Da una parte, la scenografia rifletterebbe una certa tradizione storica italiana, caratterizzata da un’imponente architettura bellica e politica, composta da torri, chiese, castelli in cui le potenti Signorie hanno esercitato il loro specifico potere temporale e militare. Da questo punto di vista, l’ambientazione risponde ad un’esigenza analitica che tenta di comprendere il corso storico degli eventi. Dall’altra, evidenzierebbe la stessa vicenda di Moro, la quale coinciderebbe con il tentativo di stabilire un equilibrio tra le diverse spinte politiche italiane e internazionali, di porre una sorta di pace, di compromesso. La frammentazione della politica italiana, l’eccessivo partitismo e una vivacissima attività governativa, evidenziano la particolare instabilità della storia politica e civile dell’Italia. La scena iniziale del famoso palio di Siena, potrebbero assumerebbe questo significato. Le immagini sono veloci, strette su dettagli e montate con un ritmo serrato e brevissimo. Suggeriscono una forte conflittualità tra gli elementi[237]. La funzione semantica del particolare chiuso all’interno dell’immagine, l’inquadratura specifica che sottrae lo spazio intorno all’oggetto, destruttura e mette in conflitto tutta l’integrità dell’oggetto e della stessa scena. Attraverso un montaggio rapido, concentrato sulla brevità dell’inquadratura e sulla specificità dei dettagli, emerge un significato conflittuale tra gli elementi mostrati. Tale struttura suggerirebbe la forza rituale del palio di Siena, ma anche la tradizione storica della cavalleria, dei soldati, e in una parola della guerra: il film si apre attraverso la messa in scena di una guerra. Attraverso il rituale storico del palio, come paradigma degli eserciti e della conquista, emerge l’idea di un conflitto permanente che attraversa tutto il racconto filmico e che ha determinato la vicenda storica dell’Italia e dello stesso Aldo Moro.
Ma esiste anche un altro aspetto importante che emerge dalla scena della Torre e che posso definire di valore squisitamente cinematografico. Si tratta del valore simbolico che assume lo spazio scenico in cui avviene il racconto. Questo valore spaziale è propriamente la dimensione dell’altezza della Torre[238]. L’altezza della Torre corrisponde al punto di vista di chi nell’insieme analizza l’affaire Moro; più si va in alto e più sono chiare le strategie del Potere. Questa scena ha lo scopo di svelare lo scenario internazionale dietro l’episodio prettamente nazionale, contro chi, fino ad oggi, ha insistito per far prevalere l’interpretazione del sequestro Moro solo e soltanto attraverso le Brigate rosse. Lo scopo precipuo della scena è quindi di dare una risposta al significato particolare che Moro dava alla parola guerra. La metafora adottata per questa scena è quindi il punto di vista dei protagonisti, una metafora che viene realizzata dal basso verso l’alto. Il punto di vista spaziale corrisponde al punto di vista narrativo e conseguentemente al punto di vista storico. La finzione cinematografica e narrativa è il presupposto per una possibile verità storica che avrebbe generato la drammatica vicenda di Aldo Moro: questa, a mio avviso, sarebbe la forza semantica di questa scena. Martinelli afferma che si è trattato di una metafora per dare corpo all’idea del complotto: «dalla cima della Torre, molti fatti apparentemente slegati tra loto tradiscono così il filo sotterraneo che li lega»[239].
Ogni piano della torre corrisponde ad un nuovo e inquietante livello del caso Moro, dove si svelerebbero i tasselli dell’indagine. Rosario accosta tutte le conclusioni raggiunte fino ad ora: quello di via Fani è un sequestro anomalo, come anche quello di via Gradoli è un covo anomalo. Ancora una volta emerge l’idea di una situazione strana, non chiara, esattamente come la «guerra» di cui scriveva Moro. Il film raggiunge il suo scopo puntando l’attenzione sulla figura anomala e ambigua del presunto capo delle Brigate rosse, Mario Moretti, un «capo anomalo». Il giudice rivela le ultime informazioni avute a Parigi dalla cosiddetta entità. Tutta la strana vicenda del sequestro Moro è fatta risalire alla scuola di lingue Hyperion, il cui scopo nascosto era quella d’impedire l’ascesa del partito comunista italiano. Un obiettivo che coincideva con quello della Loggia Massonica P2. Rosario conclude affermando che dentro le Brigate rosse vi erano gli infiltrati di presunti e misteriosi servizi segreti che dovevano convogliare gli interessi dei terroristi con gli interessi delle potenze internazionali: in una parola l’impraticabilità del compromesso storico. Questo aspetto emerge in maniera piuttosto diretta attraverso le parole di Saracini: «il programma della P2 era diametralmente opposto alla politica di Moro, la loggia di Gelli avversava il partito comunista come un esiziale nemico… proprio in quegli anni nel nostro Paese era nato un fenomeno nuovo, le Brigate Rosse, appunto»[240].
In questo punto del film si tratta l’ennesima anomalia dell’affaire Moro. L’esempio è fornito da Frate Mitra, meglio conosciuto come Silvano Girotto. La sua biografia può essere equiparata a quella dell’agente provocatore: studente, ladro, rapinatore, legionario in Algeria, disertore, frate francescano, guerrigliero in Bolivia, resistente in Cile. Sempre salvo mentre chi gli sta intorno viene arrestato. Si ha l’impressione di vedere un infiltrato di altissimo livello, agli ordini di un servizio segreto che determina gli eventi storici, «usato dagli strateghi della tensione che procedono alternando attentati di destra e attentati rossi»[241].
Il primo incontro tra Curcio e Girotto avviene il 28 luglio 1974. L’incontro è fotografato dai carabinieri del generale Dalla Chiesa. Il secondo incontro è del 31 agosto. Curcio e Moretti sono insieme. Girotto aveva offerto la sua conoscenza di guerrigliero andino. Moretti trasse l’impressione che Girotto fosse sincero. Ma Curcio e Cagol non ne erano affatto convinti, ricorda Franceschini. Il terzo incontro è fissato per l’8 settembre. Il 6 settembre una telefonata anonima giunge ad Enrico Levati, medico già presente nell’incontro di Pecorile, arrestato e poi rilasciato in merito alle indagini sui Gap di Feltrinelli. Flamigni ricorda che Levati avvrebbe ricevuto l’informazione di avvisare Curcio che l’incontro di settembre sarebbe stato una trappola. Ma la notizia non arriverà mai a Curcio, ma soltanto a Moretti[242]. Gli incontri tra il gruppo armato e Girotto sono di fatto una trappola gestita dal Nucleo speciale dei carabinieri del generale Dalla Chiesa. Ma questa operazione si rivela, comunque, gravida di enigmi e di ambiguità a partire dallo strano comportamento di Moretti e dalla misteriosa fuga di notizie che avrebbe avvisato Enrico Levati.
L’otto settembre del 1974 Girotto partecipa all’operazione organizzata dai carabinieri del Generale Dalla Chiesa, che si concluderà con l’arresto di Franceschini e Curcio, in località Pinerolo. Si tratta di un evento che muta radicalmente l’attività delle Brigate rosse e tutti gli obiettivi politici della lotta armata contro il “regime”. Il film evidenzia i lati oscuri dell’arresto di Pinerolo a partire da un fatto strano: perché Curcio e Franceschini sono stati arrestati così in anticipo da bruciare la stessa copertura di Girotto? Se Girotto avesse potuto continuare le sue indagini, avrebbe sgominato l’intera organizzazione e impedito, probabilmente, lo stesso sequestro Moro. Il generale Dalla Chiesa, in Commissione Parlamentare, diede una risposta poco esaustiva, affermando che una volta identificati i criminali dovevano, nell’obbligo della legge, intervenire nell’arresto[243]. Ma non basta.
Tra il materiale che i carabinieri raccolsero non risulta, stranamente, nessuna immagine di Moretti. Fino a quel 8 settembre, Moretti era già stato pedinato, fotografato e quindi era un elemento classificato come pericoloso dalle stesse Forze dell’Ordine. Eppure nei suoi confronti, come ricorda Flamigni, non vennero fatte ulteriori fotografie comprovanti la sua presenza a Pinerolo. Questo spiegherebbe, ricorda Fernanda, «come mai in nessuna foto agli atti del processo torinese delle Brigate Rosse non compare Moretti»[244]. Cosa più strana è che Mario Moretti non è arrestato. Ne consegue che la presenza di Girotto, non solo comproverebbe l’ingerenza dei servizi segreti dietro gli stessi Brigatisti, ma evidenzierebbe che la retata sarebbe stata organizzata con lo scopo preciso di arrestare soltanto una parte della Brigate rosse e lasciare poi spazio al nuovo capo Mario Moretti. Moretti è il vero beneficiario dell’arresto[245]. Egli cambia strategie e obiettivi del gruppo armato, dando una svolta violenta e bellicosa: il film mostra le immagini del telegiornale relative al 6 giugno del 1976, quando le Br uccisero il magistrato Francesco Coco e i due carabinieri della scorta. Come ricorda Saracini, «è a partire da questo preciso momento che le Br adottano l’omicidio come metodo di lotta»[246]. Quando Moretti assume il comando, le Brigate Rosse stanno progettando il sequestro dell’onorevole Giulio Andreotti, «Moretti invece, convince l’organizzazione a spostare il tiro su Aldo Moro… nel momento in cui quelli che manovrano Moretti decidono il sequestro di Moro, il presidente della Democrazia Cristiana è un uomo morto»[247]. Ricorda Franceschini, che nel ’74 si era deciso di organizzare il sequestro Andreotti con il quale i brigatisti avrebbero chiesto in cambio i compagni della XXII Ottobre e di Maurizio Ferrari (arrestato dopo la liberazione di Sossi). Nel ’76, dopo il reclutamento di Morucci, i brigatisti iniziarono un’inchiesta su Moro, spingendo verso la realizzazione del suo sequestro. Moretti, spiegherà che molto probabilmente le Br non avevano compreso in pieno la differenza tra Moro e Andreotti. Ma appunto, ricorda Flamigni, «perché Moro e non Andreotti?», perché il leader democristiano vicino alla sinistra, progressista, filoaraba, inviso agli americani e allo stesso Mossad? Perché non Andreotti, capo della destra anticomunista accusato dalle stesse Br di essere il regista politico della svolta “neo-gollista” di Sogno? Sono domande che Moretti evade con sfrontata ambiguità[248]. Sofri ricorda una dichiarazione di Moretti: «non mi risulta che si sia pensato ad altri per la grande campagna di primavera del ’78 […] la nostra attenzione e il nostro impegno si concentrarono su Moro»[249]. Dunque, strane contraddizioni.
Rosario illustra le nuove priorità delle Br, il cambiamento di rotta. Moretti è l’unico brigatista importante ancora libero: trasforma l’obiettivo delle Br attraverso un’opera di propaganda per sequestrare il vero nemico del proletariato e del partito armato, l’esponente di spicco dei Stati Imperialisti Multinazionali: Aldo Moro. Da adesso in poi, Moro è il vero responsabile del regime democristiano[250].
Rosario ricorda che intorno ad Aldo Moro esisteva già una «cortina di ferro» anche nell’area di partito, di governo e nel mondo politico internazionale. La realizzazione del suo progetto politico, attraverso l’entrata del partito comunista nell’area di governo, avrebbe rappresentato un serio pericolo per le forze democratiche e per lo stesso regime comunista. Si tratta del punto più delicato e fondamentale del film. La politica di Moro era destabilizzante, avrebbe permesso ad un partito “nemico” di accedere ai segreti militari della Nato. L’entrata del Pci nel Governo avrebbe significato svelare tutti i segreti Nato al nemico. Di contro, avrebbe significato che un partito comunista poteva partecipare al processo democratico attraverso un consenso popolare ed elettorale, senza il bisogno di costruirsi su di una solida impalcatura burocratica come poteva essere l’Unione Sovietica di Breznev. Dunque, il compromesso storico rappresentava oggettivamente un problema geopolitico e strategico-militare tanto per Washington, quanto per Mosca. È il punto chiave del film.
Lo stesso Pecorelli aveva evidenziato il carattere internazionale del sequestro Moro attraverso un articolo intitolato Yalta in via Mario Fani: «l’agguato di via Fani porta il segno di un lucido superpotere. La cattura di Moro rappresenta una delle più grosse operazioni politiche compiute negli ultimi decenni in un Paese industriale, integrato nel sistema occidentale». Più avanti aggiunge che l’obiettivo principale di questo sequestro è l’allontanamento del partito comunista dall’area di governo, e al tempo stesso, l’allontanamento di una prospettiva troppo democratica per lo stesso comunismo o «eurocomunismo». Il film diviene la descrizione narrativa di questo articolo: il fattore Yalta e la divisione del mondo in due blocchi. Pecorelli insiste in questa prospettiva: la partecipazione del Pci non era gradita ne a Washington e ne a Mosca, «la dimostrazione storica che un comunismo democratica può arrivare al potere grazie al consenso popolare, rappresenterebbe non soltanto il crollo del primato ideologico del Pcus sulla Terza Internazionale, ma alla fine dello stesso sistema imperiale moscovita»[251]. L’apertura al “quarto livello” è da identificare con la logica di Yalta, «è Yalta che ha deciso via Mario Fani»[252].
Da questo presupposto il film introduce il dubbio sulla identità organica e unitaria delle stesse Brigate rosse e su alcuni suoi componenti, proprio come aveva fatto lo stesso Pecorelli attraverso un altro articolo: E anche Renato Curcio fa il suo dovere. Si tratta di un articolo sibillino che allude al fatto che i rapitori di Moro non avrebbero niente a che vedere con le Brigate rosse, con il «grande fatto politico – tecnicistico del sequestro Moro»[253].
La scelta di Moretti di puntare l’attenzione su Aldo Moro coincide “stranamente” con la volontà internazionale dei due blocchi di scongiurare a tutti i costi la realizzazione del compromesso storico in un paese, l’Italia, in cui esisteva il partito comunista più forte sotto giurisdizione Nato. Da qui, il film, spinge ulteriormente sulle strane anomalie del brigatista Moretti: la sua straordinaria fortuna nell’evitare gli arresti, fino all’aprile 1981, i suoi misteriosi viaggi, i contatti con Hyperion, i suoi evasivi resoconti sulla dinamica del sequestro Moro, versioni non sempre chiare e soddisfacenti. Tanto che, in carcere Moretti verrà emarginato da tutti gli altri brigatisti, come ricorda Galati, perché considerato spia[254].
Il film mostra l’opuscolo che il giudice avrebbe avuto dall’Entità a Parigi. L’opuscolo definisce i piani d’intervento militare da adottare in caso di vittoria elettorale del partito comunista o in caso d’invasione dell’Armata Rossa, attraverso l’azione di agenti infiltrati. Si tratta, afferma Rosario, della direttiva FM 30/31 B che prevedeva azioni di provocazione e reazione di alti esponenti della sinistra comunista e azioni di sequestro, fino all’assassinio di leader politici. Il dato più significante è quello che riguarda i piani d’intervento militare presenti nell’opuscolo in mano a Rosario sono incredibilmente simili ai piani di intervento politico e finanziario in programma per le elezioni politiche del 18 aprile 1948[255]. Si tratta dei piani di Gladio, di cui Moro stesso era a conoscenza, e della struttura segreta Stay Behind, nata per lo stesso motivo: osteggiare il pericolo di un’avanzata politica e militare comunista[256]. Ed è probabilmente a questa guerra che Moro si sarebbe rivolto nelle sue lettere. Aspetti militari e politici che in quel periodo ancora erano del tutto sconosciuti all’opinione pubblica e a buona parte del mondo politico, ma di cui Aldo Moro, noto anche con il nomignolo di Signor Omissis, ne conosceva gli interessi e la gestione[257].
Da un punto di vista narrativo la scena della torre assume un’importanza fondamentale per risolvere definitivamente l’indagine. Rosario, si rivolge a Branco, affermando che forse conosce l’ubicazione del presunto vero Memoriale Moro. Ed è in questa direzione che il film tenta il suo percorso investigativo. Il Memoriale che tutti conoscono quello riscoperto nel ’91 sarebbe dunque incompleto e il giudice Saracini starebbe per raggiungere quello vero e definitivo[258].
13.
LA FINE DEL RACCONTO
Nella ricorrenza della strage di Via Fani del 16 marzo 1988, Il Messaggero pubblicò alcune dichiarazioni del pubblico ministero Domenico Sica. Il magistrato affermava: «non ci sono verità nascoste sul caso Moro... tutto quello che poteva essere scoperto è stato scoperto… sono convinto che ciò che resta da sapere è assolutamente irrilevante ai fini dell’individuazione del nucleo terroristico responsabile»[259]. È un punto di vista condiviso dalla maggior parte delle Istituzioni e dalla politica italiana: nel caso Moro non c’è più niente da scoprire e per questo sono da escludere tutti quei misteri che continuerebbero a destabilizzare la verità giudiziaria. Tutte le indagini personali portate avanti da un certo settore dalla pubblicistica apparterebbero, quindi, ad una dietrologia speculativa e fantastica. Quella di De Sica è un’affermazione molto forte che stride con l’idea narrativa del film di Martinelli e con le ipotesi proposte da altri scrittori, giornalisti e intellettuali[260]. Lo stesso Moretti, ancora oggi, è fermamente convinto che le Br, di fatto, furono un gruppo rivoluzionario armato che voleva attuare una lotta contro il Potere. Tuttavia, molti sono i buchi neri che confermerebbero le strane circostanze del sequestro Moro. Ci si trova di fronte ad uno strano bivio, un doppio percorso che descriverebbe i due approcci del caso Moro. Da una parte esiste la versione ufficiale, divulgata in ogni dove, di cui si fanno portavoce maggiori rappresentati della cultura e della politica italiana. È il caso dell’Odissea del caso Moro, di Vladimiro Satta, ricordato polemicamente dallo stesso Flamigni, o ancora di alcuni interventi giornalistici di Pierluigi Battista o ancora di Paolo Mieli che avrebbero sminuito il lavoro investigativo di Flamigni o criticato lo stesso film di Martinelli[261].
Dall’altra esiste una “strana” minoranza, che continuerebbe il personale percorso investigativo, molto spesso solitario e difficoltoso, cercando di portare alla luce gli elementi poco definiti della vicenda. Due tendenze che, effettivamente, sembrano rispecchiare un divario storico e politico tutto italiano e che rappresentano due tendenze opposte e contrarie che sembrano andare molto al di la della semplice ricerca storiografica. Forse, come ha osservato il presidente della commissione stragi Giovanni Pellegrino «la classe politica italiana non ha un reale interesse all'accertamento della verità sulle stragi in quanto ciascuna forza politica punta ad una verità che giovi al proprio interesse»[262].
Sopra le due tendenze, sembra esistere un potere molto più ampio, che gestirebbe la verità storica e giudiziaria: è la tesi narrativa proposta dal film e che colpirà direttamente i familiari di Fernanda e lo stesso procuratore Saracini. Si tratta, almeno da un punto di vista filmico, della conferma della tesi del complotto, e di come esista un potere che convive con gli eventi quotidiani della società civile, che gestisce gli eventi della storia. La morte del marito di Fernanda, in circostanze che il film presenta chiaramente delittuose, e la scoperta della vera identità di Branco, indicherebbero la presenza di un potere insidioso dedito al controllo delle informazioni, proteso ad un incessante spionaggio. Martinelli racconta che il caso Moro nasce in un contesto storico e politico determinato da una guerra di spie di altissimo livello internazionale. Gli eventi incalzano tutti verso il finale: l’inseguimento di un misterioso elicottero che tenta di eliminare il giudice[263]; la visita intimidatoria nella casa del giudice che viene messa a soqquadro[264]; la strana telefonata che Rosario riceve dal capo della magistratura che lo invita a presentarsi immediatamente a Roma. Si tratta, ineccepibilmente, di un superpotere che esiste e convive concretamente con la vita del procuratore, che controlla segretamente tutti gli eventi privati e pubblici della vita del singolo cittadino.
Quando Rosario scoprirà la chiave per accedere al programma informatico, comprenderà che si tratta del nome di una nota zona romana, prossima a piazza Navona, dal nome piazzadellecinquelune: è la password che gli consentirà di svelare il mistero intorno al memoriale Moro. Piazza delle Cinque Lune è anche il luogo dove Varisco, Pecorelli e il generale Dalla Chiesa si sarebbero incontrati in più riprese e dove, molto probabilmente, sarebbero venuti a conoscenza, già durante il 1978, dei passi censurati del memoriale Moro. Piazza delle Cinque Lune sarebbe la chiave per accedere al Memoriale, il luogo dove si sarebbe creata una strana collusione tra servizi segreti e occulti superpoteri. Ma sarebbe anche lo spazio scenico del finale narrativo del racconto, il telos della storia. Quindi il livello storico si sovrappone al codice narrativo, delineando una nuova possibilità investigativa. Il titolo del film spiegherebbe tale circostanza complottistica e insidiosa, la rappresentazione di “poteri” non meglio definiti. Piazza delle cinque lune è il luogo fisico carico di misteri, è l’elemento narrativo che scioglie l’intreccio e spiega la logica del racconto. Un luogo che sosterrebbe il significato storico e storiografico di tutta la vicenda: il caso Moro nasconderebbe un’intricata matassa da districare, resa contorta dalla mancanza di documenti troppo spesso confusi o addirittura scomparsi. Se il giudice Saracini scopre di essere stato spiato sin dal primo momento, lo spettatore scopre che tutto il caso Moro è controllato da un superpotere nascosto e onnisciente[265]. Tutta la storia raccontata è quindi travolta dal poderoso dubbio finale che travolgerebbe tutta la storiografia riferita al caso Moro. Tutta la finzione narrativa, quindi, corrisponderebbe ad un reale livello storico ancora da esplorare.
Nell’incontro con Branco si assiste allo svolgimento dell’intreccio narrativo che però non risolve quello storico: anzi lo ammanta di un dubbio maggiore. Chi si nasconderebbe dietro il caso Moro? È l’invisibilità dell’evidenza, per dirla con Sciascia. Il potere dentro il sistema è onnicomprensivo, onnisciente e onnipresente. Convive a fianco della magistratura, della politica, nell’esecutivo e per poi intervenire quando crede. L’inquadratura dall’alto assume anche questo significato: il controllo. Il punto di vista rappresenta la visione complessiva degli eventi e come un potere più grande che controlla gerarchicamente quelli più in basso. Il film, come ho osservato precedentemente, adotta questo linguaggio semantico per evidenziare questo aspetto del racconto, ovvero la relazione esistente tra il punto di vista narrativo (la macchina da presa) e il punto di vista storico (lo svelamento di alcuni indizi giudiziari).
Il Memoriale non sarà scoperto nemmeno alla conclusione del racconto: «il film ha una conclusione amara, ovvero che la verità è destinata a rimanere nascosta in questo paese. Il famoso Memoriale non verrà fuori neanche nel film […] in Italia certi misteri sono destinati a non essere svelati mai, come è successo per i fatti di Ustica, per la strage di Bologna e in tanti altri tragici episodi della nostra storia»[266]. Il Memoriale Moro fa riferimento ad espressioni tipo «come dirò più avanti» oppure «come ho già detto altrove»[267]. Nelle 229 pagine fotocopiate, trovate nel covo di via Montenevoso il 9 ottobre del ’90, mancherebbero tali rimandi. Perché i brigatisti non hanno divulgato il Memoriale, pur avendo affermato che “niente doveva essere nascosto al popolo”? Dov’è finito l’originale scritto a mano del Memoriale Moro? Dove sono finite le pagine mancanti? Dove le bobine registrate ? Dove sono le trascrizioni degli interrogatori?[268]. Il regista sceglie la strada del finale aperto. L’impossibilità narrativa di trovare il Memoriale è la triste constatazione di una storia politica e giudiziaria ancora da risolvere. Da questo punto di vista, il film raggiunge il suo scopo narrativo. Il discorso della storia e il discorso della forma coincidono nell’impossibilità di non poter chiudere il film. Si tratta di un film che inquieta lo spettatore, il quale non riesce a trovare un finale perché non esisterebbe, secondo Martinelli, nemmeno nella storia ufficiale, perché nessuno è ancora riuscito a trovare la versione definitiva del Memoriale Moro.
Il collante di questi misteri è rappresentato da una location virtuale, un luogo che per tutto il film non esiste, se non nell’indagine che compiono i protagonisti, e compare soltanto nel finale del film, nella soluzione amara dell’intreccio: Rosario non troverà il Memoriale, ma scopre la doppia faccia dello Stato. Il Memoriale, è molto probabilmente dietro a questo superpotere. Cercare di scoprire l’ubicazione del Memoriale, significherebbe affrontare la presunta identità di uno Stato che si muove nel segreto, con tutte le conseguenze che questo comporterebbe[269].
Il punto di vista è confermato anche dalla scelta stilistica del regista, dalla costruzione scenica e narrativa della scena finale. L’ending shot, è realizzato attraverso il ritorno della forma elicoidale della rampa delle scale e dalla panoramica sulla mappa della città. Tutto richiamerebbe alla rete in cui è caduto il giudice. La forma essenziale di questi due elementi, già presenti durante la narrazione, sono esasperati attraverso l’utilizzo di un piano sequenza che partendo dall’interno del palazzo, in cui si trova il giudice, arriva a coinvolgere una zona enormemente più grande e più complessa. La violenza del zoom out non indica soltanto lo stato d’animo del giudice, sorpreso e spaventato della presenza di Branco, ma è anche l’espressione diretta, tangibile ed estetica del complotto. Il film, attraverso questo finale, offrirebbe un’ulteriore spiegazione sull’utilizzazione semantica del punto di vista. Lo svelamento del reticolo delle strade, visto dall’alto, indica chiaramente l’incastro diabolico e perfido di tutta la storia, quella del giudice che tenta l’indagine e quella stessa di Moro, ricca di contraddizioni irrisolte. La figura ellittica, come ho già evidenziato precedentemente, è la metafora di una ragnatela che circoscrive l’affaire, la stessa che fa riferimento alla citazione in esergo al film: «la giustizia è come una tela di ragno: trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi trafiggono la tela e restano liberi»[270].
Si tratta di una conclusione inquietante che entra nettamente in contrasto con quella garantista e risoluta delle istituzioni. Ce lo ricorda Franceschini. Per lui Moretti era un infiltrato di terzo livello: il primo livello era il movimento rivoluzionario; il secondo livello erano le stesse Br; e il terzo era rappresentato da chi «utilizzava anche la lotta armata per garantire gli equilibri del mondo sanciti a Yalta nel 1945». D’altra parte, è lo stesso Moretti a ricordare la valenza storica dell’affaire Moro sarebbe rimasta ancora aperta, «perché questa storia che politicamente è finita non è una storia giuridicamente finita»[271]. E Franceschini parla apertamente di trattative: «nelle galere c’è stata la contrattazione su quello che si doveva e non si doveva dire, e il silenzio è stato pagato con la libertà o i benefici di legge a favore degli ergastolani»[272].
Flamigni, a suo modo giunge ad alcune conclusioni simili a Franceschini, in totale disaccordo con gli esiti giudiziari: la verità ufficiale raccontata dai brigatisti e sancita dai tribunali come tale è, in più punti, inverosimile; non crede alla purezza rivoluzionaria delle Brigate rosse morettiane e tanto meno a quella di Moretti; egli è convinto che nel delitto Moro vi siano state implicazioni dei servizi segreti e collusioni “atlantiche”. Si tratta di tesi soggettive e per tanto opinabili, afferma Flamigni, ma libere di essere espresse e di essere argomentate. Ed è, al contempo, il filo rosso che percorre tutto il film di Martinelli, nel racconto di finzione e nell’indagine giudiziaria.
Un film, come ricordavo all’inizio è prima di tutto un fatto narrativo, che rientra di diritto nel campo estetico. Ma non per questo deve essere necessariamente destinato al mondo della finzione e dell’invenzione intellettuale. Da questo punto di vista, il film di Martinelli può essere definito come un fondamentale esempio di impegno civile e sociale interessato all’analisi e allo studio della verità storica. Non si tratta di puntare l’attenzione sul fattore spettacolare che tenta di trarre il massimo dai tanti misteri che esistono nella prima repubblica. E ne si può accusare il film di Martinelli di faziosità politica o giudiziaria. Gli elementi presentati nel film, sono in primo luogo indizi, tracce reali, segni oggettivi che messi insieme definiscono una possibile pista investigativa, una possibile interpretazione storica che non può essere tacciata come difettosa o paranoica. Il film è l’esempio in cui il cinema, come immagine movimento, possa intervenire nella realtà sociale per rappresentare il suo più alto contributo etico ed estetico. La costruzione della trama, il rifacimento delle scene, costringe il film, per forza di cose, ad ipotizzare un'altra dinamica degli eventi a tal punto da scorgere, senza imbarazzo, brigatisti e istituzioni dietro una versione troppo spesso superficiale. Così accade nella ricostruzione della strage di via Fani dove due elementi giudiziari non hanno permesso, a rigore di logica, lo svolgimento drammatico e fattivo dell’incidente: l’impatto della macchina di Moro, che non c’è mai stato e l’uccisione del maresciallo Leonardi. Qui il film insinua il dubbio e lo fa secondo una base oggettivamente riscontrabile nei resoconti giudiziari e nelle versioni fornite dai stessi brigatisti. Probabilmente, come afferma il regista, se brigatisti hanno potuto mentire sull’azione di via Fani e su un aspetto evidente come il mancato tamponamento, forse hanno mentito su tutto il resto[273]. Dunque, il film non è esclusivamente un fatto finzione o di invenzione. Da questo punto di vista il racconto ribadisce continuamente il suo sforzo di costruzione semantica e al tempo stesso storiografica, degna di un cinema della migliore tradizione italiana, del cinema di Rosi, di Petri, del cosiddetto cinema politico.
In oltre, il film ha un altro primato: per la prima volta all’interno del cinema italiano viene trattato senza troppi formalismi l’argomento P2. Non solo. Nel film esiste una vera e propria struttura gerarchica, un organigramma, che si mostra chiaramente in tutta la sua forza storica e giudiziaria, attraverso alcune inquadrature chiare e distinte in un contesto storico preciso. Prima di questo film, nessuna opera aveva osato tanto, nessun racconto aveva tentato di presentare i nomi di uomini politici, militari e civili per inserirli in un racconto. Da questo punto di vista, il film di Martinelli ha effettivamente rotto un muro di omertà e per questo, volenti o nolenti, bisogna dargliene atto[274].
Ma la conclusione spetta proprio allo spettatore, poiché il film è creato soprattutto per stimolare la sua conoscenza e la sua intelligenza. Allo spettatore spetta il compito di unire i spezzoni proposti nel film, di operare un scelta tra le tante versioni esistenti, di creare un unico percorso narrativo unendo i diversi tempi e i diversi spazi proposti nel film: il flashback, il repertorio, le immagini di finzione, le telefonate dei brigatisti, il filmato di via Fani, i nuovi elementi indiziari. Tutto questo deve essere necessariamente contestualizzato se si vuole dare un senso al racconto narrativo e al racconto storiografico. Per dirla insieme a Deleuze, l’attività dello spettatore finisce per coincidere con quella «falda di trasformazione» che inventa una sorta di continuità, di comunicazione trasversale, liberando così la stessa narrazione dall’impaccio del racconto e operare un senso compiuto. Percezione, ricezione e riflessione: la sintesi deve essere data e offerta proprio dallo spettatore, che completa il finale aperto del film. Ma forse «è un lavoro che rischia lo scacco, talvolta produciamo soltanto una polvere incoerente fatta di prestiti giustapposti, talvolta formiamo soltanto generalità che prendono in considerazione solo delle somiglianze» e in tutto questo, lo spettatore comune può perdersi, confondendo ulteriormente la ricerca della verità[275]. Ma si tratta, inevitabilmente, di un rischio che il cinema deve correre se vuole intervenire positivamente nei gangli dello sviluppo sociale e civile, modificare i punti nevralgici del Potere e incentivare la crescita degli individui.
La costruzione finale del racconto indica inequivocabilmente l’allargamento del caso Moro: l’affaire è «una vicenda di intelligence internazionale, non circoscritta solo all’Italia e nella quale molti sono i punti oscuri». Il film propone dunque l’idea di questa storia e non pretende, secondo la più alta ambizione del cinema politico italiano, di risolvere la vicenda e ne tanto meno di schierarsi su di un fronte interessato e partitico: «vorrebbe sollecitare gli spettatori a riflettere su tutte le incongruenze e le menzogne che da venticinque anni ruotano intorno a questo evento epocale»[276]. Lo scopo dell’arte impegnata del cinema cosiddetto politico è quello di incitare allo studio della propria storia, stimolare la curiosità e comprendere le cause e gli effetti del proprio paese, significa crescere e costruire il futuro. Lo scopo del cinema verità è quello di impedire l’oblio, provocare l’indignazione non per il gusto estetico di provocare emozioni forti e violente: semplicemente per non dimenticare la propria storia e gli strani revisionismi che non collimano tra loro, molto spesso forzati e interessati. L’indignazione è il gesto rivoluzionario dello spettatore, è una delle possibilità per acquisire coscienza critica. È uno dei modi per poter raggiungere la verità. E la verità è sempre illuminante e ci aiuta a essere coraggiosi, come scriveva Moro. Il film di Martinelli è un film coraggioso proprio perché cerca una verità senza tornaconti.
Andrea Lomartire
--------------------------------------------------------------------------------
[1]Lo strutturalismo sostiene che ogni forma narrativa si compone di due parti: una “storia”, il contenuto o concatenarsi di eventi (azioni e avvenimenti, più quelli che possono essere chiamati esistenti ovvero personaggi, elementi dell’ambiente), e un “discorso” vale a dire l’espressione, il mezzo attraverso il quale viene comunicato il contenuto. Seymour Chatman, Storia e discorso, la struttura narrativa nel romanzo e nel film, Pratiche Editrice, Parma, 1981, pp. 5; 15. La narrazione è il rapporto che si stabilisce tra il contenuto e la forma che corrispondono rispettivamente alle categorie di cosa e come. Chatman ha indicato con “storia” (story) cosa è la narrativa e con “discorso” (discourse) come è la narrativa. Il cosa–storia tratta il contenuto della narrativa, ovvero gli eventi e gli esistenti. Il come-discorso tratta l’espressione della narrativa, il “modo” con il quale si esprimono esistenti ed eventi, nonché la posizione narrativa dello stesso autore, il punto di vista. Storia e discorso, dunque, sono le due categorie necessarie per comprendere la funzione della narrazione. I paragrafi che seguono tratterranno di conseguenza la funzione del personaggio (storia) e il tipo di narrazione (discorso). Per Chatman gli eventi sono «azioni (atti) o avvenimenti, ed entrambi sono cambiamenti di stato […] se l’azione è significativa per l’intreccio, l’agente o il paziente vengono chiamati personaggi». Gli esistenti sono i personaggi e l’ambiente e sono definiti soprattutto per la dimensione spaziale, mentre gli eventi sono definiti nella dimensione temporale: «lo spazio nella storia contiene gli esistenti, così come il tempo della storia contiene gli eventi». La caratteristica fondamentale della categoria degli esistenti è che si riferisce ai personaggi e all’ambiente. Quello degli eventi si riferisce alle azioni e agli avvenimenti. Ivi, p. 42.
[2] Dall’intervista di Marco Spagnoli pubblicata presso il sito Superava.
[3] Racconta Martinelli che l’idea del film nasce dall’incontro casuale con una via di Roma intitolata al colonnello Varisco: «spesso in questo mestiere è il film a scegliere il regista. Le cose capitano quasi per caso. A Roma vicino casa mia, dove per lavoro trascorro molta parte del mio tempo, passo sempre in via Varisco. Lì, c’è un targa. Guardandola e riguardandola mi sono incuriosito, mi sono chiesto chi fosse Antonio Varisco, generale dei carabinieri ucciso dalle Br il 13 luglio del 1979». Il generale Varisco, ricorda lo stesso regista, è uno dei tre uomini, insieme al giornalista Mino Pecorelli e al generale Carlo Alberto dalla Chiesa ad aver preso e analizzato il vero Memoriale di Aldo Moro. Martinelli ricorda che i tre uomini verranno eliminati in circostanze, ancora oggi, poco chiare. Pubblicato su Citi News 9 maggio 2003, http://www2.unicatt.it/unicattolica. Si veda anche Renzo Martinelli, Piazza delle Cinque Lune - Il thriller del caso Moro, Gremese Editore, Roma 2003, p. 9.
[4] Intervista di Emilio Targia al regista Martinelli, pubblicata nel sito di Radio Radicale.
[5] Per la maggior parte degli storici del cinema, la nascita del film politico può identificarsi con il film Salvatore Giuliano di Francesco Rosi del 1962. Il tratto essenziale di questa opera (ma si può rintracciare anche in altri film di Rosi come Il caso Mattei e Lucky Luciano) riguarda la commistione della narrazione (un alto livello poetico ed estetico) con gli elementi storico-giudiziari che riguardano la vicenda del “re di Montelepre”. Il film non ha la pretesa di raggiungere una verità assoluta, ma di “suggerire” una determinata pista giudiziaria attraverso la costruzione di un montaggio serrato e diegetico che si basa esclusivamente sull’accostamento di tempi e spazi diversi, perfino contrastanti. Sul film politico rimando alla mia tesi La rappresentazione del crimine nel cinema di Francesco Rosi: Salvatore Giuliano, il caso Mattei, Lucky Luciano, pubblicato presso lo stesso sito e in particolare ai paragrafi § 4.5 Il film politico, § 4.6 La politicità nei film di Rosi.
[6] Il senatore ha scritto molti volumi sul caso Moro: La tela del ragno, il delitto Moro (sul caso Moro), Fantasmi del passato (la vita politica di Francesco Cossiga), Le trame atlantiche (i poteri legati alla volontà del governo americano, a Gladio e alla P2), Il mio sangue ricadrà su di loro (dove vengono pubblicati tutti i scritti di Moro dal “carcere”), Convergenze Parallele (sulla “minaccia” Moro), Il covo di Stato, Via Gradoli. Tutti i libri sono stati pubblicati con le edizioni Kaos. L’autore ha in oltre aperto un sito http://www.casomoro.it./ in cui promette di inserire documenti inediti sul caso Moro.
[7] Martinelli attribuisce la nascita di questo film attraverso una frase sibillina del venerabile della Loggia P2 Licio Gelli: «lei non sarà così ingenuo da pensare che delle persone maniache della documentazione come le Br non abbiamo filmato il più clamoroso sequestro di questo secolo?». L’idea del film parte proprio da questa frase misteriosa: «e se qualcuno, quello mattina del 16 marzo 1978 avesse veramente filmato con un super 8mm il massacro di via Fani dal terzo piano di un palazzo? E questo qualcuno, ormai prossimo a morire per un tumore, consegnasse il filmato al Procuratore Capo di Siena, promettendogli di portarlo fino al memoriale Moro? Quello originale. Autografo. Completo». Renzo Martinelli, cit., p. 9.
[8] Italo Sordi, Introduzione a Il teatro delle marionette, Brescia 1980, in Philip Willan, I burattinai, Pironti, Napoli 1993, p. 197.
[9] Questa tesi, ormai proposta in ogni libro che tratti il caso Moro, è tuttavia osteggiata da quasi tutti i brigatisti che parteciparono al rapimento e, primo fra tutti, dal “capo anomalo” Mario Moretti, che nell’intervista a Sergio Zavoli afferma: «e’ una accusa che vuole colpire l’autenticità delle Br». Sergio Zavoli, La notte della repubblica. In più di un’occasione, il “capo” brigatista – ma Moretti afferma di essere soltanto uno dei dirigenti e che le Br non avrebbero avuto nessuna struttura gerarchica – afferma che le Br furono soltanto un gruppo armato. Per Moretti gli storici e i giudici si ostinano ancora oggi ad accettare la “purezza rivoluzionaria” di questo gruppo. Da parte sua, il racconto di Martinelli tende ad evidenziare il tratto «anomalo» di questo personaggio.
[10] J. L. Borges, Ficciones, citato da Sciascia, L’affaire Moro, Sellerio, 1978, p. 138.
[11] Come ho osservato nella mia tesi, il regista compie una e vera sostituzione dell’espressione «Ministro Scelba» con quella di «Pubbliche Autorità», evitando, anche astutamente osserva Adam Sitney di provocare conseguenze giuridiche e legali che dovrebbero essere esenti da un “racconto narrativo”. Si veda il paragrafo § 1.10 La sentenza e § 1.11 Le omissioni nel film. A tale proposito – mentre sto scrivendo questa relazione – è doveroso osservare come un altro film Segreti di Stato di Paolo Benvenuti (2003) che tratta direttamente la strage di Portella della Ginestra racconti, attraverso le parole di Pisciotta, l’implicazione politica, mafiosa e “massonica” di importanti uomini di potere. Il film recupera, all’interno di un panorama intellettuale e politico, quella sorta di “autocensura” che Rosi aveva inevitabilmente realizzato quarant’anni prima nel suo film.
[12] Durante il Sciascia Film Festival, lo stesso regista Ferrara è ritornato sui misteri del caso Moro: «ci sono tante cose sul rapimento e sull'uccisione dello statista democristiano - ha detto il regista, autore anche dei film Il sasso in bocca e Giovanni Falcone - che non sono state approfondite: è come se lo Stato abbia voluto depistare, nonostante ufficialmente in tutti questi anni ci siano state tante indagini compiute dagli organi di polizia, accertamenti lunghissimi portati a termine dalle varie Commissioni parlamentari (sulla P2, sul caso Moro, sulle stragi) e cinque processi sulla vicenda Moro: io stesso ho raccolto delle testimonianze e dei documenti esplosivi per arrivare alla identificazione dei mandanti dell'omicidio Moro, che avrebbe avuto la complicità dei servizi segreti, ma nessuno si è preso la briga di andare ad accertare la verità. Non è un caso che tutti quelli che erano chiamati ad indagare sul rapimento di Aldo Moro facevano parte della P2 e che a capo del Governo c'era Giulio Andreotti, appartenente anche lui alla loggia massonica». Giuseppe Scibetta, Un complotto della P2 contro Moro, La Sicilia, 8 aprile 2003.
[13] Philip Willan, I burattinai, Tullio Pironti Editore, Napoli 1993, p. 304.
[14] Ivi, p. 319.
[15] Il professore criminologo Giovanni Senzani è un personaggio strano e oscuro, la cui funzione all’interno delle Br non si è mai chiarita totalmente. Consulente del Ministero della Giustizia, ma il dossier prodotto dal senatore Pellegrino lo definisce un esponente vicino al Comitato Toscano, forse l’uomo misterioso che incontrava lo stesso Moretti, non che probabile “grande inquisitore” dell’interrogatorio di Moro. Tra i molti elementi già noti, citati da Pellegrino, c'e' quello relativo alle carte che il generale Le Winter consegnò anni fa al giornalista Ennio Remondino che stava svolgendo un’inchiesta sulla Cia e la strategia della tensione in Europa. Nelle poche righe si affermava che tra le fila della Cia di Roma si poteva evidenziare il contratto di Senzani. Enzo Fragalà, capogruppo di An della stessa commissione, afferma che sul personaggio di Senzani occorre un approfondimento più dettagliato visto il «ruolo di primissimo piano nella gestione del sequestro Moro». Arrestato dopo la morte di Roberto Peci provocata da una sua ritorsione verso l’ex brigatista pentito Patrizio Peci, gode oggi di regime di semilibertà occupandosi attraverso varie organizzazioni delle condizioni dei detenuti all’interno delle carceri. Nel film non è citato, ma la sua presenza all’interno dell’affaire troverebbe una particolare collocazione nella zona grigia che si situa tra il partito armato e uomini vicini ad Edgardo Sogno. Dal sito /www.almanaccodeimisteri.info/moro2001.htm.
[16] Willan, cit., 320.
[17] Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, prima parte. Tuttavia è doveroso ricordare che la partecipazione di Bonisoli si limita al giorno del sequestro dopodiché, come lui stesso racconta, partì per Milano e non entrò mai nel rifugio brigatista.
[18] A fare menzione di questo fatto è lo stesso Pecorelli che affermerebbe l’esistenza di alcuni nastri magnetici con la voce di Moro. In Willan, cit., p. 301. Si veda anche Flamigni, cit., p. 255. All’inizio del marzo 1992 dagli archivi del Cesis salta fuori una strana registrazione che vede al centro due brigatisti in carcere. Si tratta di un dialogo frammentario, ma diventa chiaro quando si riferisce a Moro: «si lavava quattro volte al giorno, si faceva la barba, la doccia…bastardo! Stava bene, mangiava bene, se voleva scrivere scriveva…. Hanno ancora tutti gli originali e i nastri degli interrogatori». Si tratta di un’ulteriore traccia che confermerebbe l’esistenza di registrazioni visive e sonore di Aldo Moro, oltre che di una diversa condizione logistica del prigioniero. Flamigni, cit., p. 322.
[19] Adriano Sofri, L’ombra di Moro, Sellerio Editore, Palermo 1991, p. 88.
[20] Afferma Martinelli: «l'idea del super 8 me l'ha data Gelli che in un'intervista ha detto: "ma lei non sarà così ingenuo da pensare che persone così maniache della documentazione non abbiamo ripreso il rapimento del secolo?"». Marco Spagnoli, intervista pubblicata presso il sito Supereva.
[21] Il saggio di Lotman evidenzia che il compito principale dell’arte è quello di realizzare l’illusione della realtà: «tutte le forma d’arte si preoccupano in qualche modo di trasmettere al pubblico un senso di realtà». L’esempio della doppia rappresentazione, dello schermo nello schermo, evidenzia lo scarto tra realtà e finzione, «questo duplice rapporto con la realtà crea quella tensione semantica di cui il cinema d’arte si è reso esperto». Jurij M. Lotman, Semiotica del cinema, Edizioni del Prisma, Catania 1994, p.31; 41.
[22] In quest’ultimo ritrovamento Sofri riporta un appunto Ansa sul materiale presente nel rifugio di Milano: 421 fogli di fotocopie delle lettere scritte da Moro, una pistola Ppk 76.5, un mitra di fabbricazione sovietica Pps 7.62 tipo Tokarev, una canna da pistola tipo Brigadier, circa 30 detonatori e una borsa nera contenente circa 60 milioni di lire, provenienti dal riscatto dell’imprenditore Piero Costa. Adriano Sofri, L’ombra di Moro, Sellerio Editore, Palermo, 1991, p. 13. La circostanza del ritrovamento è descritta in Willan, I burattinai, cit., p 315: «un operaio incaricato della ristrutturazione dell’appartamento di via Montenevoso scoprì un nascondiglio segreto di armi e documenti nascosto da un pannello di gesso sotto una delle finestre». Commenta Sofri: «un muro alzato a regola d’arte».
[23] Scrive Moro: «Francamente bisogna dire che non è questo un bel modo, un modo dignitoso, di armonizzare le proprie politiche. Perché quando ciò, per una qualche ragione è bene che avvenga, deve avvenire in libertà, per autentica convinzione, al di fuori di ogni condizionamento. E invece qui si ha un brutale do ut des. IV tema - I finanziamenti alla Democrazia Cristiana, Comm. Moro, 127-128; Comm. stragi, 170-173; Numerazione tematica 4). Memoriale Moro pubblicato presso il sito Apolis. Altrove Moro fa cenno ai contatti di Andreotti coi colleghi della Cia e al fatto che avesse diretto ai servizi segreti tanto dal ministro della Difesa che dal Presidente del Consiglio più a lungo di chiunque altro. Philip Willan, cit., p. 317. Per le citazioni di Sofri si veda L’ombra di Moro, cit., pp. 38-39; 182.
[24] Colpisce in un centro senso l’affinità con il contesto del Pubblico Ministero Luciano Infelisi incaricato inizialmente del caso Moro, il quale non riuscì a coordinare le ricerche in maniera intelligente e decisa: non ricevete aiuto e nessun collega lo affiancò nell’incarico. Willan, I burattinai, cit., p. 247. Tale stato di impotenza, potrebbe rispecchiare la debolezza e l’ingenuità del personaggio del giudice Rosario.
[25] Aldo Moro era nato in Puglia nel 1916 e aveva studiato legge all’università di Bari, dove era stato presidente della Fuci, la Federazione dei Giovani Cattolici di cui, nel 1939, divenne responsabile nazionale. Ricoprì la carica di ministro Grazia e Giustizia nel 1955 e nel 1959 fu eletto segretario della Dc, arrivando poi alla presidenza del consiglio nel 1963. All’epoca del suo sequestro, Moro aveva rivestito quell’incarico in ben cinque diverse coalizioni di governo. La pietra basilare del suo credo politico era la fiducia nel dialogo tra le diverse correnti e la convinzione che tutti i settori dell’opinione pubblica dovessero essere rappresentati in parlamento, per dare piena espressione alla vita politica nazionale. Fu per queste caratteristiche che gli venne affidato il ruolo di mediatore tra Dc e Pci negli anni di crescente tensione politica. All’avanzata elettorale comunista, Moro rispondeva con la proposta di un governo di unità nazionale, l’unico in grado di fornire una valida risposta alla recessione economica e al terrorismo. Il suo piano per un “compromesso storico” col Pci prevedeva che i comunisti sarebbero dovuti passare dalla non sfiducia a un sostegno attivo al governo, per arrivare a una divisione dei compiti di potere che prevedeva la presenza dei comunisti in incarichi di governo. Solo l’amicizia personale esistente tra Moro ed Enrico Berlinguer rese attuabile il progetto, interrotto bruscamente dalla tragica fine dello statista. In un famoso articolo dello statista che doveva uscire su il Giorno all’inizio del 1978 e che venne pubblicato postumo su l’Unita 29 maggio 1978, Moro spiegava che l’alleanza con i comunisti era essenziale per sottrarre l’Italia dalla paralisi politica e terminava il suo articolo con un appello «alla prudenza, all’intelligenza, allo spirito aperto di coloro sui quali ricadono le massime responsabilità». Willan, cit., pp. 237-238; 242.
[26] Per il memoriale di Moro e i comunicati delle Br si veda il sito: http://www.apolis.com/moro/moro/memoriale/indice.htm
[27] Willan, cit., p. 237.
[28] Ivi, p. 27. Martinelli cita una frase dello storico Marc Bloch, tratto dall’Apologia della Storia : «ci sono due modi di essere imparziali: quello dello studioso e quello del giudice. Essi hanno una radice comune: l’onesta sottomissione alla verità». La scelta di costruire il personaggio del giudice attraverso l’hobby delle navi in bottiglia, rappresenta, però, una metafora triste e negativa della ricerca di questa stessa verità: le navi in bottiglia non sono mai destinate a vedere il mare. Nonostante il lavoro paziente e scrupoloso, il procuratore non concluderà le sue indagini e si troverà intrappolato in una rete ancora più grande. Renzo Martinelli, cit., p. 73.
[29] La costruzione del personaggio brigatista corrisponde in gran parte alla tipologia del terrorista che è riuscito ad inserirsi nella società civile e ad evitare le condanne grazie alla falsa identità che gli ha garantito l’impunità. Tuttavia, si tratta di un particolare che il film non esprime chiaramente, ma piuttosto tende a suggerire. Molti terroristi hanno percorso la strana linea di confine tra la lotta armata e la vita civile. Una doppia identità quindi che evidenzia il ruolo stesso delle Br e la sua sostanziale ambiguità con i suoi programmi rivoluzionari e politici. L’epopea violenta e misteriosa di questo gruppo è stata ben sintetizzata dall’ex brigatista Enzo Fontana: «Noi siamo stati come Teseo, siamo entrati in un labirinto di specchi per portare l’attacco al cuore del Minotauro, dello Stato capitalista, imperialista. Il Teseo sovversivo si è nutrito mentre avanzava per il labirinto, di logiche astratte, di parole, di armi, di carne umana, lo stesso nutrimento del Minotauro. E finalmente lo ha trovato, non era al centro di niente, ma c’era, c’era uno specchio che rifletteva un Teseo mutato, più armato e feroce di quello che aveva iniziato l’avventura. Teseo era entrato nel Minotauro e il Minotauro in Teseo, dove per la verità era sempre stato». Willan, cit., pp. 218 - 223.
[30] «L’atto udito di parole come componente dell’immagine visiva fa vedere qualcosa in tale immagine». Non solo: non si accontenta di far vedere, ma succede che esso stesso vede. Si tratta di evidenziare quello che Deleuze, Comolli e Chion hanno individuato nei loro studi sull’atto parlato all’interno del film, in cui «l’atto udito di parola è esso stesso visto». È quello che succede nella scena del Super8 in cui lo spettatore, oltre a vedere il filmato nella sua scansione diretta e oggettiva, è guidato dalla voce fuori campo di Rosario, in modo tale da volgere l’attenzione su alcuni aspetti di quel filmato. Da questo punto di vista la voce fa da guida, opera una sorta di montaggio dell’attenzione che in questo caso è fondamentale per realizzare l’indagine. Gilles Deleuze, L’immagine – tempo, Ubulibri, Milano 1989, pp. 256 –257.
[31] Il film cita la targa diplomatica, ma evita di approfondire dettagliatamente la sua storia. Si tratta della targa CD 19707 che risulterà rubata l’11 aprile 1973 dalla macchina dell’addetto militare venezuelana, Aquimedez Guevara Alcalà. La stessa targa venne rilasciata da un altro addetto militare il dottor Heliodoro Clavarie Rodriguez che la restituirà al ministero dei trasporti nel gennaio 1978. La targa verrà successivamente assegnata ad una Fiat 124. Nella relazione di maggioranza della Commissione si legge: «ha lasciato perplessità il fatto che non è stato accertato quando la targa di plastica con lo stesso numero di quella rubata, sia stata assegnata al secondo diplomatico venezuelano e perché sia stata ristampata in plastica una targa rubata e assegnata di nuovo alla stessa ambasciata». La macchina dei terroristi con questa targa venne notata a Roma e ogni mattina, nei giorni a ridosso del 16 marzo, compiva evoluzioni di “prova” lungo la via dell’attentato. «Ma è stata vista anche nei pressi dell’abitazione di Moro, in via Trionfale, in altre strade del quartiere, a Porta Pia, all’aeroporto di Ciampino, sul Lungotevere, a Piazza del Popolo, persino ferma davanti all’ambasciata dell’Iraq: quando due uomini di circa trent’anni vi salirono». Mimmo Scarano, Maurizio De Luca, Il mandarino è marcio, cit., pp. 81-82.
[32] Per quello che concerne i nomi dei brigatisti che hanno partecipato alla strage di via Fani, esistono ancora dei dubbi giudiziari. Ufficialmente furono: Prospero Gallinari, Valerio Morucci, Franco Bonisoli e Raffaele Fiore che, vestiti da avieri, aprono il fuoco sulle auto; Mario Moretti, alla guida della 128 che blocca, facendosi tamponare, le vettura con a bordo Moro; Barbara Balzerani, Alessio Casimirri e Alvaro Loiacono, che bloccano il traffico; Bruno Seghetti che guida la 132 sulla quale il leader Dc viene portato via, e Rita Algranati, che ha l'incarico di segnalare l'arrivo di Moro e della scorta. Cronologia, Vladimiro Satta, Odissea nel caso Moro, Edup, Roma 2003. Il testimone Antonio Marini avrebbe riferito di una moto Honda con due persone a bordo, una delle quali armata, che avrebbe sparato contro un passante. I brigatisti hanno sempre negato la presenza di questo mezzo. Sul numero preciso dei brigatisti in via Fani esistono ancora alcuni, come anche sulla dinamica balistica. Il gruppo di azione oscilla da un numero di nove elementi (Morucci) ad un numero di undici, se si tiene conto della moto Honda. Anche altri testimoni, Paolo Pistoiesi e Giovanni Intrevado, parlano di una moto. Molti testimoni, quindi, la cui versione processuale entra nettamente in contrasto con le smentite dei brigatisti.
[33] Le deposizioni di Moretti e di Morucci relative all’impatto sono raccolte nel processo Morouno (p. 28 dove si legge che la macchina si è arrestata per «l’inopinato impedimento») e Morobis e nel Moroquater (p. 31; 38). La sintesi dei processi è scaricabile presso il sito www.apolis.it.
[34] Un ulteriore versione di questo tamponamento è rintracciabile nel libro intervista di Carlo Mosca - Rossana Rossanda, Mario Moretti – Brigate Rosse, una storia italiana, Anabasi Tascabili 1994, pp. 127-128.
[35] Gli elementi qui descritti sono tratti esclusivamente dal film in questione. Il libro Piazza delle Cinque Lune, evidenzia meglio la deposizione di Moretti e del Memoriale di Morucci. Quest’ultimo cita letteralmente la parola “tamponamento”; Moretti afferma di aver dovuto tenere premuto il freno causa del “doppio” tamponamento della 130 di Moro. R. Martinelli, cit., pp. 38-39. Nella ricostruzione filologica della scena, Martinelli osserva la foto originale del tamponamento della strage di via Fani concludendo che la mancanza di frenate sull’asfalto e la mancanza di graffi e ammaccamenti sulla macchina di Moretti, indicano chiaramente la falsa versione dei brigatisti e sollevano una domanda: perché i brigatisti hanno mentito circa la dinamica del sequestro? La foto originale, relativa al “mancato” impatto, è pubblicata nel libro Piazza delle Cinque Lune, cit., p. 43.
[36] Il regista ha utilizzato l’Arriflex 16mm SR, con un’ottica 10 – 100mm Zeiss che permette di avere al tempo stesso o un grandangolare o un teleobbiettivo. Il linguaggio adottato è quello del piano sequenza, dove la macchina da presa non stacca mai, ma segue l’evento in presa diretta. La costruzione della scena non ha bisogno, quindi di essere montata. L’utilizzo dello Zoom sui momenti chiavi della strage, il prelevamento del prigioniero, la presenza di Camillo Guglielmi, evidenzia un linguaggio ricco di panoramiche veloci, arresti improvvisi, sbandamenti che comunicano chiaramente la drammaticità dell’evento, ma anche lo stato d’animo di chi avrebbe ripreso il sequestro. Questa scelta di linguaggio attribuisce alla scena una verosimiglianza, ovvero finisce per essere assimilata come vera pur essendo di finzione. Questo grazie al “rigore filologico” che il regista ha voluto perseguire. Tutti gli eventi sono tratti dai resoconti dei brigatisti e dalle varie deposizioni: il capello dell’aviere che spara da sinistra e che cade, la posizione delle macchine, la sparatoria. Tutto questo è stato ricostruito attraverso un rigore filologico dell’attentato. È ed proprio da questa ricostruzione che Martinelli si accorge dell’inconciliabilità tra le versioni di Morucci e di Moretti e la dinamica dell’incidente. A livello tecnico, per simulare la grana del super8, la scena ha dovuto subire una modifica in postproduzione da sembrare più invecchiata e degradata. R. Martinelli, cit., pp. 26; 48.
[37] Eleonora Moro, Comm. Parlm., 1 agosto 1980, Scarano - De Luca, Il mandarino è marcio, cit., p. 72.
[38] Martinelli, cit., pp. 38 - 43.
[39] È doveroso osservare che il lavoro di Satta, che può essere valutato come la controparte dell’inchiesta portata avanti dal film, non fa nessuna menzione di questo mancato tamponamento. L’unica circostanza trattata è invece quella relativa al tamponamento della macchina di Moro con la stessa scorta, indicando una sorta di «imperfezione» e di «dilettantismo» della stessa scorta, colta dall’effetto «sorpresa» e per questo «inefficiente» alle risposte del fuoco nemico. Questo fatto spiegherebbe la libertà operativa degli stessi brigatisti. Vladimiro Satta, cit., pp. 7-8.
[40] Il maggior contributo, relativo al misterioso superkiller, viene dal testimone Lalli e dalla stessa perizia balistica messa in evidenzia dal libro inchiesta di Zupo – Recchia, Operazione Moro, Franco Angeli 1984. Da parte sua, Satta sostiene che non è possibile parlare di un superkiller, visto e considerato che le pallottole sono state sparate da due armi diverse e quindi si può parlare, più giustamente, di «due killer normali», appunto due terroristi. In oltre, visto e considerato che nessuno dei brigatisti parla di questo presunto superkiller, Satta sostiene che non c’è ne motivo e ne utilità di pensare che i terroristi debbano mentire su questa dinamica. Per tanto non esisterebbe nessun superkiller. Satta, cit., pp. 9-10.
[41] Ivi.
[42] Ivi.
[43] Philip Willan, cit., p. 11. Su questo aspetto è tornata la Commissione Stragi. Oggetto del dibattito: un appunto del ‘78 della Questura di Roma nel quale si affermava che alcuni bossoli rinvenuti a Via Fani proverrebbero da "un deposito dell’Italia settentrionale le cui chiavi sono in possesso di sole sei persone". Sulla base di questo documento, il figlio di Moro, Giovanni, ha chiesto che venga fatta "immediata chiarezza". Mauro Bottarelli, La Padania, 28 ottobre 1999.
[44] Nel punto relativo ai collegamenti internazionali, della Relazione di maggioranza della Commissione di Inchiesta, si nega categoricamente la presenza di uno “straniero” la mattina del 16 marzo in via Fani. E aggiunge: «tutti i brigatisti interrogati sono stati concordi nell'escludere tassativamente ogni presenza straniera in via Fani e nella gestione del sequestro ed hanno riferito che le voci circolate in proposito erano state oggetto, all'interno dell'organizzazione, di divertiti commenti». Questo fatto, secondo la relazione, sarebbe evidente nella stessa risoluzione strategica n. 6, «laddove orgogliosamente si afferma che in via Fani non c'erano misteriosi 007 venuti da chissà dove, ma avanguardie politiche tempratesi nella lotta della classe operaia e addestrate nei cortili di casa».
[45] Eleonora Moro, Comm. Parlm., 1 agosto 1980, Mimmo Scarano, Maurizio De Luca, Il mandarino è marcio, cit., p. 72.
[46] Scarano De Luca, cit., p. 73.
[47] Eleonora Moro, Commissione Parlamentare, in Scarano – De Luca, cit., p. 79.
[48] Ivi, p. 80. L’evento è chiaramente raccontato nel film Il caso Moro.
[49] Ivi, p. 81, da deposizione dell’agente Otello Riccioni in Comm. Parl, 21 maggio 1981, raccolta dal senatore Sergio Flamigni.
[50] Ivi, p. 79.
[51] Il dialogo avviene tra un generale presente in via Fani e la moglie di Aldo Moro, Eleonora. La donna fa notare che una delle borse è stata portata via da poco tempo: «se tutte e tre le borse fossero state portate via allo stesso istante, anche li, dove invece è pulito, sarebbe colato il sangue». Il generale, di contro, conferma la versione dei presunti testimoni che avrebbero affermato che le borse sarebbero state portate via dalla Brigate Rosse. La sorpresa della donna è immediata: «le Br ? Come fate a saperlo? O avete dei testimoni anche per questo?». Il generale si toglie dall’impaccio scusandosi e allontanandosi molto freddamente.
[52] Eleonora Moro con estrema sorpresa dichiarerà nella stessa Commissione: «ma come! Il giorno prima c’è il Capo della polizia a dire che in via Savoia sono soltanto scippatori e il giorno dopo in via Fani mi dice sicuro: “Sono Brigate Rosse?”». Scarano – De Luca, cit., p. 88.
[53] Si tratta di una delle prime lettere di Moro, la numero 4, scritta tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, spedita a sua moglie Noretta, ma non racapitata.
[54] Osserva Willan che forse per questo motivo la lettera non venne consegnata: «renderla pubblica avrebbe significato ammettere che Moro era tenuto all’oscuro della sorte dei suoi documenti e avrebbe potuto generare sospetti sull’intera conduzione del sequestro». Willan, cit., p. 298.
[55] Eleonora Moro, Commissione Parlamentare, in Scarano – De Luca, cit., p. 72.
[56] L’intervista è presa dal programma televisivo La notte della Repubblica di Sergio Zavoli. Qui viene sollevato un altro mistero: se le Br stanno mentendo significa che stanno alterando la veridicità dei fatti coprendo qualcosa che ancora oggi rimane all’oscuro delle indagini; se invece stanno affermando la verità, si avrebbe la tentazione di interpretare il 16 marzo come un giorno in cui i terroristi sarebbero stati “controllati” e “protetti”, probabilmente a loro insaputa, da un gruppo di potere non meglio identificato, che si sarebbe assicurato l’accadimento degli eventi. In entrambe le circostanze la vicenda del sequestro Moro rimane ancora poco chiara. Ma si tratta di un ipotesi priva, al momento, di prove oggettive e dimostrabili.
[57] Direttore della rivista scandalistica dal titolo Osservatore Politico (OP), Pecorelli iniziò la sua attività come avvocato specializzato in diritto commerciale che ben presto abbandonò per darsi interamente al giornalismo, sfruttando le informazioni apprese nel mondo politico e finanziario in articoli ricattatori scritti in un linguaggio ermetico e allusivo, spesso comprensibile solo da pochi iniziati appartenenti a questo o a quel centro di potere. Inizia con Paolo Senise (figlio di Carmine Senise, capo della polizia fascista) direttore del Mondo d’oggi (nella redazione c’era anche Nino Pulejo che aveva aiutato il principe Valerio Borghese a nascondersi dai partigiani su richiesta di James Angleton). Il primo lavoro insieme a Nicola Falde (ex servizi segreti militari) fu la campagna di diffamazione contro il nucleo operativo dei servizi segreti diretto da Gianadelio Maletti per conto di Vito Miceli. La sua attività molto presto si rivelò legata al ricatto politico per estorcere denaro, come affermò Federico Umberto D’Amato alla commissione P2. Tra i suoi articoli vengono di frequente trattati i personaggi politici come Giulio Andreotti, Michele Sindona, Guido Giannettini, Antonio Viezzer, e tutti i personaggi dell’affaire Moro, brigate rosse comprese. Willan, cit. pp. 95-100. Secondo la tesi portata avanti dal film, Pecorelli venne eliminato perché era a conoscenza di elementi particolarmente gravi riguardo al sequestro e alla morte di Moro.
[58] Ivi, p. 257.
[59] Ivi, p. 258
[60] «Gli americani, secondo questa interpretazione, non avrebbero interferito nell’invasione sovietica della Cecoslovacchia e dell’Ungheria e, conseguentemente non avrebbero tollerato l’ingresso di un partito comunista nel governo di un paese occidentale. L’Unione Sovietica, per parte sua, avrebbe accettato l’impossibilità di un governo comunista in Italia e, se necessario, l’intervento militare americano per impedirlo. Quando alla fine degli anni Settanta si avanzò l’ipotesi di una coalizione di governo tra democristiani e comunisti, il governo e sovietico e quello americano si allertarono, anche se per motivi diversi: i sovietici infatti, preferivano che il Pci restasse all’opposizione, piuttosto che vederlo allineato con l’ideologia occidentale in un governo di coalizione». Willan, cit., 23-24.
[61] Ivi, p. 259.
[62] In riferimento alla divisa di avieri, Pecorelli scrive una delle sue lungimiranti allusioni (le uniformi di aviere saranno scoperte nel covo di via Gradoli): «non saranno infatti andati in elicottero a deporre Moro?». Sembra un modo per indicare ancora una volta la complicità dello Stato nel sequestro. Questo elemento coincide con la testimonianza di un medico che vide due della vetture delle Br la mattina del sequestro nei pressi di via Fani e contemporaneamente (9.10 – 9.20) sentì un rumore di elicottero, quando in realtà questi si levarono soltanto dopo le 9.30. Willan, cit., p. 267, da Sergio Flamigni, La tela del ragno.
[63] Willan, cit., pp. 346-348, dal libro di Licio Gelli, La verità.
[64] Tuttavia la sua deposizione è da considerarsi ancora ricca di lacune e per questo non pienamente attendibile. Proprio negli ultimi giorni, immediatamente precedenti l'assassinio dell'onorevole Moro, si colloca il tentativo di ottenere un'intervista sulle condizioni di Moro. Dopo il decesso di Moro, Viglione continuò ad avere contatti con un misterioso e anonimo brigatista, il quale aveva dichiarato il vero obiettivo delle Br non era di uccidere Moro, come invece avrebbero voluto certe forze politiche. Lo sconosciuto, individuato in Pasquale Frezza, avrebbe richiesto somme di denaro per portare avanti l'azione. Viglione stesso chiese al generale Dalla Chiesa la somma di 2 milioni da passare al "brigatista pentito", senza però ottenerla. Viglione consegnò a Frezza somme in franchi francesi e in lire italiane. In seguito avrebbe scoperto che Frezza aveva precedenti manicomiali; ma non ritenne di doverne parlare col generale Dalla Chiesa per non screditare quanto in precedenza affermato. Essendosi proceduto penalmente, i personaggi coinvolti nella vicenda, Pasquale Frezza e lo stesso Ernesto Viglione, sono stati condannati per reati vari, oltre che per truffa (30 giugno 1980). L'eloquente vicenda giudiziaria - i cui atti sono stati acquisiti dalla Commissione - ha suggerito l’inopportunità di ulteriori approfondimenti». Dalla Commissione Parlamentare, Il caso Moro, Capitolo 5, p. 83.
[65] Willan, cit., p. 76.
[66] Benito Cazora fu il deputato democristiano che tentò, attraverso la malavita calabrese, di scoprire il covo della prigionia di Moro. Sereno Freato fu il segretario di Moro. Quei fotogrammi furono al centro di strani interessamenti da parte della 'ndrangheta, l’organizzazione criminale calabrese che non sembra aver avuto dei punti di contatto con l’attività brigatista. La telefonata di Cazora affermava che gli sarebbero servite le foto del 16 Marzo «Si, perché loro... [nastro parzialmente cancellato]...perché uno stia proprio lì, mi è stato comunicato da giù […] Dalla Calabria mi hanno telefonato per avvertire che in una foto preso sul posto quella mattina lì, si individua un personaggio... noto a loro […] una copia, capito, può darsi che stia sui giornali del 16 o 17 marzo». Ivi, p. 288.
[67] Scarano -De Luca, cit., p. 88.
[68] Le testimonianze relative alla macchina blindata giungono anche dalle vedove del resto della scorta, Ileana Leonardi e Maria Ricci. Ivi, p. 88.
[69] Da l’avvocato Giuseppe Zupo, parte civile dei due agenti, Rivera e Zizzi, morti in via Fani. Scarano – De Luca, cit., p. 87. Una segretaria dell'ambasciata del Libano in Italia denunciò che nei giorni 8 e 9 maggio 1973 era stata seguita da un'auto con a bordo una persona, identificata poi per Franco Moreno. Il fatto aveva suscitato apprensioni nella signora poiché lo stesso 9 maggio l'usciere dell'addetto militare dell'ambasciata era stato avvicinato da uno sconosciuto che, promettendo soldi, avrebbe chiesto di conoscere gli spostamenti dell'ambasciatore.
[70] La testimonianza è di Marco Tarditi, ex agente di polizia, il quale riconosce le sirene vendute al Moreno, dopo l’eccidio di via Fani. Scarano - De Luca, cit., p. 86. La mattina del 17 marzo, il Moreno venne fermato dalla pubblica sicurezza in relazione al sequestro Moro, ma tre giorni dopo egli venne rilasciato dal sostituto procuratore dottor Infelisi che ha dichiarato alla Commissione «di avere approfondito con sicurezza la posizione di Moreno prima di disporne il rilascio. La figura di Moreno ha, peraltro, alimentato perplessità. Egli è stato seguito per mesi, e nonostante non sia emerso nulla di specifico in relazione ai fatti di via Fani, nessuna spiegazione è stata fornita dagli inquirenti sul suo interessamento per le finestre dello studio dell'onorevole Moro». Commissione Parlamentare, pp. 23 – 24.
[71] De Luca – Scarano, cit., p. 87.
[72] Rientrano in questo tipo di “indizi” gli articoli di Pecorelli: Moro ha deciso, molla, titolava Pecorelli una nota dell’agenzia del luglio 1975 «…per il momento tutti i commentatori politici si esercitavano con l’interrogativo. E’ proprio il solo Moro il ministro che deve morire alle 13?». Il riferimento di Pecorelli era nel libro scritto da Giulio Andreotti, Ore 13, il ministro deve morire. Si tratta di un racconto che sembra alludere al futuro presidente del governo di unità nazionale, basato sulla storia dell’assassinio di Pellegrino Rossi, ministro di Pio IX, perpetrato non si sa se da un killer della Curia, o da una potente massoneria laica, dai francesi che non gradivano un governo liberale in Vaticano, o dai rivoluzionari contestatori della Roma ottocentesca. L’articolo riporta un’espressione da enigmistica, Moro…bondo che evidentemente sta per “moribondo”. In un altro articolo dell’ottobre ’75, Pecorelli scrive della riunione del Consiglio Nazionale democristiano nel quale prenderà parte anche Moro, «se vivrà ancora». Sono tutti elementi chiaramente “profetici”. De Luca – Scarano, cit. pp. 95-97.
[73] Il detenuto dichiarò in seguito che la sua fonte sarebbero stati alcuni colloqui con i brigatisti Olivieri, Buonavita e Socci che gli avevano esternato una possibilità di sequestrare un’alta personalità dello Stato al fine di chiedere la liberazione di detenuti politici». Ivi, p. 98.
[74] Ivi.
[75] Il detenuto Senatore, appartenente ai Nap (Nuclei Armati Proletari) aveva rapporti epistolari con Renato Curcio e con Giovanni Marini. Ivi, p. 99.
[76] A questa lista si unisce la notizia che giunge a Craxi attraverso Willy Brandt (segretario del partito socialdemocratico tedesco). Ivi, p. 100. Moro era nel mirino del terrorismo internazionale. Nel testo, che la polizia olandese trovò in un covo terrorista, Moro figurava come uno dei possibili obiettivi con il nome di Alter Mann, appunto le sue iniziali. Craxi dichiarò che l’espressione “uomo vecchio” si riferiva proprio allo statista democristiano. Ivi, pp. 100-101.
[77] Ivi, p. 103.
[78] Testimonianza dell’insegnante Fanny Bufalini. Ivi.
[79] Ivi.
[80] Commissione Parlamentare, pp. 25- 26.
[81] Ivi, pp. 106-107.
[82] Per Satta non esistono dubbi: l’ufficiale Camillo Guglielmi non era in via Fani bensì nella vicina via Stresa, non era in servizio, ma in ferie e non era in forza al Sismi, nel quale sarebbe entrato mesi più tardi. Dunque si tratta di una presenza casuale che non va collegata con il sequestro di Moro. Lo stesso Satta riporta nelle note l’articolo di Cipriani (L’Unità, 6 giugno 1991), in cui il colonnello Guglielmi avrebbe offerto delle versioni ambigue e spesso in contraddizione riguardo alla sua presenza in via Stresa. Per Satta si trattò di un errore giornalistico sulla cui scia si inserirono tutti gli altri quotidiani. Le dichiarazioni del Guglielmi al magistrato Luigi de Ficchy si concentrarono soprattutto sull’incontro fissato con il colonnello D’Ambrosio in via Stresa 117 per le 9.30 del mattino. La sua presenza è data soprattutto da questo fattore. Si è trattato per tanto di una pura coincidenza. Tuttavia, necessiterebbe maggior chiarezza la testimonianza del paracadutista ed ex-appartenente al Sismi Pierluigi Ravasio, che avrebbe affermato che il colonnello Guglielmi nel 1978 avrebbe già fatto del servizio segreto militare, cosa negata dallo stesso interessato. Gli unici misteri, secondo Satta, sono quelli relativi a dove alloggiasse il Guglielmi e se era a piedi o in macchina. Satta, cit., pp. 158-161; 228; 408.
[83] Quella dello sciacquone difettoso sembra essere una sorta di “tecnica” che avrebbe perseguitato il destino dei brigatisti. La scoperta del covo di via Scarenzio numero 6, nella periferia di Pavia, avvenuta nel 24 dicembre del 1975, ricorda in modo inequivocabile la modalità della scoperta del covo di via Gradoli. Anche in questa circostanza, la polizia trovò in bella mostra timbri targhe false, radio ricetrasmittenti e banconote per circa 4 milioni. Gli inquilini di questo appartamento sarebbero stati i brigatisti Fabrizio Pelli, Susanna Ronconi, e forse, Curcio, Alunni e Moretti. Flamigni, cit., pp. 160- 161.
[84] Per la parte relativa alla scoperta del covo di via Gradoli, rimando ai paragrafi seguenti.
[85] Su questa informazione si veda l’audizione Scialoja in Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Terrorismo.
[86] Si veda l’articolo Via Gradoli e alcuni nomi della P2: www.supereva.it/elezioni.freeweb/morop2.ht
[87] Willan, cit., p. 275.
[88] De Luca – Scarano, cit., pp. 264-265.
[89] Per il documento De Luca – Scarano, cit., p. 265.
[90] Willan, cit., pp. 273-275.
[91] Ivi, p. 255.
[92] «Caro Licio… anche nella Famiglia è venuta meno la solidale assistenza dei suoi componenti… Esistono per caso fratelli di serie A ed altri di serie B?… Nella constatazione di siffatta disparità ti rassegno la mia irrevocabile decisione di uscire definitivamente dall’Organizzazione». Ivi, p. 271.
[93] Il mandante della morte di Pecorelli resta ancora oggi avvolta nel mistero più fitto. Lo stesso Andreotti, uscito illeso da un processo a suo carico, è stato accusato di essere il mandante della sua eliminazione. Secondo la deposizione di Angelo Izzo, l’esecutore materiale dell’omicidio fu Valerio Fioravanti, il quale, avrebbe ucciso anche Mattarella. Ma si tratta di dichiarazioni che non hanno trovato una conferma giudiziaria. Willan, cit., pp. 99; 207-271. A collegare la morte di Pecorelli, a quella del generale Dalla Chiesa è il boss mafioso Tommaso Buscetta: la loro eliminazione sarebbe avvenuta per evitare la diffusione di particolari interessi che sarebbero legati al senatore Giulio Andreotti. Dal programma televisivo Mixer su Aldo Moro. Si veda, in oltre, Pino Arlacchi, Addio Cosa Nostra, Bur 1996, p. 206.
[94] Ivi, pp. 266 -268. Tale ipotesi è avanzata dagli autori De Luca e Scarano. Le Br assumerebbero diverse identità a seconda delle opportunità strategiche che gli si sarebbero presentate. La prima volta con Ronald Stark che avrebbe descritto i diversi livelli di clandestinità di tale organizzazione; la seconda volta con la falsa scoperta di Via Gradoli, dove viene trovato il bossolo 7, 65 parabellum Sako, appartenente a chi aveva sparato al lato destro della macchina di Moro, che viene poi fatto “misteriosamente” sparire; la terza volta con il falso comunicato del Lago della Duchessa, la cui genesi è di matrice sconosciuta, come la partecipazione di Chichiarelli; la quarta volta con il comunicato numero 10, maggio ’78, al cui interno c’è una messaggio in codice militare; la quinta volta con il messaggio radio-televisivo intercettato dal Sismi nella redazione del Gr2 in cui si annunciava con la morte di Moro 34 ore in anticipo (ma il messaggio era stato dato dai brigatisti al parroco della Val Di Susa, alle 23.30 del 7 maggio con l’espressione “il mandarino è marcio”); la sesta volta con il borsello dimenticato da Chichiarelli che alluderebbe a misteriose complicità. Si tratta di circostanze diverse e distanti tra loro, che da una parte insisterebbero sulla dubbia identità delle Br, e dall’altra evidenzierebbero la presenza di una regia occulta dietro gli stessi brigatisti.
[95] Willan, cit., p. 275.
[96] Stranamente si aprì una pista internazionale: due successive rapine alla sede londinese e a quella parigina della stessa Brinks fanno sospettare che all’interno della multinazionale esistessero dei contatti che andavano ben oltre la corruzione di qualche guardia. Ma su questa pista non sembra essere sviluppata nessuna indagine precisa. Ivi.
[97] Testimonianza di Gaetano Miceli, Willan, cit, p. 283.
[98] Il biglietto apparteneva allo stesso Chichiarelli invitato a Messina per il matrimonio di un maggiore dei carabinieri, suo amico, Raffaele Imondi. Ivi, p. 284.
[99] È opportuno ricordare che il caso Chichiarelli costituisce uno dei misteri del caso Moro, anche per lo stesso Satta, in quanto non si conosce l’identità di chi lo ingaggiò per fargli confezionare il falso comunicato. Satta, cit., p. 424.
[100] Deleuze, cit., p. 115.
[101] Di fronte ad una nota inquadratura del film Ivan il terribile di Sergej Ejzenstejn, Barthes rintraccia un primo livello di comunicazione (lo scenario, i costumi, i personaggi ecc.); un secondo livello di significazione, rappresentato dagli elementi all’interno dell’inquadratura che possono avere un significato simbolico (nel caso specifico la pioggia d’oro che “inizia il giovane zar); un terzo livello “ostinato”, “ieratico”, il quale indica propriamente la significanza dell’immagine, il senso ottuso, «ciò che è smussato, di forma arrotondata», il quale rappresenta una sorta di valore aggiunto al senso ovvio della stessa, che ha a che fare anche con il travestimento o con la percezione estetica della stessa. Per la prima volta appare in Cahiers du Cinema del luglio 1970, n. 222. Poi nel libro L’ovvio e l’ottuso. Qui dalla raccolta di scritti Roland Barthes, Sul cinema, Il melangolo, Genova, 1997, pp., 115-134.
[102] Da questo punto di vista, il film drammatizza il contesto famigliare non solo per un fine spiccatamente narrativo, ma anche per “raccontare” il metodo assolutista e violento del Potere pronto a distruggere gli effetti e i propri cari. Nasce spontaneo una sorta di parallelismo tra il senso e il valore della famiglia descritto nel film e l’importanza che lo stesso Moro dava alla sua e il dolore di Eleonora Moro e dei suoi figli. L’importanza della famiglia affiora soprattutto dalle 86 lettere che Moro spedisce dal carcere brigatista attraverso espressioni affettuose, protettive e rassicuranti. Questo va detto contro chi non ha esitato ad accusare il «cinico» politico di Maglie come uomo freddo e razionale, dedito al potere e al controllo del partito. In particolare si veda Alfredo Carlo Moro, fratello dello statista che, mentre indaga sui tanti buchi neri dell’affaire, ricorda la campagna denigratoria contro lo stesso Moro da parte di Massimo Fini, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Flaminio Piccoli. Alfredo Carlo Moro, Storia di un delitto annunciato -Le ombre del caso Moro, Editori Riuniti.
[103] La “casuale” scoperta del covo di via Gradoli e il falso comunicato numero sette, hanno avuto una funzione precisa nel sequestro Moro. Per Flamigni, tale funzione è rappresentata da un vero e proprio linguaggio in codice diretto allo stesso Moretti da parte di chi controllava gli eventi del sequestro. Sono due eventi plateali e spudoratamente “costruiti” da divenire un vero e proprio “monito” a Moretti, una decisa accelerazione del sequestro in senso definitivo. Flamigni, cit., pp. 226; 230.
[104] Dal sito http://www.kaosedizioni.com/nov_covo_sintesinotizie.htm
[105] Flamigni, La tela del ragno, Kaos, pp. 274-276.
[106] Le informazioni sono tratte da un’intervista di Lorenzo Baldo a Sergio Flamigni a cura dal sito Terzomillennio.
[107] Satta, cit., pp. 179-180.
[108] Da un articolo del 1 maggio 2003 pubblicato sul sito Clorofila.
[109] Ivi.
[110] La relazione conterrà alcuni punti importanti. Il primo riguarda l’ipotesi iniziale che non fossero le Brigate Rosse a gestire il sequestro Moro: il rapimento è stato fatto «maniera estremamente pulita, il che contrasta con il normale operato di gruppi terroristici». Subito dopo si esclude la possibilità che la sigla Br possa essere stata utilizzata da un altro gruppo. Nella relazione Pieczenik si chiede perché la famiglia dello statista "insista sullo scambio politico; cerca un sistema per «controllare i magistrati»: suggerisce alcuni metodi per destabilizzare le Br (simulare la morte di Curcio, una ricompensa per liberare Moro). In oltre consigli di sgonfiare il “caso” sulla stampa e mantenere unita la Dc; di contro chiede di dividere il gruppo di alti esponenti della politica da gruppo strategico operativo. Dal sito Almanacco dei misteri.
[111] Willan, cit., p. 268.
[112] Le accuse recenti di Pieczenik in riferimento alle inattività dei Comitati, mette in evidenza il clima di incertezza e di debolezza nei confronti delle stesse indagini. Si veda l’articolo del Corriere della Sera del 18 marzo 1998.
[113] Gli elementi che compongono il comitato fanno sovente dichiarazioni contraddittorie e strane. Le parole di critica del Sottosegretario agli Interni Lettieri (30 marzo) sono ritrattate il giorno dopo. Il generale Santovito (capo del Sismi) chiama in causa elementi indiziari fino ad oggi estranei a tutta la vicenda (una nave che proverebbe la pista turca; una radio di Rimini che trasmetterebbe messaggi contro Moro; una misteriosa abitazione in via Aurelia). Il generale Giudice (finanza) afferma della difficoltà di controllare i contratti di affitto; e lo stesso fa il capo della polizia Parlato il quale lamenta la possibilità di trovarsi documenti falsi, inutili al fine delle indagini. Fa riflettere l’indagine di Giudice relativa alla zona nord di Roma, nei pressi di Monte Mario e il riferimento di un paesino vicino Viterbo (sembra un riferimento a Gradoli di cui però ancora non si fa nome). In sostanza il summit degli apparti dello Stato si mostra davvero molto poco «tecnico operativo». De Luca - Scarano, cit., pp. 178 – 180.
[114] Aldo A. Mola, Storia della massoneria italiana, Bompiani, Milano 1994, p. 774. Propaganda Due, loggia massonica “deviata” fondata da Licio Gelli. La sua scoperta avviene presso lo stabilimento di Castiglion Fibocchi il 17 marzo del 1981 su mandato dai magistrati Viola, Colombo e Turone del tribunale di Milano per presunta estorsione continuata ai danni di Cuccia Enrico e Latri, in concorso con Michele Sindona e Latri». Dopo dieci anni di indagine il giudice istruttore Francesco Monastero accoglie le richiesta del pm: gli affiliati «volevano modificare i poteri costituivi dello stato e la costituzione stessa». I reati degli affiliati, che in tutto sono 16 compreso Gelli, sono: spionaggio, cospirazione politica mediante associazione, milantanto credito, rivelazione di segreti di stato, attentato contro la costituzione. Tra i nomi ci sono quattro ministri, tre sottosegretari e 38 parlamentari. Tale collusione fece cadere il governo tenuto da Arnaldo Forlani. Giuseppe Muratori, Enciclopedia dello spionaggio, edizioni attualità del parlamento Roma, 1992.
[115] Per la prima volta si fanno i nomi degli appartenenti alla Loggia P2. Si tratta di un organigramma che mostra tutti coloro che presero parte alle indagini di Aldo Moro: Giuseppe Santovito (Sismi), Gen. Giovanni Grassini (Sisde), il Prefetto napoletano (Cesis, il quale prenderà il posto di Walter Pelosi, l’unico che non fa parte della Loggia e probabilmente per questo motivo viene sostituito), Gen. Raffaele Giudice (Guardia di Finanza), Senatore Donato Lo Prete (Capo S.M. della Finanza). Tra i collaboratori del direttore del Sismi si vedono i nomi del Col. Musumeci (Capo uff. Controllo e Sicurezza), Col. Domenico Scoppio (Capo Sios – esercito), Ten. Col. Sergio Di Donato (gestione fondi del comitato), e il suo vice Mario Salacone. Tra i collaboratori del Sisde si vedono i nomi del Magg. Rizzuti (Capo Divisione Affari), Terranova (Vice capo del centro Sisde di Firenze) e il Vicequestore Emilio Coppa (Vicecapo Divisione). Si tratta di nomi che si leggono a chiare righe all’interno della scena. Attraverso l’organigramma l’indagine si concretizza: i nomi eccellenti comprovano le responsabilità giudiziarie e danno un valore aggiuntivo alla stessa opera. Il cinema dell’organigramma viene applicato come recupero della memoria e come impegno civile attraverso un altro film recente, Segreti di Stato di Paolo Benvenuti. Attraverso una sequenza di nomi “eccellenti” il film spiega l’ipotesi del complotto dietro la strage di Portella della Ginestra (1 maggio 1947) e spiega le alleanze trasversali e gli interessi internazionali che crearono il primo episodio di terrorismo politico all’alba della prima Repubblica.
[116] Figlio di un mugnaio toscano, Gelli nacque a Pistoia il 21 aprile 1919. A soli diciassette anni fa carte false per partire volontario per la guerra di Spagna. Al suo rientro, a causa della morte del fratello Dino, Mussolini in persona lo accoglie con affetto. Pier Carpi riporta il dialogo che sarebbe avvenuto tra Mussolini e il giovanissimo Gelli. Pier Carpi, Il Venerabile, cinquant’anni di misteri e segreti in un romanzo con nomi e fatti veri, Gribaudo – Zarotti, Parma, 1993, p. 104. «Dal 1941 al 1945 lavora per il Counter Intelligence Corps, il servizio di controspionaggio militare americano. Nell'autunno del 1962 entra nella loggia massonica Gian Domenico Romagnosi di Roma. Nel Dicembre '65 viene elevato nella gerarchia massonica ed entra nella loggia Propaganda 2. Nel '68, recluta nella P2 il gen. Allavena, dal quale riesce ad avere una copia dei 157.000 fascicoli del SIFAR. Nel frattempo è diventato maestro venerabile. Nel 1971 Salvini tenterà di conquistare il controllo della P2 estromettendo Gelli, ma non ci riesce. Nel Febbraio 1973 sarà Gelli a perorare la causa del ritorno di Peron presso il governo militare. Nel ’74 Gelli, intrattiene anche stretti rapporti con Michele Sindona, che nel Settembre '74 fugge negli USA a causa del crack della Banca Privata Finanziaria. Nel Marzo '81 la magistratura indaga su un eventuale favoreggiamento, del "venerabile" in un falso auto-rapimento inventato da Sindona a New York, viene, quindi, perquisita (17 marzo) villa Wanda, la residenza di Gelli nei pressi di Arezzo, e gli inquirenti trovano un'ingente documentazione che prova l'esistenza di una cospirazione politica di destra dietro alla loggia segreta P2, alla quale risulteranno iscritti 963 uomini importanti. La P2 risulta, inoltre, avere depositi per circa mille miliardi su conti bancari svizzeri. Una commissione parlamentare d'inchiesta chiarirà poi, solo in parte, i legami esistenti fra Gelli, Michele Sindona, Roberto Calvi, la finanza internazionale, la mafia, i servizi segreti USA, golpisti di diversi paesi fra cui Italia, Argentina e Uruguay. Il 13 settembre del 1982, Gelli viene arrestato in Svizzera, dove rimarrà in fino il 9 Settembre '83, quando riuscirà ad evadere. Si veda il sito Cattiviragazzi
[117] De Luca – Scarano, cit., p. 137.
[118] Ivi.
[119] Ivi, p. 136.
[120] Ivi.
[121] Secondo la testimonianza dell’ex terrorista di destra, Vincenzo Vinciguerra il misterioso emissario sarebbe stato Francesco Varone.
[122] Dal Processo Pecorelli, 14 aprile 1994, pubblicato presso l’Almanacco dei misteri.
[123] Dal primo Processo Moro 1982.
[124] Dal sito di Radio Radicale www.radioradicale.it/servlet/VideoPublisher?cmd=segnalaGoNew&livello=s7.2.2&file=uni_michele_0_20010418123356.txt
[125] Dal sito di Radio Radicale
[126] Dichiarazione di Moretti riportata Dal sito Almanacco dei misteri.
[127] Dal sito http://www.kaosedizioni.com/nov_covo_sintesinotizie.htm
[128] Flamigni, la tela del ragno, pp. 274-276.
[129] Flamigni, cit., pp. 169 -175. Si veda Flamigni, Il covo di Stato, PP. 147-141; La tela del Ragno, pp. 147–156.
[130] De Luca – Scarano, cit., p. 139.
[131] Willan, cit., p. 235.
[132] Dal sito http://www.almanaccodeimisteri.info/morograd.htm. Flamigni, La sfinge delle Brigate Rosse, pp. 227-229; 348-349. Dal sito http://www.kaosedizioni.com/nov_covo_sintesinotizie.htm
[133] Dalla sceneggiatura, p. 59.
[134] Dalla sceneggiatura, p. 59. La notizia è presa dal quotidiano La Padania 28 ottobre 1999 in riferimento della deposizione di Prodi in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e il terrorismo (1997) davanti all'on. Enzo Fragalà.
[135] Flamigni, La sfinge delle Brigate Rosse, p. 227. Nel volume Convergenze Parallele (p.177) Flamigni riporta la missiva dello stesso Stelo in cui si afferma che non esiste nessuna relazione tra le indagini del senatore e le società immobiliari di via Gradoli. Da parte sua, Flamigni continua a mettere in relazione le strane circostanze tra via Gradoli e le citate società immobiliari. Si veda, in oltre, l’intervista di Dimitri Buffa a Flamigni, La padania, 11 novembre 1999.
[136] Flamigni, I fantasmi del passato, Kaos, pp. 347-348.
[137] Flamigni, La tela del ragno, pp. 171-177; I fantasmi del passato, pp. 347-348.
[138] Flamigni, La sfinge delle Brigate Rosse, pp. 348-349. Si nota che tale indagine è sostenuta dallo stesso Flamigni e principalmente nei suoi diversi volumi pubblicati. In altri studi, si veda ad esempio quello di Satta, molti nomi che per Flamigni sono legati a via Gradoli, non sono affatto presi in considerazione.
[139] Dal sito Kaos Edizioni. Satta evidenzia che quella foto non ebbe affatto un significato intimidatorio e minaccioso. Partendo dalla deposizione del giudice Priore in Commissione, Satta ricorda che la foto fu semplicemente una «burla» del capo dell’Ufficio Politico Domenico Spinella. La scritta il “gatto e la volpe” apposta sul retro della foto evidenzierebbe questa intenzione. Dunque nessun mistero dietro quella foto. Satta, cit., p. 379.
[140] Bruno Sermoneta era un commerciante di 37 anni che gestiva un ampio negozio di biancheria e tappeti con ingresso in via Arenula e retro in via delle Zoccolette, nei pressi del Ghetto ebraico. Le indagini furono coordinate dal tenente colonnello Antonio Cornacchia (affiliato alla Loggia P2). Naturalmente non si approdò a nessun risultato. Ivi.
[141] Willan, cit., pp. 264 –265.
[142] La documentazione è presente nel sito Kaos Edizioni in riferimento al lavoro svolto da Flamigni. Si veda in oltre l’articolo Il covo di via Gradoli (25 febbraio 2004) pubblicato presso il sito Archivio900.it all’indirizzo www.archivio900.ititdocumentidoc.aspxid=82
[143] Flamigni, Il covo di Stato, p. 354; Convergenze parallele, pp. 228-230.
[144] Flamigni, cit., pp. 242–243.
[145] Ivi.
[146] De Luca – Scarano, p. 135.
[147] Il falso comunicato numero sette: «Oggi 18 aprile 1978, si conclude il periodo "dittatoriale" della DC che per ben trent'anni ha tristemente dominato con la logica del sopruso. In concomitanza con questa data comunichiamo l'avvenuta esecuzione del presidente della Dc Aldo Moro, mediante "suicidio". Consentiamo il recupero della salma, fornendo l'esatto luogo ove egli giace. La salma di Aldo Moro è immersa nei fondali limacciosi (ecco perché si dichiarava impantanato) del lago Duchessa, alt. mt. 1800 circa località Cartore (RI) zona confinante tra Abruzzo e Lazio. E' soltanto l'inizio di una lunga serie di "suicidi": il "suicidio non deve essere soltanto una "prerogativa" del gruppo Baader Meinhof. Inizino a tremare per le loro malefatte i vari Cossiga, Andreotti, Taviani e tutti coloro i quali sostengono il regime. P.S. - Rammentiamo ai vari Sossi, Barbaro, Corsi, ecc. che sono sempre sottoposti a libertà "vigilata". 18/4/1978 . Per il comunismo».
[148] Leonardo Sciascia, cit., p. 84.
[149] Willan, p. 277.
[150] Ivi, p. 277-278. Dall’intervista di Giorgio Bocca a Mario Moretti, L’Espresso, 2 dicembre 1984.
[151] Ivi, p. 280.
[152] Ivi, p. 279.
[153] Per Satta non esisterebbero legami diretti tra la scoperta del covo e il falso comunicato. Non si possono congetturare strane collaborazioni tra Stato e terroristi. Le vicende relative al 18 aprile, tendono a evidenziare i «segni di negligenze eclatanti, e tanto dolose», ma si tratta comunque di escludere una regia comune nello svolgimento dei fatti. Il punto di appoggio basilare della tesi sostenuta dall’autore, è dato dalla trascrizione dell’interrogatorio del pompiere Leonardi che entrò nell’appartamento di via Gradoli:«il pompiere non dichiarò mai che la scopa orientava il getto d’acqua: lo scrissero i suoi esegeti». Non si trattò di scoperta guidata, ma di fatalità. Satta evidenzia le foto agli atti della Commissione Moro, pubblicate nel suo libro. Quindi in primo luogo, la scoperta dell’appartamento di via Gradoli, sarebbe avvenuta per caso, nessuno avrebbe manomesso la doccia, ma la doccia sarebbe stata semplicemente difettosa. Da questi particolari importanti, se fossero effettivamente smentiti, cadrebbe tutta la tesi del complotto sostenuta dal regista e dagli stessi studi di Flamigni. Satta, cit., pp. 280-281; 291; 410.
[154] I contatti tra il caso Moro e il Vaticano sembrano essere minati da una sostanziale ambiguità, anche se nessuna prova ha confermato una possibile collusione. Sergio Flamigni, affrontando la dinamica immediatamente successiva alla strage di via Fani, ricorda come un possibile luogo di sosta dei brigatisti poteva essere individuato via Massimi. Per il magistrato Nicolò Amato è molto probabile che i terroristi abbiano avuto un appoggio tipo un garage nelle vicinanze nei pressi di via Licino Calvo «appartenenti a persone del tutto insospettabili». Lo stesso Pecorelli in un articolo del 16 gennaio 1979, aveva puntato l’attenzione sul «garage compiacente che ha ospitato le macchine servite all’operazione». Il garage era sito in Via Massimi, una via particolarmente ricca di sedi religiosi tra cui lo IOR, la Loyola University Chicago Rome Center of Liberal Art. E’ evidente che i brigatisti abbiano mentito riguardo ai loro spostamenti dopo il sequestro, per coprire «complicità imbarazzanti». Tra il materiale sequestrato ai brigatisti Valerio Morucci e Adriana Faranda dopo il loro arresto (29 maggio 1979), verranno trovati l’indirizzo e il numero di telefono dell’abitazione del Monsignor Marcinkus nonché l’indirizzo e il numero di telefono di Felix Morlion, il religioso francese agente della Cia, in contatto con la scuola di lingue Hyperion. Sergio Flamigni, cit., p. 207; 221.
[155] L'incontro fu tenuto in Crimea, nel palazzo imperiale di Yalta (4-11 Febbraio 1945), pochi mesi prima della sconfitta della Germania nazista. Esso fu il secondo di una serie di tre incontri fra i massimi rappresentanti delle grandi potenze alleate, iniziati con la Conferenza di Casablanca (14-24 Gennaio 1943) e conclusisi con la Conferenza di Potsdam (17 Luglio-2 Agosto 1945). Questi incontri si proponevano di stabilire l'assetto internazionale post-bellico, ed effettivamente gran parte delle decisioni prese a Yalta (ad esempio la divisione dell'Europa in sfere di influenza) ebbero profonde ripercussioni sulla storia mondiale, perlomeno fino alla caduta dell'Unione Sovietica del 1991. La conferenza di Yalta, da questo punto di vista, costituisce il preludio della Guerra fredda. Gli accordi ufficialmente raggiunti a Yalta prevedevano la liberazione dell’Europa e lo svolgimento delle elezioni democratiche, la costituzione futura di un organismo internazionale che si realizzerà con la nascita dell’Onu, lo smembramento e il disarmo della Germania, non che i suoi debiti riparatori, e il destino della Polonia e della Jugoslavia, il rapporto tra Giappone e Unione Sovietica e la liberazione dei prigionieri di guerra.
[156] Flamigni, cit., pp. 184-185.
[157] Willan, cit., pp. 213-217.
[158] Il colonello Stefano Giovannone fu rappresentante del Sismi a Beirut dal 1972 fino alla metà degli anni 80 quando fu coinvolto in alcuni scandali relativi alla sua attività segreta. La morte, sopraggiunta nel 1985, riucorda Willan , “fece tirare un sospiro di sollievo a molti personaggi dei servizi segreti”. Willan ricorda che l’uomo che Moro aveva scelto per le relazioni con l’OLP era lo stesso colonello. In una delle sue lettere (numero 44, del 29 aprile indirizzata a Flaminio Piccoli) Moro scrive il nome “Giovanoni” creando un precedente: avendo trattato nella medesima l’argomento Miceli-Fiorenzi-Stark, quell’errore era una sorta di indicazione tra le righe in riferimento alla presenza straniera in tutto l’affaire? Willan, cit., pp. 182-184; 213-217; 339-341.
[159] Willan, cit., pp. 213-217.
[160] Ivi, p. 217.
[161] Flamigni, cit., p.184.
[162] La scelta dell’attore Murray Abraham, di cui si vede soprattutto il volto e non ha altre funzioni narrative se non in questo punto del film, è data soprattutto dalla sua spiccata qualità recitativa e facciale, come ricorda lo stesso Martinelli. Si tratta di un volto che ben si adegua alle rivelazioni che sta per fare e coincide con l’emotività del momento scenico: movimento degli occhi, lo sguardo profondo, il controllo della faccia. In oltre, l’aspetto «ambiguo, mediorientale» del personaggio, evidenzierebbe ulteriormente la figura del manipolatore addentrato nelle cose segrete dell’affaire Moro. La scena è stata girata a Versailles accanto alla statua di Titano morente, un mito che ricorda, secondo Martinelli, la lotta contro il Potere (la reggia) da parte della Verità, destinata a soccombere. Si tratta di una metafora che fa riferimento al personaggio Saracini, destinato ad un pericoloso collasso, come dimostrerà il finale del film. Martinelli, cit., p. 83.
[163] Per diritto di cronaca, è doveroso citare che secondo Satta non esistono prove e documenti che comproverebbero una simile ipotesi: in primo luogo, Moretti non sarebbe stato un doppiogiochista agli ordini di una chi sa quale potere misterioso; in secondo luogo, la scuola Hyperion «non sarebbe stata una centrale incaricata dai servizi segreti delle grandi potenze di fomentare il terrorismo in tutto il mondo e non ebbe a che fare con il caso Moro». Le argomentazioni edotte da Satta prendono avvio soprattutto da un fatto: le voci relative al Moretti spia e agente segreto furono fatte circolare da Franceschini e da Curcio relative ad una sorta di guerra interna alle stesse brigate rosse e agli eventi relativi all’infiltrazione di Frate Mitra. In oltre, Satta ricorda che a confondere le acque fu un articolo intervista rivolto allo stesso Gallinari che avrebbe delineato un simile scenario, ma soltanto come provocazione (Antonio Cipriani, L’Unità 3 dicembre 1990). In fine, questo effetto fu prodotto, in maniera esagerata, dalla deposizione del pentito Michele Galati. Nel complesso, si trattò, quindi, di una chiave sensazionalista ostile a Moretti, da parte dei stessi compagni di lotta. Satta, cit., pp. 197- 199; 409.
[164] Ivi, p. 210.
[165] A raccontare l’episodio è lo stesso Franceschini. Egli ricorda come l’arresto di Curcio e di Nadia Mantovani presso l’appartamento covo di via Maderno a Genova, era avvenuto proprio il giorno dopo l’alloggio di Moretti. I carabinieri fecero l’irruzione nell’appartamento, dopo una lunga opera di pedinamenti e di infiltrazioni, immediatamente dopo lo stazionamento di Moretti. Questo episodio comproverebbe che i responsabili di quell’arresto, i servizi segreti e lo stesso Ufficio D (generale Giovanni Romeo), non erano interessati ad arrestare Mario Moretti. Flamigni, cit., p. 163.
[166] L’arresto dei brigatisti, tra cui quello di Semeria, avvenuto in via Balestrati a Milano, è sempre sorprendentemente relazionato ai strani errori di Moretti: egli aveva affermato che il covo appartamento era “pulito”, ovvero sicuro. Ma appena vi si stabilirono i brigatisti, la polizia fece irruzione, esattamente come era avvenuto per il primo arresto di Curcio. Questi eventi fecero scattare un’inchiesta interna alle stesse Br affidata a Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, ma senza risultati. L’unica conseguenza fu che Moretti pretese le scuse scritte da parte dei brigatisti responsabili di quell’indagine interna. Ivi, p. 164-165.
[167] S. Flamigni, cit. p 29.
[168] L’evento è citato in Giuseppe Zupo - Vincenzo Marini, Operazione Moro, Franco Angeli 1984, p. 271. Willan, cit., pp. 211-212
[169] S. Flamigni, cit. p 29.
[170] Willan, cit., p. 85.
[171] Ivi, p. 86.
[172] Ivi, p. 85.
[173] Ivi, p. 103.
[174] Giovanni Fasanella, Claudio Sestieri, Giovanni Pellegrino, Segreto di Stato, cit., pp. 12-15.
[175] De Luca – Scarano, cit., p. 136.
[176] La lettera è tratta dal sito Apolis
[177] Adriano Sofri, cit., p. 173.
[178] Dalla trasmissione televisiva di Enigma, Rai Tre, martedì 22 marzo 2004.
[179] Satta, cit., p. 210.
[180] Leonardo Sciascia, cit., p. 55.
[181] Ivi.
[182] Anna Maria Braghetti, Il prigioniero, Mondatori 1998, p. 68.
[183] Ivi, p. 35.
[184] Ivi, p. 126
[185] Molte contraddizioni strategiche e terroristiche delle Br e del suo capo, Mario Moretti, sono evidenziate dallo studio già menzionato di Sergio Flamigni.
[186] Luigi Bonanate, intitola il capitolo dedicato al terrorismo rosso e all’uccisione di Moro come Attacco al cuore dell’Europa in un periodo che coincide con il terrorismo della banda Baader Mienhof tedesche e con una particolare coincidenza di piani, obiettivi e strategie: «è difficile sapere se Raf e Br fossero in contatto e collaborassero scambiandosi informazioni e suggerimenti; ma non è difficile scorgere somiglianza tra i destini di Aldo Moro e di Martin Schleyer (presidente associazione industriali tedeschi, N.d.A.) come se quest’ultimo avesse ispirato il primo». Un intreccio che avrebbe coinvolto anche il terrorismo francese e che evidenzierebbe un destino comune dell’eversione all’interno di alcune democrazie europee. Luigi Bonanate, Terrorismo Internazionale, Giunti Casterman, Firenze 1994, pp. 137-167.
[187] Adriano Sofri, cit., p. 98.
[188] Leonardo Sciascia, cit., pp. 112-114.
[189] Ivi, p. 114.
[190] La funzione narrativa di Rosario può essere equiparata all’indagine giornalistica portata avanti da Sergio Flamigni, il quale descrive chiaramente le contraddizioni esistenti nelle deposizioni di Moretti, Braghetti e Maccari. Per tutti e tre l’uccisione di Moro sarebbe avvenuta all’alba del 9 maggio in via Montalcini, nel box auto. La Braghetti afferma, per esempio che il prigioniero era stato bendato e messo in una grossa cesta di vimini; Maccari afferma che tutti i brigatisti indossavano il passamontagna per non farsi riconoscere dal prigioniero. Un'altra contraddizione affiora dalla lettera di Moro, la penultima, dove lo statista parla di «ordine di esecuzione» rivelando il fatto che egli sapesse della sua fine incombente. Maccari e Moretti affermano che il prigioniero non sapeva di dover essere ucciso. Sergio Flamigni, cit., p. 236-237.
[191] In occasione del sequestro Vallarino Gancia, le Br avevano adottato una strategia piuttosto precisa nel caso fossero incappati in un posto di blocco. Essendo le macchine sempre tre, le prime due avrebbero fatto strada a quella dove era il prigioniero, forzando così il blocco. Si tratta di una pratica che doveva essere adottata molto probabilmente anche per il trasporto del corpo di Moro, in una situazione particolarmente più complicata e rischiosa. Per questo motivo Flamigni evidenzia che la versione ufficiale data da Moretti potrebbe essere falsa. In oltre, la perizia eseguita sul corpo di Moro, afferma che il prigioniero, dopo l’esecuzione, non si è più mosso da quella posizione. Questo confermerebbe che dopo la sua morte non è stato trasportato in nessun luogo, ma sarebbe rimasto nel medesimo. Sergio Flamigni, cit., pp. 208; 240.
[192] La perizia del professore Silvio Merli, dichiara che il cadavere non era stato mosso dopo l’esplosione degli undici colpi della Skorpion e della Walter Ppk. Martinelli, cit., p. 94. La domanda che guida l’indagine è perché le Br mentirono?
[193] Flamigni, pp. 236-237; 249.
[194] Dalla sceneggiatura, cit., p 101. Le strane coincidenze relative alle “tre vie”, come ricorda un importante documentario di Sergio Zavoli, può essere evidenziata dalle prime abitazioni di Mario Moretti. La prima abitazione di Moretti era situata a Milano in via Gallarate 131, nello stesso stabile di un importante collaboratore del colonnello Rocca, impegnato nella cosiddetta “guerra psicologica”. Si tratta di Luigi Cavallo ex comunista, provocatore, «ex agente dell’Ovra infiltrato nel gruppo partigiano torinese Stella Rossa, ex infiltrato Cia nell’Unità». Le “coincidenze” relative a via delle Ande, la seconda abitazione di Moretti, sono ancora più sorprendenti. A pochi metri risiede il capo della questura milanese Antonino Allegra, e l’ex partigiano comunista Roberto Dotti definito «ex infiltrato della Cia nel Pci, scoperto ed espulso dal partito». Sia Cavallo che Dotti sono legatissimi ad Edgardo Sogno e alla sua politica filoamericana. In oltre, Dotti conosce molto bene Corrado Simioni, il responsabile della prima frattura all’interno delle Brigate rosse. Insomma, i luoghi che frequenta Moretti sembrano essere legati ad ambienti controrivoluzionari con idee di alta strategia psicologica caratterizzate da azioni provocatorie finalizzate ad emarginare l’azione politica del Pci. Osserva Sogno: «non era difficile vedere che l’azione contro il Pci era tanto più efficace quanto più veniva svolta da sinistra». Flamigni, cit., pp. 23; 45-46;
[195] Si tratta di una tesi allarmante più volte presentata da Sergio Flamigni: «e se palazzo Caetani ospitava diverse sedi diplomatiche coperte da immunità territoriale, non così era per l’attiguo palazzo Mattei, ideale come “luogo di ricetto di autovettura”, che però le forze di polizia omisero di segnalare: la Renault delle Br avrebbe potuto entrare e uscire dall’ampio passo carraio situato in via dei Funari». S. Flamigni, cit., p 247.
[196] La versione iniziale affermava che ad uccidere Moro fosse stato Prospero Gallinari. In seguito nel 1993 Moretti riferirà che fu lui stesso ad uccidere lo statista: «non avrei mai permesso che l’avesse fatto qualcun altro». La versione è confermata dallo stesso Maccari, ma con ulteriori contraddizioni. Nel suo racconto Maccari afferma di non indossare il passamontagna, di cui aveva raccontato precedentemente al pubblico ministero Marini (Corte d’Assise di Roma, 19 giugno 1996). In oltre, Maccari, presente al momento dell’uccisione, non sa niente di quei fazzoletti tampone usati per impedire la fuoriuscita di sangue dal cadavere; ma stranamente ne era a conoscenza Antonio Chichiarelli con gli indizi lasciati nel borsello. La versione di Maccari è quindi piena di contraddizioni e ha lo scopo di adeguarsi alla “verità” concordata con gli altri brigatisti. Anche la dinamica balistica, tratta dal resoconto di Maccari e scritto dalla Braghetti, è piena di incongruenze: Moretti prima sparò con la pistola Walther Ppk poi con la mitraglietta Skorpion. L’autopsia ha accertato che Moro, colpito da 11 proiettili calibro 7,65 della Skorpion e da un ultimo proiettile calibro 9 corto, ebbe una forte emorragia interna, e spirò dopo un’agonia di 15 minuti. La versione della Braghetti e quella di Maccari sono in evidente contraddizione con la perizia medica. Sergio Flamigni, cit., pp. 238-241.
[197] Ivi, p. 241.
[198] Ivi, p. 243.
[199] Il colonnello Antonio Cornacchia (P2) si era adoperato per avvertire lo stesso Sermoneta di una possibile indagine sul suo corso. Tale comunicazione avrebbe permesso allo stesso commerciante di prepararsi in anticipo le domande che gli verranno poste il 5 marzio 1979, in modo da non essere colto di sorpresa ed evitando di offrire nuovi elementi investigativi. Ivi, p. 244.
[200] Gli investigatori erano già a conoscenza di questo covo, ma nessuno fece niente per realizzare un intervento concreto. Ne erano a conoscenza il Sismi, il colonnello Demetrio Cogliandro, e il capitano Antonio Fattorini, detto “mezzo ebreo” per i suoi rapporti con il Mossad. Ivi.
[201] La prima informazione relativa a Igor Markevich proviene dai due agenti del Sismi Antonio Ruvolo e Giuseppe Corrado. Ma il Sismi posticiperà da maggio a ottobre la data in cui il capitano Fattorini avrebbe fornito tale informazione ritardano le indagini. Ivi, p. 245.
[202] Ivi, p. 245. In oltre, Fasanella – Rocca, Il misterioso intermediario, Igor Markevich e il caso Moro, Einaudi 2003.
[203] Ivi, p. 246.
[204] Dalla sceneggiatura, p. 98.
[205] Flamigni, cit., p. 246.
[206] Ivi, p. 248.
[207] Dalla sceneggiatura, p. 101.
[208] Willan, cit., p. 308.
[209] A tale proposito, il giornalista Sergio Zavoli chiese al brigatista Bonisoli il motivo di questa «bugia pietosa” e crudele. A Moro venne detto che sarebbe stato rilasciato e stando alla versione del brigatista lo stesso statista fu «contento». Bonisoli afferma la difficoltà del momento, ma condivise la necessità di «mentire». Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Elleu Multimedia 1989.
[210] Willan, cit., p 308.
[211] Ivi, p. 333.
[212] Ivi, p. 237.
[213] Martinelli, cit., pp. 66-67.
[214] Tuttavia Giuseppe Santovito mentì spudoratamente in relazione ai reparti: «non è niente di speciale: «si tratta del sostegno del personale di leva in servizio, gli autisti, i marconisti si chiamano unita speciale». S. Flamigni, cit., pp. 192 194. Si veda in oltre Willan, cit., pp. 173-174.
[215] Scarano De Luca, cit., pp 150 – 151.
[216] Tratto dalla Commissione Parlamentare in data 1 agosto 1980, in Scarano De Luca, cit., p. 150.
[217] Leonardo Sciascia, cit, p. 167.
[218] Sceneggiatura, p. 102.
[219] Willan, cit., p. 263.
[220] Fatto allarmante riguarda la profezia dello stesso Pecorelli che avrebbe alluso alla morte prossima del generale Dalla Chiesa. Willan, cit., p. 264.
[221] La dichiarazione del segretario Sereno Freato testimonierebbe la forte tensione esistente tra la segreteria di Stato americana (Kissinger) e la politica di Aldo Moro. Tale situazione avrebbe generato una vera e propria politica di contrasto che trova il suo conflitto maggiore nel caso Lockheed. L’assistente dello statista Corrado Guerzoni ricorda che dentro le valigette di via Fani vi sarebbe stato del materiale importante relativo al caso Lockheed e allo scagionamento dello stesso Moro dalle infamanti accuse secondo le quali Antilope Coppler sarebbe stato lui. Willan, cit., p. 299. D’altra parte i contrasti tra Moro e gli Stati Uniti sarebbero emersi già nel settembre del 1974, durante il viaggio a New York e a Washington. Secondo le testimonianze di Eleonora Moro, lo statista venne avvertito in maniera piuttosto diretta di non continuare la sua politica. Le parole rivolte a Moro da parte di un uomo politico non meglio identificato, sarebbero state «guardi che se lei insiste questa cosa la porterà nei guai». Secondo alcune fonti, quell’uomo fu Kissinger stesso, il quale però smentì (si veda l’intervista di Minoli nel programma Mixer). Voci confidenziali vennero anche dal segretario del partito socialdemocratico tedesco Willy Brandt e da un incontro segreto che lo stesso Moro avrebbe avuto con un esponente dell’Intelligence Usa, politicamente legato al Partito democratico, sul cui episodio mancano però elementi precisi. A Moro furono fatte rivelazioni sull’estrema decisione da parte americana nel voler interrompere la sua politica, sia per la sua tendenza filoaraba e sia per la sua apertura alla sinistra comunista. Fu questo incontro a aumentare il malessere dell’allora ministro degli esteri Aldo Moro e provocare il malore nella cattedrale di St. Patrick, pochi giorni prima di lasciare l’America. De Luca – Scarnano, cit., pp. 21-26. Lo stesso evento è evidenziato dallo stesso regista nel suo libro in cui riconosce Kissinger nell’uomo che avrebbe intimato la politica di Moro. Piazza delle Cinque Lune, p. 112. Secondo Satta, la «disistima» tra la politica di Moro e gli interessi americani era assai nota. I loro contrasti sarebbero stati «meno aspri» di quanto avrebbero “stigmatizzato” gli stessi parenti di Moro e il suo entourage. Satta, cit., pp. 22-23; 316.
[222] Willan, cit., p. 300.
[223] Ivi, p. 301.
[224] Adriano Sofri, cit., p. 174.
[225] Ivi.
[226] Ivi, pp. 195-196.
[227] Ivi, pp. 206-207.
[228] Ivi, pp. 175-176.
[229] Willan, cit., p.175.
[230] Adriano Sofri, cit., p. 100.
[231] Nella presente lettera lo statista si riferiva allo scambio con i prigionieri brigatisti, ipotesi che non fu minimamente presa in considerazione dal mondo politico.
[232] Il materiale preso in esame è tratto dal sito Apolis.
[233] Il termine guerra e guerriglia appaiono nelle seguenti lettere: in quella indirizzata a Cossiga, la numero 3, in cui Moro fa un paragone tra la Ragion di Stato e la sua liberazione; nella lettera appena citata indirizzata alla moglie; nella lettera numero 11, rivolta al Papa Paolo VI dove insiste sulle condizioni di scambio dei prigionieri sempre adottata dagli altri paesi; nella lettera numero 13, indirizzata a Taviani in cui lo statista ricorda che questa è una «guerriglia» e non è una «delinquenza comune»; nella lettera numero 33, indirizzata al compagno di partito Zaccagnini, forse la lettera più amplia per argomentazione, in cui Moro introduce concetti giuridici e filosofici sull’idea di libertà e di vita, citando lo stesso Cesare Beccaria; nella lettera numero 46, indirizzata a Renato Dell’Andro, dove ricorda l’esempio Palestinese; nella lettera numero 50, indirizzata a Pennacchini dove ricorda sempre la vicenda Palestinese; e in fine nella lettera numero 69, indirizzata a Riccardo Misasi in cui Moro ammette l’oggettiva volontà da parte dello Stato di lasciarlo prigioniero.
[234] Lo ricorda lo stesso Sofri, cit., p. 110.
[235] Le allusioni letterarie e storiche di Sofri fanno ben comprendere la reale situazione che sta dietro l’affaire Moro. La struttura militare organizzata contro una possibile invasione dell’Armata Rossa va sotto il “doppio” nome di Gladio e, in gergo inglese, Stay Behind, una doppia semantica che corrisponde ad una doppia identità e che risuona nel nome della stessa P “2”. Come del resto Spartaco il “gladiatore”, il nome in codice Adam Weishaupt, fondatore della nota società degli Illuminati di Baviera (1776). Insomma Sofri, con eleganza stilistica ed erudita, sembra insistere sulla forte presenza della loggia massonica deviata in tutto il sequestro Moro e, per questo, ne rintraccia la causa fondamentale nei poteri internazionali e finanziari. Sofri, cit., pp. 96-97; 110.
[236] Con l’espressione “quarto livello” mi voglio riferire a quella usata dal magistrato Carlo Palermo, già citato nella presente relazione.
[237] Lo stesso regista ricorda che per girare questa scena e ottenere un effetto piuttosto realistico e dinamico, abbia utilizzato un’ottica Canon 800mm, un vero e proprio superobbiettivo che permette di cogliere perfettamente tutti dettagli dell’inquadratura che possono essere visti con estrema nitidezza nello schermo pieno. Piazza delle cinque lune, cit., p. 20.
[238] Scrive Martinelli: «è dall’alto della Torre che si vede perfettamente la geometria della città. Esattamente come nel caso Moro: soltanto alzandosi in alto si può vedere il filo sottile che lega tra loro avvenimenti apparentemente scollegati. È solo dall’alto che si può capire il caso Moro». Dal libro, Piazza delle Cinque Lune, cit., p. 18.
[239] Sono le parole di Martinelli. In oltre il regista ricorda come nel film torna di frequente la forma estetica della spirale: all’inizio delle indagini quando nella rampa del garage sotterraneo; e lo stesso si può parlare dell’avvitamento realizzato da Martinelli per le inquadrature compiute dall’alto. In questo senso la scelta stilistica corrisponde con quella narrativa, in cui i protagonisti sono gradualmente risucchiati dalla spirale del caso Moro, un percorso complesso e oscuro, rischiando la loro stessa vita. Martinelli, cit., p. 119.
[240] Dalla sceneggiatura, cit., p 112.
[241] Il terrorismo italiano, Giorgio Bocca. De Luca – Scarano, cit., p. 184.
[242] Flamigni, cit., pp. 136-142.
[243] Willan, cit., p. 227.
[244] Dalla sceneggiatura, p. 114.
[245] Nella testimonianza fornita da Girotto si descriveva il piano dei servizi segreti per porre termine al sequestro Sossi con un massacro: «Curcio mi disse che c’era l’intenzione di giustiziare Sossi, ma poi le Br avevano saputo da una fonte sicura del ministero degli Interni che i carabinieri avevano avuto l’ordine di giustiziare tutti, anche Sossi». Willan ricorda il commento del pubblico ministero, Luigi Moschetta: «c’era qualcuno in ambiente qualificato che aveva interesse che le scorrerie delle Brigate Rosse continuassero… possiamo credere che le Br avessero un informatore all’ufficio Affari riservati del ministero degli Interni». Willan, cit., p. 228. Tutto questo confermerebbe la presenza di un disegno segreto che vorrebbe i brigatisti guidati da un potere non meglio identificato.
[246] Dalla sceneggiatura, p. 114.
[247] Sono le parole del personaggio Fernanda Doni. Dalla sceneggiatura, p. 115.
[248] Flamigni, cit., pp. 129; 175-176.
[249] Sofri, cit., p. 189.
[250] Moretti ricorda che Moro era il «grande sacerdote che per far tornare i conti del potere è capace di fondare un’eresia». Andreotti sarebbe stato il giocoliere che «alla fine dei maneggi fa sparire il mazzo di carte». Riguardo alla scelta di colpire Moro il brigatista ammette: forse sbagliammo valutazione, non posso negarlo in assoluto. Forse non abbiamo capito che fra i due c’erano differenze molto più profonde di quelle che apparivano». Tuttavia in quel tempo per Moretti, Andreotti e Moro erano «gemelli» e che non c’erano differenze sostanziali. Carlo Mosca - Rossana Rossanda, cit., pp. 115-116.
[251] Willan, cit., pp. 257-258.
[252] Ivi, p. 258.
[253] Ivi.
[254] Ivi, p. 230. Il frammentario orientamento dei brigatisti emerge molto stranamente alla fine del caso Moro. La prima scissione avviene dopo il sequestro D’Urso, tra le Brigate Rosse – partito comunista combattente, (linea militarista morettiana) e Brigate Rosse – partito guerriglia (Balzerani, Savasta, Novelli). Il collasso totale, colmo di tradimenti, reticenze e rapporti ambigui avviene durante il Morobis quando il 28 aprile la Corte concede di scegliere la collocazione nelle gabbie durante le udienze. La prima gabbia è per Peci, Savasta, Bonavita; la seconda è per i dissociati, inizialmente per Norma Andriani; la terza è per il partito della guerriglia, Azzolini, Bonisoli, Fiore; la quarta è per Moretti, Gallinari, Braghetti; nella quinta ci sono i futuri dissociati, Morucci, Faranda; nella sesta, ci sono gli imputati che hanno deciso la posizione autonoma, Triaca, Cavani e altri. La frammentazione del partito armato lascia comprendere la particolare fragilità dei piani e degli obiettivi dei terroristi. Se inizialmente tutti sono stati concordi, sotto l’organizzazione verticistica e compartimentalizzata di Moretti, di operare contro il politico Moro, poi come per incanto emergono divergenze e diversità tra gli stessi terroristi. La macchina di guerra che ha messo in crisi il mondo politico, è presto svelata come debole, labile e incapace di gestire i suoi stessi fondatori. Si tratterebbe di un’anomalia su cui riflettere. La spaccatura potrebbe indicare in sede storiografica la particolare specificità che avrebbe prodotto il delitto Moro. Flamigni, cit., pp 284; 297.
[255] Nel 1947 il presidente Harry Truman dette vita al National Secuity Council (Consiglio per la Sicurezza Nazionale), costituito da tutti i reparti militari e dai servizi segreti. Il primo rapporto di questo consiglio, definito NSC 1/1, (14 novembre 1947) descrive l’importanza della posizione strategica italiana e sottolinea la necessità di continuare gli aiuti finanziari. Nel punto “E” si legge: «combattere attivamente la propaganda comunista in Italia attraverso un efficace programma di informazione americano e ogni altro mezzo praticabile». Nel NSC 1/2 del (10 febbraio 1948), si passa ad un’azione energica che prevede anche l’intervento militare contro l’avvento comunista, destinato a mettere in pericolo la stessa sicurezza degli Stati Uniti. Nel documento del 5 marzo 1948, intitolato Conseguenza dell’accesso comunista in Italia attraverso mezzi legali, si prevede la possibilità di una «guerra civile» e la necessità di prevedere scissioni e gruppi di opposizione da utilizzare contro il Cremino. Per motivi economici, finanziari e industriali, il governo italiano governato dai comunisti è comunque «costretto a fare quanto in suo potere, se intende evitare un suicidio politico, per evitare il blocco dei crediti americani». Nel NSC 1/3 (8 marzo 1948), si osserva che il pericolo maggiore per l’Italia e per la stessa democrazia americana è la vittoria del Fronte popolare nelle elezioni del 18 aprile e le sue devastanti implicazioni per l’intero scacchiere europeo. Nel caso di vittoria, gli Stati Uniti avrebbero dovuto opporsi fermamente all’aggressione comunista, rafforzando le posizioni militari nel Mediterraneo, fornendo al «movimento clandestino anticomunista italiano aiuti finanziari e assistenza militare». Giovanni Zozzini, Hanno sparato a Togliatti - l’Italia del 1948, Il Saggiatore, pp. 32-49.
[256] Il Field Manual 30- 31 B, come ricorda De Lutiis, è il documento «che più di ogni altro evidenzia aspetti illegali dell’intervento che governo e esercito statunitense hanno pianificato in caso di vittoria delle sinistre in Italia». In esso erano previste operazioni clandestine, reclutamento di membri di spicco, l’utilizzo di organizzazioni di estrema sinistra e il riferimento all’operazione Chaos che prevedeva l’infiltrazione in gruppi di estrema sinistra, anarchici, marxisti – leninisti, operaisti e castristi. Giuseppe De Lutiis, Il lato oscuro del potere, Editori Riuniti, Roma 1996, pp. 11-16.
[257] Aldo Moro era il responsabile dell’occultamento dei risultati relativi all’inchiesta sul Piano Solo, che consisteva in una mastodontica archiviazione di circa 157 mila fascicoli di uomini più influenti e importanti della prima repubblica. Lo scandalo, scoppiato nel’11 maggio 1967 attraverso un articolo dell’Espresso, descriveva le circostanze di un possibile colpo di stato preparato per il 14 luglio 1964 e che vedeva coinvolti il presidente Segni e il generale De Lorenzo. Le indagini produssero un rapporto dell’allora ministro della Difesa, generale Aldo Beolchini e un altro dal comandante dei carabinieri Giorgio Manes. Il rapporto Manes venne censurato con ben settantun omissis dallo stesso Aldo Moro e per questo venne soprannominato il Signor Omissis. Willan, cit., pp. 42-44. Si veda anche De Lutiis, I servizi segreti in Italia, cit., pp. 87-89. Lo stesso accadrà in relazione all’inchiesta sui piani golpisti (Sogno – Cavallo) del giudice istruttore Luciano Violante il quale rivolgendosi al presidente del Consiglio Moro, vedrà opporsi il segreto di Stato. Flamigni, cit., p. 154.
[258] A titolo informativo, è doveroso sottolineare come i contenuti del film evidenziano una sostanziale ingerenza americana nel caso Moro, escludendo totalmente gli eventi storici relativi al versante sovietico e la KGB, che pure sono presenti nella cronaca giudiziaria. In primo luogo nel film non è trattato il caso dell’archivio Mitrokhin, che secondo una certa pubblicistica, avrebbe avuto un ruolo non esiguo in tutta la vicenda. Tuttavia il film non pecca di parzialità: se la narrazione è spinta in senso antiatlantico, ovvero i nemici di Moro sarebbero da rintracciare in un certo livello della politica americana, è anche vero che il regista non esita a ricordare, come aveva fatto lo stesso Pecorelli, che la politica di apertura a sinistra di Moro avrebbe messo in seria difficoltà il comunismo sovietico, il quale non avrebbe mai accettato uno sviluppo internazionale su base democratica ed elettorale del proprio modello politico. Per Satta, il dossier Mitrokhin, il caso dello studente polacco che avrebbe seguito le stesse lezioni di Moro, S. F. Sokolov, non indicherebbero nessuna responsabilità internazionale. Il dossier Mitrokhin fu soltanto un depistaggio dei servizi segreti comunisti in senso antiamericano. In oltre, non esisterebbero elementi consistenti da far pensare ad una possibile alleanza tra brigatisti e servizi segreti dell’est. Satta, cit., pp. 25-26; 33.
[259] Willan, cit., p. 236.
[260] Il sito www.informationguerrilla.org/caso_moro evidenzia le due scuole di pensiero che continuerebbero a fronteggiarsi: quella di chi dice che, appunto, i “buchi neri” del caso Moro sono ancora molti e sempre più inquietanti e chi, all’opposto, sostiene che ormai tutto è chiaro. Da una parte esiste il polo Martinelli – Flamini; dall’altra un’archivista del Senato, Vladimiro Satta con il suo libro Odissea nel caso Moro. Si tratta di due tesi contrarie. La prima quella che sostiene «la CIA, travestita da BR, rapì Moro per impedire al Pci di portare a termine il compromesso storico con la DC»; la seconda è quella che sostiene «tutto chiaro, nel caso Moro non c’è un mistero che sia uno». Il sito definisce “visionarie” e “precostituite” le tesi di Martinelli – Flamigni e di “ingenuo candore” lo studio di Satta. Tuttavia, il sito ricorda il giornalista Roberto Chiodi ha evidenziato un certo numero di misteri irrisolti, che andrebbero però inquadrati in un contesto giudiziario preciso e ragionevole. Tali misteri riguarderebbero: 1) il superkiller; 2) il Memoriale; 3) i delitti Pecorelli, Varisco e Dalla Chiesa; 4) il covo; 5) il ghetto; 6) la seduta spiritica; 7) il caso Giuliana Conforto; 8) l’operazione Hyperion; 9) il “grande vecchio” nell’appartamento fiorentino.
Dal sito www.informationguerrilla.org/caso_moro
[261] Flamigni si riferisce ad una recensione di Battista relativa al libro Convergenze Parallele. In questa si leggerebbero una serie di «falsità», secondo Flamigni, che confermerebbero la tendenza a mistificare i veri misteri del caso Moro. Paolo Mieli ha scritto un articolo del 18 maggio 2003 in chiaro disappunto con il tentativo investigativo del film di Martinelli, giudicato “dietrologo” e affermando l’utilità e la giusta serietà del libro di Satta. La tesi è sposata anche da Il manifesto che in quei stessi giorni pubblica un articolo di Andrea Colombo di forte coloritura: «Flamigni merita l’oscar per le ricostruzioni più dietologiche, fantasiose, paranoiche, confuse e prive di qualsivoglia prova tra le tantissime partorite a raffica in questi venticinque anni». Ma le critiche non finiscono. Esiste anche un articolo di Rossana Rossanda (22 luglio 2003) che afferma che dietro il delitto Moro, «misteri non ce ne sono» e lo dimostrerebbe il voluminoso libro di Vladimiro Satta. Flamigni, cit., pp. 345-347.
[262] Si tratta di un’espressione usata dal senatore durante la presentazione del libro del giornalista Daniele Biacchessi sulla strage alla stazione di Bologna.
[263] E’ il punto nodale dell’intreccio narrativo. L’evento aggressivo non ha lo scopo di eliminare il giudice e la sua scorta Branco: ha semplicemente lo scopo di creare una forte ansia psicologica nel giudice da provocare, non sentendosi più al sicuro, la rivelazione della password allo stesso Branco. Da questo momento Branco, e chi insieme a Branco controlla la vicenda, conosce la password. Dunque, già da questo momento l’indagine è conclusa.
[264] Il regista spiega che la tecnica di ripresa (grandangolo 18mm Zeiss e il medio teleobbiettivo 100mm Zeiss) e quella di montaggio, attraverso l’accostamento dei due piani, doveva provocare la descrizione di confusione e di paura dello stesso personaggio. R. Martinelli, cit., p. 126. Ai fini narrativi, tale situazione, ha lo scopo di intensificare le minacce nei confronti del giudice e quindi di confermare che un misterioso potere lo sta tendendo sotto controllo. Lo spettatore, inevitabilmente non può che condividere lo stato d’animo del personaggio, incapace di capire chi possa compiere questo controllo violento e minatorio.
[265] Il personaggio di Branco è un esistente del racconto e per tanto è un personaggio di finzione. È però ispirato da una situazione storica più che verosimile come ricorda lo stesso Martinelli: Branco è uno sleeper, un agente di Super Gladio in sonno, temporaneamente non in servizio. E naturalmente Saracini non lo sa, non lo ha mai saputo che al suo fianco c’è sempre stato un agente dei Servizi segreti. L’esistenza del Super8, l’intenzione di Saracini di iniziare un’indagine privata, attiva l’agente Branco che da quel momento sta alle costole del magistrato, simulando una doverosa protezione. La scoperta della vera identità del capo scorta, spiegherà il perché di certi comportamenti e di certe sue frasi sibilline. Martinelli, cit., p. 62.
[266] Ivi, p. 8.
[267] Ivi, p. 107.
[268] Ivi.
[269] Si tratta di un fatto importante, avvallato da alcune dichiarazioni, riportate da Willan, che sarebbero state fatte dallo stesso Licio Gelli, di cui furono testimoni il giornalista fiorentino Marcello Coppetti e il maggiore Umberto Nobili. Per Gelli, il generale Dalla Chiesa avrebbe avuto un infiltrato all’interno dell’organizzazione brigatista che sarebbe riuscito a mettere le mani allo stesso Memoriale da favorire gli interessi di Giulio Andreotti (le borse scomparse). La vicenda è ricordata di Willan. Si veda in oltre Satta, cit., p. 183- 184. Satta ricorda che questo racconto non fu mai preso in considerazione dalla Commissione Moro e per questo si tratterebbe di una supposizione poco attendibile.
[270] Si tratta di una frase di Solone, ripresa dallo stesso libro di Sergio Flamigni, La tela del ragno, la cui edizione è stata riveduta, ampliata, proprio dopo l’uscita del film, come ricorda lo stesso scrittore. Ivi, p. 5.
[271] Tuttavia, nella stessa intervista, Moretti dichiara che poco importa degli altri dettagli del sequestro e della prigionia di Moro, in quanto non aggiungerebbe niente di significativo da modificare il giudizio storico e politico di tale evento. Per Moretti sarebbero soltanto delle «banalità». Per tanto esiterebbero dei punti oggettivamente non chiari che però, a detta del capo brigatista, non rappresenterebbero nessun mistero decisivo. Intervista a Mario Moretti di Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, pp. 325-326. Satta, cit., p. 425.
[272] Intervista a Franceschini di Giovanni Bianconi, Corriere della Sera, 21 maggio 2003.
[273] Giovanni Bianconi, Corriere della Sera, 21 maggio 2003.
[274] È importante osservare che le conclusioni del lavoro effettuato da Satta, sono fondamentalmente divergenti dall’affaire Moro, raccontato da Martinelli e da Flamigni. Per Satta i misteri irrisoluti sono fondamentalmente quattro: 1) la moto Honda e l’eventuale ruolo ricoperto dalle due persone che erano a bordo di essa; 2) le operazioni relative al furgone brigatista di via Bitossi e l’abbandono delle automobili in via Licino Calvo; 3) l’identità di chi avrebbe commissionato il falso comunicato a Chichiarelli; 4) il luogo esatto dell’incontro di Piperno – Moretti nell’estate del 1978 e l’identità del presunto anfitrione che mise a loro disposizione un luogo non meglio precisato. Si tratta di eventi oggettivamente ancora poco chiari, che divergono clamorosamente dall’analisi portata avanti dal film in questione. Un esempio fortemente in contrasto con la tesi del film, è data dalla funzione della Loggia Massonica P2, che secondo Satta non fu affatto responsabile dell’andamento delle indagini, di nessuna collusione oscura, e tanto meno di aver determinato l’uccisione di Aldo Moro. L’autore, anche attraverso questa relazione, evidenzia l’insostenibilità del complotto e del «delitto in appalto». Satta, cit., pp. 420; 424-425.
[275] Deleuze, cit., p. 140.
[276] Martinelli, cit., p. 12.
webmaster Fabio D'Alfonso