
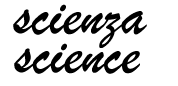
 |
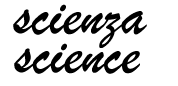 |
LA TROMBOEMBOLIA POLMONARE E I FILTRI CAVALI di Stefano dott. Montanari
Stefano Montanari, nato nel 1949, si è laureato nel 1972 in Farmacia presso l’Università di Modena. Da allora ha collaborato in qualità di tecnico e progettista con varie ditte italiane e straniere nel campo dell’emodialisi, della cardiologia, della cardiochirurgia, ecc.
Da molti anni si occupa di filtrazione cavale, campo nel quale ha offerto la propria collaborazione nel progetto e nello sviluppo di vari filtri, permanenti e temporanei.
Recentemente ha messo a punto il primo sistema che permette l’espianto di un filtro per vena cava senza alcun limite di tempo d’impianto.Tra tutte le patologie, la tromboembolia polmonare ricopre senza dubbio un ruolo molto particolare. La letteratura riporta regolarmente come questa sia, per numero di decessi, la terza causa di morte a livello mondiale e la prima tra i pazienti ospedalizzati. Gli anatomo-patologi sono concordi nel denunciarne la sottostima a livello diagnostico di uno o due ordini di grandezza. Gli statistici ne costatano l'aumento dell'incidenza ad ogni rilevamento, per quanto incerti e frutto di estrapolazioni i rilevamenti siano, e questo a dispetto degl'indubbi progressi compiuti in campo farmacologico.
Eppure, quando s'interrogano medici e chirurghi di qualsiasi specialità sulla loro casistica personale, la risposta è quasi invariabilmente: nel mio reparto non ho tromboembolie polmonari; oppure: noi facciamo prevenzione con l'eparina a basso peso molecolare ed embolie non ne vediamo più; oppure ancora: sì, qualcosa abbiamo visto: un caso due o tre anni fa; fino ad arrivare all'incontro personale con un primario anestesista di un ospedale mportantissimo il quale mi disse che "l'embolia polmonare esiste solo sui libri". Ma i dati qualitativi di cui all'esordio restano, così come restano i 20.000 morti per anno che gli addetti ai lavori stimano per difetto in Italia.
E allora? E allora, senza il coraggio di mettere serenamente e senza preconcetti né condizionamenti in discussione tutto quanto si è fatto e si sta facendo, il rischio concreto è quello di autoconvincersi che la strada intrapresa è non solo la migliore sempre e comunque ma l'unica possibile, e così vinceremo tutte le battaglie ma perderemo la guerra.
Nel 1856 il patologo tedesco Rudolf Virchow pubblicò un articolo che dava conto delle condizioni e delle sollecitazioni necessarie perché il sangue coaguli patologicamente all'interno dei vasi. Questi fattori, noti come
"Triade di Virchow", sono: l'ipercoagulabilità, la lesione parietale e il rallentamento del flusso. L'ipercoagulabilità implica una chimica del sangue secondo cui la coagulazione avviene dietro sollecitazioni che normalmente
sono insufficienti per provocare effetti del genere. Il sangue coagula poi nel caso in cui la parete interna (intima) del vaso - vena o arteria che sia - risulti in qualche modo lesa o, infine, quando il flusso sanguigno sia per qualsiasi ragione rallentato o, addirittura, arrestato.
Una volta che il sangue coaguli all'interno di un vaso - all'interno di una vena, per quanto interessa la nostra trattazione - la massa che si forma (trombo) può aderire alla parete, consolidarsi e restarvici per sempre; oppure può accrescersi nel senso del flusso (verso il cuore per quanto riguarda la circolazione venosa) e può, infine, rompersi, con i frammenti che vengono trasportati dal sangue. Per motivi anatomici tutti i frammenti (emboli)
di cui si è detto finiscono nel circolo polmonare con il rischio di ostruirlo, raramente del tutto, spesso in parte. Questa condizione, nota come "tromboembolia polmonare", ha vari gradi di gravità, da quella inavvertibile da parte del paziente, ad un'amputazione funzionale del polmone o dei polmoni colpiti, fino alla morte.
Le condizioni di rischio che conducono alla cosiddetta "trombosi venosa profonda" - cioè all'instaurarsi di un trombo nel lume di una grossa vena, spessissimo degli arti inferiori o della pelvi - origine della tromboembolia
polmonare, sono numerosissime e sono da ricondursi alla Triade di Virchow.
Ricorderò qui, tra le moltissime, quasi tutti gl'interventi chirurgici, l'obesità, i traumi, l'immobilità, l'uso di antiprogestinici (la pillola antifecondativa), il diabete, il lupus. A proposito delle chirurgie, mi limiterò a ricordare l'incidenza della trombosi venosa profonda in qualche specialità, con una variabilità che è funzione del tipo d'intervento: in chirurgia generale si va dal 20 al 50%, in ginecologia maggiore dal 19 al 29, in chirurgia urologica dal 28 al 58, in chirurgia toracica dal 12 al 26, in neurochirurgia dal 4 al 40 e in ortopedia dal 40 al 78% con la punta massima per quest'ultima che corrisponde agl'interventi di artroprotesi.
Curiosamente, e con le dovute eccezioni, sono proprio gli ortopedici, però, a negare più d'ogni altro specialista la presenza di tromboembolie polmonari nella loro popolazione di pazienti. La cosa può trovare spiegazione nel
fatto che la mortalità per questa malattia in quella specialità trova il suo picco tra la ventesima e la quarantesima giornata per protrarsi ancora parecchi mesi, quando il paziente sfugge all'osservazione dell'ortopedico.
Ciò che può essere spunto di riflessione è il dare un'occhiata a ciò che avviene negli Stati Uniti d'America e paragonarlo a quanto capita da noi.
Là le diagnosi di tromboembolia polmonari sono di qualche ordine di grandezza più numerose che in Italia, eppure sono proprio gli americani a lamentare la sottostima della patologia e a denunciare come tante morti ufficialmente attribuite ad infarto del miocardio o ad ictus cerebrale o alle cause più disparate siano, in realtà, da imputare all'embolia polmonare. Sono loro ad affermare che le patologie di origine venosa hanno un costo sociale triplo rispetto a quelle di origine arteriosa cui si è tradizionalmente più attenti.
Sono loro a sottolineare l'insufficiente interesse della classe medica nei confronti di queste patologie devastanti.
Ragioni per spiegare - non per giustificare - la situazione ce ne sono tante: le patologie venose - la tromboembolia polmonare in primis - non hanno "glamour".
Sono difficili ed incerte da diagnosticare, con un numero altissimo di falsi negativi. Non sono sempre facili da curare. In aggiunta, non raramente seguono un comportamento poco prevedibile. Allora, quando la morte sopravviene per tromboembolia polmonare, se proprio ci se n'accorge, questa viene fatta passare di fronte ai parenti del defunto come un evento ineluttabile e la cosa viene di norma accettata con rassegnazione. Del resto, nel nostro paese le autopsie sono viste come una specie di vilipendio di cadavere e sono i parenti stessi ad implorare che non siano eseguite. E così, occhio non vede, cuore non duole e il medico non ha il feed-back necessario per accorgersi dell'errore commesso dal quale non impara, perciò, nulla, corroborando, anzi, la convinzione che la tromboembolia polmonare ai suoi pazienti non capiti mai. Poi ci sono le mancate diagnosi a monte: anche la trombosi venosa profonda - come si è detto l'origine dell'embolia polmonare quando si eccettui
la relativamente piccola percentuale della trombosi atriale - viene diagnosticata ben al di sotto della sua reale incidenza. E ancora c'è il problema della valutazione della pericolosità delle trombosi venose profonde. Dal punto
di vista tecnico quasi non esiste trombosi che non embolizzi, cioè che non si frammenti in qualche misura e i cui frammenti non entrino nel circolo sanguigno. Il più delle volte il fenomeno è ampiamente contenuto entro limiti
di asintomaticità, ma le sorprese non mancano anche da focolai all'apparenza innocui. Un caso personale recentissimo è di un decesso per tromboembolia polmonare a causa di un'apparentemente inoffensiva frattura metatarsale.
E poi ci sono le terapie mediche: l'eparina calcica, le eparine a basso peso molecolare sono estremamente comode e, spesso, efficaci. Spesso: non sempre e non per sempre. Esistono individui nei quali le eparine hanno efficacia scarsa o nulla, così come esistono casi nei quali è materialmente impossibile somministrare il farmaco e altri in cui è impossibile continuare a somministrarlo o è oggettivamente inutile continuare a farlo, e lo si fa ugualmente, salvo poi avere delusioni. Lo stesso dicasi per i farmaci anti-vitamina K impiegati in profilassi, non privi di controindicazioni e non sempre così facili da maneggiare, eppure non di rado prescritti con grande liberalità e, mi si lasci dire facendo sempre salve le debite eccezioni, con una certa spensieratezza.
Tanto per ricordare qualche dato riportato da Lancet nel 1996, se si prendono in considerazione i pazienti in carico ai centri specializzati nella terapia anticoagulante, quindi quelli trattati al di sopra di ogni sospetto secondo
i protocolli canonici, il rischio emorragico è su 7,6/100 pazienti/anno, così ripartito: 0,25 emorragie fatali, 1,1 emorragie maggiori, 6,2 emorragie minori. Il che significa che se un paziente resta in terapia 10 anni ha
una probabilità su 40 di morire per un incidente emorragico indotto dal farmaco. Recentemente, nell'agosto 2001, il Ministero della Sanità Francese ha emesso un comunicato di avvertimento nel quale riferisce come in quel
paese 17.000 ricoveri ospedalieri all'anno avvengano per emorragie da farmaci anti-K e come questi farmaci siano responsabili dell'8% delle emorragie cerebrali. Nella mia esperienza personale, che è quella di chi per professione va a "mettere delle pezze" quando ormai il guaio è fatto, vedo casi di pazienti in terapia anticoagulante coagulare in maniera imponente, con varie modalità e a volte recidivare nelle migrazioni tromboemboliche, così come vedo pazienti soggetti alla stessa terapia vittime di continue e fastidiose, magari piccole, emorragie. Problemi oggettivi, questi, che trascurano per giunta il costo sociale di un simile trattamento che costringe a controlli quanto mai frequenti con tutto ciò che la cosa comporta. Davanti alla moltitudine di soggetti anticoagulati farmacologicamente per tempi lunghissimi, io mi sono sempre chiesto, e mi chiedo ancora, se un bilancio tra i rischi, i costi e i benefici sia davvero sempre calcolato oculatamente, paziente per paziente, tenendo serenamente conto di tutte le variabili in gioco. Mi chiedo quanto si cerchi di attagliare veramente la terapia al singolo soggetto.
Mi chiedo perché, davanti a recidive tromboemboliche sotto terapia si continui cocciutamente per una strada che l'evidenza del caso singolo, che è quello che di volta in volta conta, ha dimostrato di non condurre alla meta desiderata. E c'è il problema dei protocolli: non è troppo raro assistere a casi nei quali i protocolli di prevenzione vengono applicati in maniera meccanica ed acritica che non si adatta al singolo paziente.
Mi permetto qui di ricordare un concetto ben noto ai biologi, cioè come le differenze individuali si accrescano con il salire nella scala biologica: praticamente trascurabili negli organismi monocellulari che si riproducono per divisione o, comunque, per partenogenesi, sempre più grandi dal momento in cui la riproduzione diventa sessuata e il patrimonio genetico si fa più complesso, tanto elevata da essere obbiettivamente assai difficile da controllare e da prevedere nell'uomo. Il pretendere di estendere protocolli buoni per chiunque, senza spazio per valutare correttivi e modifiche individuali anche importanti è, almeno dal punto di vista biologico, una semplificazione che può essere di certo comoda da più di un punto di vista, magari anche legale, ma che è sbrigativamente ingenua e priva di solidi presupposti scientifici. Sarebbe come se un sarto pretendesse di vestire Rigoletto con la giacca dell'antropometricamente medio signor Rossi.
I protocolli, insomma, se sono fatti bene hanno tante più probabilità di colpire mediamente il bersaglio quanto più alto è il numero di soggetti su cui vengono applicati; ma se quel protocollo viene seguito alla cieca su un solo paziente, come accade quando il medico si trova a fronteggiare un malato (non una malattia), le probabilità di andare a segno, che pure restano e sono, magari, anche molto buone, calano drasticamente. E' come se, giocando alla roulette, noi puntassimo, ad esempio sullo zero. Più il numero di giocate si alza, più ci avviciniamo al vero se diciamo che lo zero uscirà una volta su 37. Ma se le giocate sono solo 37, lo zero potrà uscire da 37 volte a mai. Questo non toglie che, su una serie di 37 giocate, lo zero possa uscire effettivamente una volta sola, ma il fatto sarebbe del tutto casuale e non avrebbe nulla di scientifico. E' dunque imprudente fidare sulla statistica quando questa sia applicata al di là delle sue possibilità, cioè sul caso singolo.
Tornando a noi, per i casi - percentualmente in minoranza - nei quali, per una ragione qualunque che il medico è chiamato ad individuare per mezzo delle sue conoscenze e della sua intelligenza, non sia indicata o attuabile una corretta terapia farmacologia, esistono i sistemi d'interruzione meccanica della vena cava, oggi limitati ai "filtri cavali". Si tratta di sistemi che trovano giusta applicazione anche con terapie mediche in atto, quando si tema un'embolizzazione della trombosi che si sta trattando. Per motivi non facilmente spiegabili senza imbarazzo, questi presidi sono sempre stati guardati con grande sospetto dalla classe medica e su di loro è fiorita e si è tramandata una tradizione orale degna del miglior romanzo gotico.
Se ci si prende la briga di osservare imparzialmente i dati, si scopre, invece, come questi oggetti siano in assoluto quelli che hanno dato e danno il minor numero di guai, invero pochissimi, tra tutte le protesi ed i sistemi ad applicazione endovascolare, dalle valvole cardiache agli stent alle endoprotesi.
Si aggiunga a questo il fatto che un buon filtro cavale (è importante che sia buono davvero) non ha bisogno di alcuna terapia di supporto a differenza di altri dispositivi per impianto analogo. Eppure ancora oggi si sentono
relazioni esposte a congressi anche importanti nei quali si esclude l'uso del filtro cavale perché "il paziente dovrebbe restare anticoagulato a vita", così inducendo gl'inesperti non solo a rinunciare ad un'arma potente, ma
ad informare scorrettamente i loro pazienti sulle possibilità e sulle alternative che la tecnologia concede. In parte responsabile di questa cattiva stampa è la guerra in cui sono comprese falsità che travalicano il ridicolo ma
che, pubblicate, diventano "letteratura", guerra che le case farmaceutiche hanno sempre visto di buon occhio contro i filtri, forse temendo un decremento dei loro fatturati, senza comprendere che farmaci e sistemi meccanici non sono affatto in concorrenza tra loro ma hanno applicazioni diverse e, spessissimo, complementari. L'industria farmaceutica dovrebbe invece premere per una migliore diagnostica della trombosi venosa profonda se volesse incassare di più e, magari, fare anche un'opera meritoria. Tutt'altro che esente da colpe è l'industria stessa che i sistemi meccanici d'interruzione li produce.
Questi oggetti sono difficili da progettare bene, hanno costi industriali relativamente alti e hanno un valore aggiunto poco interessante. Inoltre per farli conoscere ed apprezzare come meriterebbero occorrerebbero investimenti notevoli che il mercato non giustifica. E allora anche chi questi dispositivi ce li ha in catalogo li trascura e li tratta come un prodotto "me too": il filtro cavale ce l'ho anch'io. Infine c'è il medico, l'ematologo o il coagulologo in particolare, che ha per sua cultura in antipatia tutto ciò che si rifà a principi di fisica. Ora, fortunatamente, 'intravedono segni d'inversione di tendenza, vorrei dire di ravvedimento, certo di sprovincializzazione culturale, tanto che alcuni clinici ed ematologi di grande prestigio e di grande esperienza hanno cominciato a prescrivere ad alcuni dei loro pazienti l'interruzione meccanica della vena cava, spesso abbinata ad una terapia con i farmaci. E proprio grazie a quegli clinici ed ematologi - oggi ancora pochissimi, in verità - che hanno tolto l'annoso veto e alla cultura medica generale che si sta aprendo, gl'impianti di filtri cavali stanno crescendo di numero in Italia: dagli 800 di sei o sette anni fa ai 1.300 degli ultimi anni '90 ai forse quasi 2.000 dell'anno 2001. Sempre un numero irrisorio, comunque, rispetto alle necessità reali, se si pensa che nei già menzionati Stati Uniti d'America gl'impianti superano le 40.000 unità annue. Dovunque, però - e l'America non fa eccezione - così come esistono casi in cui il filtro è indispensabile ma non viene applicato, ne esistono altri in cui il paziente si ritrova un filtro nella vena cava senza che l'indicazione sia pressante o esista affatto. Ecco allora la necessità di un'azione che renda chiare finalmente le modalità d'impiego di un dispositivo che, se usato a proposito, è capace di salvare migliaia di vite ogni anno.
Ma che cos'è un filtro cavale? Non è altro che una barriera posta all'interno della vena cava inferiore, capace di catturare i trombi che embolizzano verso il circolo polmonare, lasciando agevole passaggio al sangue. Molti
modelli diversi (Figg. 1, 2, 3, 4) si sono susseguiti negli anni e molti miglioramenti tecnici sono stati attuati.Fig.1 - Clip di Pate Fig. 2 - Filtro di Mobin-Udin Fig. 3 - Filtro di Greenfield Fig. 4 - Filtro LGM Il principio su cui si basa la cattura attuata dai filtri moderni (dal filtro di Greenfield in poi) è quello secondo cui, per ragioni di dinamica dei fluidi, l'embolo viaggia lungo l'asse della vena cava e lì deve esistere una zona nella quale il filtro ha maglie particolarmente strette. Il resto della sezione cavale ha, invece, una grande pervietà.
Quanto all'impianto, lo si compie in maniera percutanea attraverso un piccolo foro praticato nel collo, in un braccio o all'inguine, una manovra ormai diventata semplicissima, rapida e praticamente scevra da rischi. Si entra
nel sistema venoso con un sottile catetere la cui estremità viene posta nella zona in cui le vene renali confluiscono nella vena cava e da questo catetere viene fatto fuoriuscire il filtro. Il posizionamento normale è quello poco al di sotto delle vene renali, ma nulla osta all'impianto soprarenale, a patto che ciò che s'impianta sia un filtro di ottime caratteristiche per quanto concerne l'assenza di trombogenicità.
Occorre subito chiarire quali siano le possibilità e i limiti di questi dispositivi. Chi, in passato, medico o industriale, abbia indicato i filtri per vena cava come la soluzione del problema delle tromboembolie polmonari ha sicuramente commesso un peccato di leggerezza. Chi li abbia impiantati senza indicazioni - indicazioni che sono fondamentalmente riconducibili ai casi in cui la farmacologia sia insufficiente, non pratica, abbia fallito o sia inutile per l'ambiente ematochimico in cui dovrebbe andare ad agire - forse non ha provocato problemi evidenti al paziente ma ha compiuto un'operazione quanto meno non giustificata. In generale il filtro cavale arresta con un
buon margine di sicurezza i trombi embolizzanti che superino una determinata dimensione (mediamente 3 mm di diametro).
Il trombo catturato può venire frammentato se è fresco - come è nella maggior parte dei casi perché sono questi che si staccano - oppure, se l'organizzazione (invecchiamento) è già iniziata e il trombo si è retratto cominciando a consolidarsi, può restare intrappolato al vertice del sistema per qualche ora o anche per qualche
giorno, fino a che non viene sciolto spontaneamente. Filtri di buona qualità intasati cronicamente da trombi non esistono, le eccezioni essendo appunto costituite da filtri inadeguati per progettazione, e questo ndipendentemente
dal successo commerciale di cui i prodotti godano o abbiano goduto. E, a proposito della cattiva progettazione, sarebbe sufficiente che chi impianta i filtri possedesse gli elementi tecnici di base per poter scegliere il presidio con cognizione di causa e punisse con un mancato acquisto quelle industrie che non si rivelassero all'altezza. Il filtro, dunque, è un sistema passivo basato su di una fisica elementare e che, salvo qualche eccezione che vedremo tra poco, fa ciò che promette: impedisce ai trombi di migrare nel circolo polmonare. Più di tanto non può fare. Quindi tutto quanto avviene a valle di flusso esula dalla competenza dell'oggetto (ad esempio una tromboembolia
che abbia origine all'interno del cuore) così come il filtro non può arrestare fenomeni microembolici o trombosi a partenza distale (a monte del filtro) che, accrescendosi, lo inglobino (un fenomeno poi ritenuto erroneamente
una trombosi di cui incolpare il filtro (fig. 5)Fig. 5 - Trombosi di origine caudale che ingloba il filtro Un altro problema che ingenera confusione è quello di voler riunire in una sorta di categoria platonica "i filtri cavali". Alla prova dei fatti esiste una grande diversità tra filtro e filtro. Questi differiscono per idrodinamica, con il problema dei coni inversi che toccheremo tra poco; per occlusività (il rapporto tra sezione cavale occupata e sezione cavale anatomica) che consegue, almeno in parte, in tasso di trombogenicità (la capacità di indurre
la formazione di trombi); per volumi di stasi: punti, cioè, in cui il flusso sanguigno viene rallentato o impedito; per capacità d'invito, cioè l'essere in grado d'indirizzare l'embolo verso il vertice del cono; per angolo efficace,
cioè l'angolo tra gamba e gamba che è fortemente responsabile dell'efficienza del dispositivo; per elasticità; per capacità di sistemarsi in asse all'interno del vaso; per scelta del materiale, dato che non tutti i metalli impiegati
sono ugualmente adatti alla bisogna; per presenza di saldature che costituiscono i punti preferenziali d'innesco dei fenomeni corrosivi che portano alla rottura del presidio e a scadimento della sua biocompatibilità; per presenza
di zone lavorate a freddo, zone che, incrudite dalla manovra, sono prone alla rottura (fig. 6); per disposizione del filtro nel periodo d'immagazzinamento che precede l'uso, disposizione che, se mal concepita, può portare ad una
parziale o, addirittura, ad una mancata apertura (fig. 7); per concezione dei dispositivi di aggancio alla parete venosa, che potrebbero rivelarsi critici per mettere al sicuro da eventuali migrazioni, cioè spostamenti
del filtro stesso dalla sua sede.
Malauguratamente l'industria si è occupata più degl'impiantatori e degli amministrativi che non dei pazienti e così, nel tempo, hanno visto la luce veri e propri mostri i quali, non raramente, hanno vissuto momenti di fulgore
con tanto di letteratura laudatoria corredata di firme anche di buona caratura a supporto. Se quelli che ho definito "mostri" oggi non esistono più, essendone alla fine stata fatta giustizia, si noti, tuttavia, come esistano ancora
filtri con evidenti errori di progettazione quali, ad esempio, quelli a doppio cono reciprocamente invertito. Si tratta di strutture che presentano un cono filtrante prossimale orientato con il vertice che punta cranialmente (verso la testa), e un altro cono, posto a monte di flusso, orientato all'inverso.
Stante la simmetria del disegno rispetto al piano trasversale, l'espediente consente di servirsi di un kit unico sia per gl'impianti ad approccio giugulare (dal collo), o alto in genere (per es. brachiale), sia per quelli ad approccio
femorale (dall'inguine), così perdonando eventuali distrazioni dell'impiantatore e facilitando l'approvvigionamento. Purtroppo, però, filtri così concepiti saranno pure comodi ma hanno irrimediabilmente scarsa efficacia (il cono
a monte devia gli emboli dalla loro traiettoria, ostacolandone l'ingresso nel vertice del cono a valle) e sono, quale più, quale meno, trombogenici (l'interno del vertice del cono invertito che sta a monte costituisce un punto in cui il flusso è assente).Fig. 6 - Gamba rotta di filtro LGT Fig. 7 - Filtro Anthéor parzialmente chiuso E' ovvio, poi, che un trombo che si formi all'interno del cono invertito allontana gli emboli dal percorso assiale più di quanto già non faccia il cono invertito stesso, con ciò indebolendo ulteriormente le capacità di cattura del cono a valle. Inoltre l'interno del cono invertito è potenzialmente sede di corrosioni intergranulari, non godendo di un flusso ematico adeguato.
Anche l'angolo efficace è insufficiente in questi filtri, dato che lo spazio impiegato per tutta la porzione caudale toglie la possibilità di usare un cono filtrante (quello di valle) che possieda l'altezza giusta. Da ultimo c'è il problema, piuttosto grave, degli agganci. Nei filtri a doppio cono questi sono sempre poco efficienti con conseguenti migrazioni del dispositivo.
Quanto appena riportato è ben noto ai costruttori, tanto che quando, per errore, un filtro viene impiantato a vertice che punta caudalmente (verso i piedi), l'unico pur parziale rimedio a cui i libretti d'istruzione consigliano
di ricorrere è l'impianto di un altro filtro più a valle. Eppure ancora oggi filtri del genere tentano, e con qualche successo, la fortuna sul mercato.
Con tutto questo, ripeto quanto ho affermato all'inizio, cioè che nessun dispositivo per impianto intravascolare è sicuro ed efficace quanto un filtro per vena cava. Se poi fosse anche di buona qualità... Spesso mi viene chiesto se i filtri cavali siano compatibili con la risonanza magnetica e se siano biocompatibili. Alla prima domanda la risposta è senz'altro sì: i portatori di filtri moderni possono tranquillamente sottoporsi a quel tipo d'indagine senza alcun rischio. La seconda domanda richiede una risposta più articolata perché bisogna intendersi sul concetto di biocompatibilità.
Ciò che viene di norma valutato è la compatibilità biologica del materiale massiccio impiantato in un tessuto vivente, spesso il sottocute dei ratti, così ottenendo determinati risultati. Quando, però, dal materiale si ricavano
manufatti - dispositivi da impianto intravascolare nel nostro caso - la reazione dell'ospite può non essere quella che la documentazione ottenuta con le prove abituali lasciava credere. Questo perché forma e funzione del
presidio sono importanti almeno quanto il materiale impiegato. E importantissimi sono anche gli eventuali prodotti della degradazione chimica, cioè della corrosione, che possono benissimo non essere biocompatibili a dispetto del materiale da cui derivano. Così, nel caso in questione, i materiali utilizzati per la costruzione dei filtri cavali sono tutti biocompatibili ai test di legge, mentre i prodotti finiti hanno gradi di biocompatibilità differenti.
Per esempio, un filtro costruito in modo da avere punti da cui s'inneschino fenomeni trombotici io non lo definirei del tutto biocompatibile, così come terrei in qualche sospetto un filtro le cui saldature possono ospitare fenomeni
di corrosione. Una delle obiezioni che vengono frequentemente opposte all'uso dei filtri è la scarsità di studi comparativi a grandi numeri tra questo tipo d'interruzione meccanica e, per esempio, l'eparina.
Dal punto di vista meramente scientifico la cosa è improponibile, stante la disomogeneità dei vari filtri fra loro, e quando ci si trova a lavorare con elementi disomogenei cade ogni criterio di scientificità, come insegna ogni professore di matematica di scuola media. Al massimo si potrebbe confrontare un determinato filtro ad un determinato farmaco in un determinato centro, ferme restando, tuttavia, le diversità individuali tra paziente e paziente di cui si è accennato. Oppure si potrebbe studiare una popolazione sufficientemente vasta di pazienti portatori di un determinato filtro con una popolazione a quella omogenea che non porti il filtro. Cosa, peraltro assai complessa, che non è mai stata fatta. Così anche quel poco di pubblicato che esiste non ha grande significato e le discordanze tanto vistose nelle varie conclusioni ne sono la prova più lampante.
E poi, comunque, già il confrontare filtro e farmaco è errato, trattandosi di strategie che ben poco hanno a che fare l'una con l'altra, pur mirando in sostanza ambedue al fine comune d'impedire il verificarsi di tromboembolie
polmonari. Cercando di dare una regola generale, i farmaci servono ad impedire la formazione o l'estensione di una trombosi; i filtri impediscono che una tromboembolia diventi polmonare. Nella maggior parte dei casi i sistemi
sono in tutto e per tutto complementari, con l'approccio farmacologico da impiegare da solo quando esista la certezza che, come del resto è nella maggioranza dei casi, questo funzioni e non faccia guai. Il filtro da solo
s'impiegherà, invece, quando i farmaci non si possano utilizzare con profitto o non si possano utilizzare tout court. Farmaci e filtro insieme fanno in genere una bellissima coppia.
A corollario di quanto detto, è opportuno sottolineare l'esistenza di un problema interessante legato all'uso cronico dei farmaci. Praticamente ogni medicamento si unisce chimicamente a molecole presenti nel sangue, costituendo composti indesiderati di cui si ha poca o nessuna conoscenza, tanto per quanto riguarda la presenza stessa quanto per quanto riguarda gli eventuali effetti. Non è raro che queste sostanze non siano eliminate e si accumulino nell'organismo, con questo accumulo che diventa importante quando il farmaco sia impiegato abbastanza a lungo. Dunque, prima d'instaurare una terapia a vita come si fa per gli "anticoagulanti" tipo gli anti-K sarebbe bene tener conto del problema.Fig. 8 - Filtro ALN Frutto di studi italo-francesi, esiste oggi un filtro cavale chiamato ALN (fig. 8) che è la summa di tutte le conoscenze e di tutte le esperienze collezionate fino ad ora, dalla perfetta tollerabilità al dispiegamento certo stante il confezionamento in apertura che previene l'eventuale perdita di memoria elastica, dall'assenza di saldature all'occlusività ridottissima, dall'assenza di volumi di stasi che lo rendono del tutto non trombogenico alla capacità di arrestare trombi embolizzanti di diametro fino a 2 mm.
Altre caratteristiche interessano principalmente l'impiantatore (che raramente è colui il quale ne pone l'indicazione): un diametro del sistema di posa di appena 7F (2,33 mm), un accesso possibile da ambo le vene femorali, dalla giugulare destra e dalla basilica (la vena che sta dalla parte del mignolo alla piega del gomito), l'allineamento spontaneo lungo l'asse cavale grazie a tre gambe molto più lunghe delle altre sei, l'eccellente stabilità grazie alla lunghezza differenziata delle sei gambe più corte uncinate, la buona radio-opacità nonostante la sottigliezza della struttura, la perfetta compatibilità con qualsiasi tipo d'indagine radiologica. Ma la caratteristica che rende questo filtro veramente unico è la possibilità di essere espiantato senza alcun limite di tempo. E l'espianto si esegue con grande semplicità e velocità in qualsiasi sala angiografica mediamente attrezzata tramite un sistema di prelievo per approccio percutaneo giugulare destro del diametro di 9F (3 mm).
Come per ogni buon filtro cavale definitivo - quei filtri, cioè, chiamati a restare per tutta la vita nel paziente - anche questo - che è un definitivo a tutti gli effetti e come tale può rimanere per sempre impiantato - non
necessita di alcuna terapia anticoagulante. Questo a differenza dei filtri cosiddetti temporanei, classe oggi tecnicamente superata a causa dei tanti problemi che davano contro i pochi che risolvevano (fig. 9) e sul viale
del tramonto, che devono di necessità operare in un sangue anticoagulato, pena il rapido instaurarsi di una trombosi. Una delle grandi limitazioni che hanno impedito la diffusione dei filtri temporanei (cateteri con una
sezione distale filtrante) è la loro impossibilità a restare impiantati al di là di qualche ora o di qualche giorno, a rischio di trombosi e d'imprigionamento della struttura nel tessuto neointimale che, formandosi rapidamente, ne
impedirebbe l'espianto o, per lo meno, renderebbe l'espianto una manovra rischiosa.
Fig. 9 - Filtro temporaneo RF02 trombizzato
L'ALN, invece, grazie alla sua architettura particolare, non trombizza e non promuove alcuna crescita rilevante di tessuto, come l'ormai buona esperienza di espianti a quasi un anno dalla posa mostra chiaramente, sì che è possibile toglierlo con la stessa facilità ed atraumaticità indipendentemente dal tempo durante cui è restato in situ. E superato è anche l'altro grave problema dei filtri temporanei, quello, cioè, di essere collegati ad un catetere che, oltre ad essere trombogenico, protrude dal punto di accesso a livello cutaneo e che è sito d'innesco di fenomeni infettivi. In aggiunta, il catetere in questione è quanto mai scomodo per il paziente che, muovendosi, può pure farlo risalire verso il cuore. Come ogni filtro definitivo, l'ALN è totalmente impiantato e perfettamente insensibile per il portatore il quale non subisce limitazioni di sorta al suo stile di vita. Da non dimenticare, poi, che l'uso di un filtro temporaneo prevede il ricovero ospedaliero, a differenza dell'impiego di un filtro ALN con il quale il paziente viene dimesso a poche ore dall'impianto e rientra in ospedale solo, e ancora soltanto per poche ore, perché sia eseguito l'espianto.
Nell'esperienza fino ad ora raccolta, al di là degl'impieghi tradizionali che restano immutati, il sistema ALN ha trovato felice applicazione nei politraumatizzati, nelle puerpere, nei pazienti destinati alla sala operatoria,
in tutti quei soggetti, insomma, nei quali il pericolo di tromboembolia polmonare costituisca una minaccia reale ma superabile nel tempo e nei quali l'anticoagulazione sia poco raccomandabile. E applicazione ha trovato anche
nella soluzione del dubbio tradizionale: definitivo o temporaneo? L'ALN è senz'altro un filtro definitivo, ma il medico ha la possibilità di sbarazzarsene quando non servisse più, non tanto perché l'ALN abbia caratteristiche di
temporaneo ma perché esiste un dispositivo per espiantarlo. Un filtro con queste caratteristiche protegge con sicurezza, senza effetti collaterali, e lo fa per tutto il tempo che si desideri. Nei pazienti ortopedici, ad esempio - per ricordare quanto si era detto a proposito della mortalità il cui picco è parecchio ritardato rispetto al momento dell'intervento chirurgico e che, in ogni caso, si protrae a lungo - il filtro può essere lasciato per molti mesi, ben dopo la sospensione della terapia eparinica che di prassi si mette in atto, e tolto se e quando si reputi che la protezione non sia più necessaria. Anche l'annoso dibattito, che nella mia esperienza personale ha portato fino ad esiti tragicamente irrecuperabili, sull'opportunità d'impiantare un filtro ad un giovane, non ha più ragione di esistere, tanto che nella nostra casistica abbiamo pure degli adolescenti (13 anni) e degli atleti.
Il dubbio che a questo punto avanzano di solito gl'impiantatori è quello relativo all'endotelizzazione, cioè la crescita di tessuto che il filtro innescherebbe e ne impedirebbe l'estrazione. Il processo (fig. 10), in realtà, esiste anche per l'ALN ma, a causa della struttura particolare, interessa un tratto limitatissimo delle zampe, dell'ordine del illimetro o due, laddove le gambe emergono dalla parete.
Fig. 10 - Tessuto fibrino-ematico cresciuto sul filtro ALN Come per tutti gli altri filtri la durata della crescita tessutale è dell'ordine di una ventina di giorni, passati i quali quel che è fatto è fatto. La differenza è che negli altri filtri il fenomeno è di proporzioni tali da impedire la rimozione, come avviene, per esempio, nel sistema definitivo/temporaneo proposto già a suo tempo da Günther (fig. 11), che comincia a diventare impossibile da estrarre già a distanza di una decina/quindicina di giorni. Non così per l'ALN. L'altro motivo per il quale riusciamo ad espiantare con facilità il dispositivo è legato alla forma particolare degli agganci che, in corso di rimozione, scivolano all'interno della parete cavale e del piccolo volume di tessuto.
Fig. 11 - Filtro di Günther Un accenno ora ai casi nei quali diventa impossibile espiantare il filtro ALN. L'eventualità che balza immediatamente alla mente è quella della cosiddetta trombosi del filtro che, si è detto in precedenza, è in realtà attribuibile alla crescita in senso di flusso di un trombo fino ad inglobare il dispositivo.
Fortunatamente, nei circa 16.000 impianti effettuati la cosa non si è mai verificata ma, comunque, chi si dovesse trovare in quella situazione non tenti l'estrazione, rimandandola, magari, al termine di una trombolisi (dissoluzione
farmacologica o meccanica del trombo) che abbia avuto esito fausto. Il caso, invece, che si è realmente posto, e per due volte, è quello delle gambe uncinate del filtro localizzate in vene differenti: l'iliaca destra e l'iliaca
sinistra in un paziente, l'iliaca e una sua collaterale in un altro. Chi abbia familiarità con il sistema di estrazione (fig. 12), nel quale un catetere deve scivolare sul filtro dalla testa inguainandolo per intero (figg. 13, 14, 15) capirà come nei casi riferiti la manovra sia impossibile. Se la localizzazione in vene differenti è a carico delle sole gambe non uncinate, invece, non esistono problemi nell'ablazione. Si noti, però, che impianti ectopici del genere sono ascrivibili ad errori dell'impiantatore il quale, approcciando per via alta, spinge lo spingitore invece di mantenerlo fermo e ritrarre la guaina. Altro errore in cui l'impiantatore può incorrere è il far alzare il paziente troppo presto, prima, cioè, di tre o quattro ore dalla posa del filtro, favorendo, così, una migrazione caudale. I fallimenti
nelle estrazioni, comunque, sono eventualità davvero rarissime, mentre in genere la manovra viene eseguita in tempi che raramente superano i cinque minuti.Fig. 12 - Sistema di rimozione ALN Nel caso relativamente frequente in cui il cono filtrante contenga trombi, se questi non sono di dimensione enormi, e non è mai capitato che lo siano, vengono estratti con facilità insieme con il filtro. Nella manovra questo, infatti, non viene mai spostato dal proprio livello fino a che non è del tutto staccato dalla parete cavale e completamente inguainato, cosicché i trombi vengono imprigionati insieme con il dispositivo.
Fig. 13 Fig 14 Fig. 15 - Fasi di rimozione di un filtro ALN: ricerca della testa, cattura, inguainamento. Si era accennato in precedenza alle indicazioni. Quelle tradizionali e assolute su cui nessuno ormai discute più sono le controindicazioni alla terapia anticoagulante o quando questa non abbia avuto successo o abbia incontrato complicanze, e questi sono casi ampiamente e meticolosamente elencati e puntualizzati in letteratura. Si veda al proposito quanto scritto da Claudio Rabbia in Malattia Tromboembolica Venosa e Filtri Cavali - Edizioni Minerva Medica - Torino - pag. 141 e segg. Poi ci sono tutte le indicazioni relative con tanto di partiti schierati e tanto di criteri a punti di appropriatezza.
Queste comprendono la gravidanza, l'embolia polmonare in atto, quella recidiva e quella sospetta in corso di trattamento e non, la trombosi venosa profonda con mille sfumature di localizzazione, di forma e di valutazione di pericolosità, i traumi, le neoplasie, le varie patologie cardiache e vascolari, i trapianti d'organo, l'età, l'obesità, il diabete e altre patologie metaboliche, i vari tipi d'intervento chirurgico, le immobilizzazioni e quant'altro.
Ripassando la letteratura medica in proposito, da tecnico allenato a ragionare nei termini tutto sommato semplici, ma non semplicistici, della scienza, non posso che manifestare perplessità di fronte a tesi così diverse, tutte apparentemente ben argomentate e corredate di numeri che dimostrano di volta in volta tutto e il contrario di tutto. La cosa che balza immediatamente agli occhi, comunque, è l'errore metodologico di partenza, cioè la palese disomogeneità delle condizioni di contorno e dei criteri di giudizio adottati, oltre, naturalmente, alla debolezza di indagini statistiche su numeri troppo lontani da una qualsiasi significatività per la complessità del territorio che indagano e che pretendono di rivelare. Così il tutto assume l'aspetto di un atto di fede o di schieramento preconcetto basato sopra una serie di ipse dixit da cui la medicina non sa ancora affrancarsi. A questo punto io, non medico, non ho più voce in capitolo e lascio la palla a chi della medicina ha deciso di fare una professione.
Quanto io posso proporre è un sistema che trova fondamento nella fisica elementare su cui ogni discussione non può che essere esercizio di sofismi che alla scienza, quella ripetibile che non ha bisogno di firme roboanti,
non interessano.
Tornando alle indicazioni, al poco già detto aggiungo che il sistema ALN trova importante applicazione quando non si abbia l'assoluta certezza che la terapia medica sia efficace o quando si tema che questa possa provocare
un'embolizzazione del trombo in trattamento. Nella mia personalissima esperienza casi del genere sono tutt'altro che rari.
Le controindicazioni, ora. In realtà queste sono poche e infrequenti. Fondamentalmente sono costituite dall'inaccessibilità di tutte le via d'approccio, una trombosi cavale estesa fino nei pressi dell'atrio e i casi di tromboembolia settica (condizione che, però, in certa letteratura è data come un'indicazione).
Da anni si trattano tranquillamente anche le cave doppie e le megacave, queste ultime, se è il caso e se la localizzazione del trombo lo consente, con il posizionamento di un filtro per ciascuna vena iliaca, soluzione d'altra
parte quasi mai necessaria stanti le più che adeguate dimensioni della maggioranza dei filtri disponibili.
Quanto agli effetti collaterali, i più comuni sono quelli degli ematomi e delle trombosi al sito di puntura come conseguenza della manovra d'impianto.
Per evitare o, quanto meno, limitare di molto quegl'inconvenienti, peraltro non soliti e raramente gravi, occorre usare kit di posa di calibro abbastanza ridotto come è il caso di molti dei sistemi attuali, pungere la vena d'accesso sotto guida ecografica e, quando non controindicato, somministrare un bolo di 5.000 UI di eparina all'inizio della procedura. Per non incorrere nella temuta quanto improbabile trombosi del filtro è sufficiente sceglierne oculatamente il modello, tenendo presenti soprattutto occlusività e volumi di stasi.
Le migrazioni si prevengono sia con la scelta giusta del filtro - che deve avere un diametro adeguato alla cava da coprire, deve essere concepito in modo da aprirsi correttamente, non deve inclinarsi troppo e deve avere un
sistema di aggancio efficiente - sia operando in modo corretto, cioè effettuando un'indagine cavografica (visualizzazione radioscopica della sede d'impianto) preliminare per accertarsi di non inserire il filtro in un trombo, avendo l'accortezza di mantenere lo spingitore fermo quando si ritira la guaina e tenendo il paziente orizzontale per qualche ora ad impianto avvenuto.
Le rotture si contrastano scegliendo filtri disegnati in modo corretto, non lavorati a freddo e senza saldature.
Qui, di solito, ci s'imbatte nella pietra d'inciampo del corpo estraneo.
L'obiezione è: il filtro cavale è un corpo estraneo. Obiezione alla cui quasi tautologica evidenza io non ho argomenti da opporre: il filtro cavale è un oggetto con una massa dell'ordine di grandezza del grammo completamente estraneo alla natura dell'organismo umano. Naturalmente mi aspetto che chi avanza l'obiezione si tormenti ogni volta che un suo paziente deva mettere una protesi dentaria, oppure deva sottoporsi all'impianto di una valvola cardiaca, di un pace-maker, di uno stent - o, magari, di una manciata di stent - di un'endoprotesi, di una rete per l'ernia, di una protesi mammaria o, chissà, di mezzo chilo di protesi ortopedica. E mi aspetto che non sia del tutto tranquillo ogni volta che interferisce con l'equilibrio chimico del sangue (e non solo) prescrivendo una molecola di cui la scienza ignora i risvolti della farmacodinamica nella loro completezza, della tollerabilità e dell'efficacia nel singolo caso, cioè nell'ambiente specifico in cui è chiamata ad agire, che sa non essere priva di effetti collaterali e sia veicolata da eccipienti della cui pericolosità cominciamo a renderci conto solo ora. E a proposito dei misteri della farmacodinamica, vorrei aprire una breve parentesi: nel 1996 veniva data alle stampe in America la seconda edizione dello Handbook of Interventional Radiologic Procedures di Kandarpa e Aruny. A pagina 415 si elencava tra le controindicazioni assolute all'uso del warfarin sodico (un principio attivo anti-K molto utilizzato) l'allattamento.
Nello stesso anno la rivista Circulation pubblicava un articolo a firma di Hirsh e Hoak (Management of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. AHA Medical Scientific Statement. Circulation 93:2212, 1996) nel quale si asseriva che quel farmaco poteva essere somministrato con tranquillità in allattamento perché non passa nel latte materno. E, allora, passa o non passa? Poiché casi analoghi hanno una frequenza imbarazzante, credo si comprenderà il mio disorientamento davanti all'uso dell'aggettivo "scientifico".
Filtro per tutti, allora, è quanto tanto ironicamente quanto invariabilmente mi si chiede di solito a questo punto. La mia risposta è che l'industria mette a disposizione un sistema con le caratteristiche che ho, pur semplificandole,
descritto. A questo punto il mio compito di tecnico si esaurisce. Sta ai medici, alla loro cultura, alla loro intelligenza, alla loro sensibilità, alla loro capacità di valutazione del singolo paziente saper fare buon uso di quanto si mette loro nell'armamentario. Rifiutare a priori un'arma non è saggio e, mi sia consentito, non mi pare nemmeno onesto verso un paziente che chiede di essere informato con precisione sulla malattia di cui soffre e sulle scelte profilattiche o terapeutiche possibili. Al paziente non interessano i "partiti", le simpatie o le antipatie, i preconcetti, gl'"ipse dixit" o quant'altro. Il paziente vuole stare bene in fretta e senza seccature.
Filtro per tutti? Rispondere sì sarebbe troppo sciocco, così come sciocco è "farmaci per tutti". Ciò che posso serenamente rispondere è che con questo presidio si dispone di un mezzo certo di prevenzione tromboembolica (prevenzione e basta), praticamente privo di controindicazioni e di pericoli, nel proprio ambito efficace senza limitazioni, poco costoso se paragonato agli altri mezzi, comodissimo per il paziente, estremamente maneggevole nell'impianto e nella gestione che è nulla, capace di proteggere per tempi praticamente illimitati laddove, prima o poi, la copertura farmacologica potrebbe dover essere interrotta o potrebbe essere o potrebbe diventare inefficace. A questo proposito ricordo ancora, a rischio di confermare la mia pedanteria, i casi di morte per tromboembolia polmonare sopravvenuti dopo molti mesi dalle dimissioni da un reparto ortopedico e, purtroppo, noti quasi solo all'anatomo-patologo, sempre che sia stata praticata un'autopsia. E ricordo ancora le troppe tromboembolie polmonari sotto terapia. Ancora una volta, e finisco sul serio, sottolineo che il filtro cavale e la farmacologia stanno benissimo insieme. Basta avere la mente elastica.
(dott. stefano montanari)