
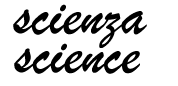
 |
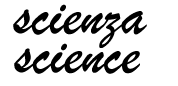 |
La Relazione d’aiuto
di Silvia Cinti
1 INTRODUZIONE
La cultura dell’Occidente, nella quale siamo inseriti e dalla quale siamo inevitabilmente condizionati, si fonda su una tradizione che pone l’io soggettivo al primo posto e parte da una visione ontologica dell’uomo.
La filosofia agostiniana che si fonda sulla ricerca dell’interiorità, quella husserliana per la quale è la coscienza il primo fondamento della conoscenza dell’assoluto, o quella cartesiana dell’io penso insegnano – sia pure su piani diversi - a ricercarci per trovare in noi stessi la prima e irrinunciabile certezza. Questo messaggio trasmette una grande fiducia nei confronti dell’uomo, al quale attribuisce la facoltà di essere lettore e costruttore della realtà, sottolineando che egli non si pone di fronte ad essa esclusivamente nella funzione di recettore. L’educazione riconoscendo la facoltà di significazione – in virtù della quale ogni individuo assimila ed elabora le informazioni che provengono dall’esterno, apportandovi un personale contributo – sviluppa la consapevolezza di poter-dover scommettere sull’uomo, insegnandogli a contare innanzitutto su se stesso per affrontare la realtà.
C’è un aspetto negativo, che caratterizza la tradizione dello sviluppo dell’io, rappresentato dalla radicalizzazione di questo atteggiamento, che comporterebbe la dimenticanza della propria intersoggettività umana. Sottolineando eccessivamente l’importanza della conoscenza di sé si rischia di dimenticare l’altro, che a sua volta ha un ”io”, una propria individualità che come tale va affiancata, rispettata e possibilmente conosciuta senza pregiudizi. E’ necessario, in educazione soprattutto, separarsi dal solipsismo e dall’egoismo per spingersi verso l’altro.
La relazione d’aiuto rivaluta la rilevanza dell’incontro con l’altro nei più svariati campi della vita sociale, nell’ambito del lavoro, delle strutture istituzionalizzate come la scuola o nell’ambito sanitario.
L’incontro è occasionale, ma anche ricercato, voluto, nella consapevolezza che l’altro è colui che può aiutare, che può accostarsi alla propria vita apportandovi arricchimento. La relazione d’aiuto si propone di sviluppare l’interiorità, la socialità, ma si propone anche il compito di essere sostegno, accoglienza, consiglio, insegnamento. Scurati[1] vede nel genitore, nell’insegnante, nell’animatore, nel formatore, nel consigliere, nel volontario, nel dirigente, nella guida spirituale i volti dell’educazione che – seppur operando in modo diverso – intervengono nel momento del bisogno, testimoniando disponibilità all’aiuto e, al contempo, come segno di questo, anche capacità di tirarsi indietro. Seppur configurata in svariate maniere si tratta sempre di relazione d’aiuto che entra nell’esistenza quotidiana dell’uomo per orientarlo. La scoperta più approfondita della propria esistenza – irrinunciabile soprattutto in una società dell’incertezza[2] come la nostra, caratterizzata dal disorientamento dell’individuo – è la risposta che l’educazione fornisce per far trovare all’individuo stesso la certezza, perché possa essere sempre protagonista indiscusso della propria vita, rispetto alla quale decidere e scegliere. La scoperta di cui si tratta non è quella che ha a che fare con i fatti comuni della vita, nei quali ci si rende conto della propria esistenza nel mondo, ma è legata al sé interiore, alla percezione ragionata che va al di là della prima immediata consapevolezza.
1.1 IL CONCETTO DI ALTRO
“ L’altro, infatti, (non solo quello interno o quello personale, ma anche quello costituito dalle cose, dalle istituzioni, dalle culture, dalle novità del tempo e della storia), non è necessariamente il nemico ( hostis in latino) o peggio, come diceva Sartre, l’inferno o comunque l’oggetto rispetto alla nostra soggettività. Può essere infatti – se lo si vuole – anche l’ospite ( hospes in latino), che si accoglie e da cui si è accolti; può essere il tu che si conosce, si apprezza, si ama e da cui si è conosciuti, apprezzati, amati; il compagno, l’amico, solidale nella comune umanità e voglia di essere persona ed in un mondo personalizzato, con cui ci si incontra, si dialoga, si discute, ci si confronta, ci si “as-socia” per affrontare problemi e perseguire indicazioni di senso umanamente degni “ [3].
Dalla notte dei tempi l’uomo si è sempre interrogato sul senso della propria esistenza, si è chiesto chi è. I presocratici hanno postulato diverse ipotesi sulla nascita del cosmo, del mondo e dell’uomo, trovando negli elementi naturali i principi primi, preesistenti al tutto, che avevano innestato il processo alla base della vita. Cercavano le spiegazioni fuori dal sé, all’esterno, nella natura.
La grande rivoluzione, che interessa la meta educativa oggi, viene compiuta nel V secolo a.C. da Socrate, il quale comincia a rivolgere la propria attenzione all’uomo. Egli esortava la gente del tempo, la gente trovata per le strade di Atene, a guardare dentro di sé, a trovare in sé le risposte agli interrogativi esistenziali, facendo tesoro dell’antico ammonimento delfico di conoscere se stesso:[4].
Anche oggi è facile, afferma la Formenti[5], che perfino l’adulto, pur avendo una storia alle spalle che l’ha costituito come persona con una precisa identità, pur avendo una maturità cognitiva sviluppata per aver affrontato esperienze di vita e intrapreso un percorso di crescita culturale, sia incline alla “dimenticanza di sé”.
Nel campo della terapia, Rogers[6] sintetizza le diverse disposizioni dell’individuo nei riguardi della propria esistenza, collocandole lungo un continuum ai cui estremi pone da una parte il soggetto che non è in grado di vivere l’esperienza con immediatezza, staccato da quanto prova e capace solo di formulazioni stereotipate; all’opposto, l’individuo capace di vivere con immediatezza e per il quale il sentire coincide con il pensare. Fra un estremo e l’altro sono rappresentati gli stadi intermedi in cui l’individuo - allontanandosi progressivamente dalla condizione che lo vede discorrere di quel che prova in un momento preciso come se fosse parte del passato e provare timore di esprimere con immediatezza i sentimenti – via via impara ad accettare il suo sentire. E’ condizione comune dell’uomo trovare difficoltà nell’essere realmente se stesso, nell’esprimere realmente il proprio pensiero personale, interiore, fino ad arrivare a dimenticarlo.
La relazione d’aiuto, innestandosi nel contesto della cultura individualista dell’occidente, si fonda sulla riscoperta del sé, ma – in opposizione a quella stessa cultura – considera rilevante sottolineare che l’uomo, dimenticando il proprio io, rischia di allontanarsi anche dagli altri. Il sé, oggetto di attenzione dell’intero processo educativo, è intrinsecamente caratterizzato dalla disposizione verso l’altro: riflettere in questo modo presuppone essere consapevoli di ciò che caratterizza la razza umana, del fatto che l’uomo è “essere intersoggettivo” e si forma attraverso la relazione. La base dell’educazione non è costituita dalla convinzione di crescere per sé, ma crescere con gli altri, in un processo di scambio. La natura stessa dell’educazione è relazionale: l’incontro è atto fondamentale del processo di crescita di entrambi i soggetti coinvolti, dell’educatore e dell’educando.
L’incontro con l’altro è il presupposto per poter parlare di individuo: il messaggio pedagogico anche nella filosofia di Fichte[7] dimostra proprio che “...sono individuo solo in quanto oppongo a me un altro essere libero fuori di me”. Nella postfazione, Ugazio[8] spiega la posizione fichtiana in questi termini: “l’Io è individuo solo in quanto può comunicare con altri individui” e può dirsi libero quando rispetta anche la libertà degli altri.
Gli aspetti costitutivi dell’uomo sono due e non in contraddizione fra di essi: l’aspetto interiore e l’aspetto esteriore. In virtù del primo egli è proiettato verso l’aldilà, è di un altro mondo, come affermavano i monaci nel Medioevo. Infatti “l’uomo è essenzialmente la propria anima”, proclamava Socrate, sconvolgendo l’Occidente cinque secoli prima dell’avvento del cristianesimo, che oltre a confermarne l’esistenza, ne sanziona l’immortalità. Ma l’uomo è tale in quanto possiede un altro componente costitutivo: il suo corpo, quel corpo che lo costituisce in quanto caduto dall’iperuranio, secondo Platone, quel corpo che S.Agostino e i Padri della chiesa si erano proposti di salvare dalle accuse di essere indegno. Anch’esso, infatti, è stato creato e in quanto atto della creazione è “buono”, fatto per il bene degli uomini. La prima dimensione dell’uomo, quella spirituale, è conoscibile per mezzo di una riflessione interiore, e ad essa si affianca la seconda dimensione, quella di essere vivente nel mondo, di essere fra gli uomini “animale sociale”.
L’educazione in generale insegna la fiducia in se stesso, con l’accortezza irrinunciabile di non vedere in essa la meta e il fine ultimo: la fiducia in se stessi è, in un certo senso, uno “strumento”, per proiettarsi verso la vita sociale, per andare all’altro. Sia l’educatore che l’educando vanno verso l’altro, attuando in questo modo il primo indispensabile passo verso il cambiamento, rendendo concreta la propria disponibilità a essere protagonisti della relazione d’aiuto. L’educazione permette di superare concretamente “la paura del negativo”: è effettivamente un tesoro[9], una grande risorsa che riesce a cancellare il potenziale negativo nascosto nella nostra tradizione dell’io, supera il solipsismo in cui rischia di nascondersi l’individuo, isolandosi e proteggendosi dalla diversità, la quale, invece, rappresenta per l’educazione terreno di arricchimento, di miglioramento, di crescita assieme. Insegna che il bisogno di interiorità, la cui scoperta è stata tanto importante e rivoluzionaria nel passato e il cui messaggio è conditio sine qua non nell’oggi, non esclude la socialità dell’uomo. La relazione educativa dimostra il significato profondo dell’ineliminabile ed eterno bisogno di conoscersi e lavorare su di sé, ma, allo stesso tempo, dimostra che è altrettanto necessaria e arricchente la conoscenza dell’altro. L’Io non deve trovare ragion d’essere esclusivamente in se stesso, ma aprirsi all’incontro-confronto. Immaginiamo un percorso che ogni “io” deve intraprendere per arrivare ad una meta, ma di cui egli stesso non è pienamente cosciente e non ne rileva nell’immediato i vantaggi. Questa è la condizione nella quale si trova ogni singolo uomo, che è invitato a lasciare il terreno sicuro, tranquillo, costituito dall’essere “solo”, per andare all’altro. Ad ogni singolo l’educazione rivolge una domanda relativa alla sua disponibilità a rischiare di mettersi in gioco nel confronto.
Il passaggio dal sé all’altro è rappresentato in modo emblematico da Hegel nella “Fenomenologia dello Spirito”, romanzo di formazione filosofica in cui i protagonisti sono l’Assoluto e la coscienza individuale. La coscienza individuale deve intraprendere un difficile cammino, rispetto al quale non si ammettono scorciatoie, che la porta a superare l’opposizione soggetto-oggetto, fino ad ammettere, a conclusione del percorso, che l’oggetto è il sé della coscienza: è autocoscienza. Una delle dimensioni costitutive dello Spirito, che per Hegel è il vero e il reale, è proprio la dimensione intersoggettiva. Raggiungere il superamento dell’opposizione comporta “la fatica del concetto”: è difficile andare all’altro, e questa disposizione non ci esula da rinunce e fatiche.
Anche nella corrente del personalismo il ruolo dell’Altro emerge con significativa rilevanza strutturante per l’io e come necessità nella sua esistenza. L’idea centrale del personalismo è quella di persona, nella sua inoggettivabilità, inviolabilità, libertà, creatività, responsabilità, incarnata in un corpo, situata nella storia e costitutivamente comunitaria. Nella filosofia di Mounier[10], teorico della rivoluzione personalistica e comunitaria, persona è centro cui tutto si riporta, ma invisibile, inafferrabile: non è “la coscienza che io ho di essa (persona)” , né si identifica con i personaggi che si è stati, né con la parte più profonda di sé, vale a dire i propri desideri, volontà, speranze. Si manifesta esteriormente attraverso alcuni gesti o segni, ma non può essere colta nella sua totalità, è più vasta delle visioni che ne abbiamo e più intima delle ricostruzioni che di essa si tenta di dare. In ogni uomo è coglibile attraverso la tensione fra le sue tre dimensioni spirituali: “quella che sale dal basso e l’incarna in un corpo; quella che è diretta verso l’alto e la solleva a un universale; quella che è diretta verso il largo e la porta verso una comunione”[11]. La prima dimensione è quella che caratterizza l’uomo in quanto “situato” in un tempo e uno spazio concreti. Grazie a essa l’uomo è spronato a non “evadere dalla vita sensibile e particolare, che si svolge tra le cose”. Dall’altra parte, però, grazie alla seconda dimensione, sviluppa anche la capacità di riferire la propria missione, oltre al contesto specifico e personale nel quale egli si trova, anche al soprasensibile e alla vita sociale. In virtù della terza dimensione, infine, siamo votati a svolgere un altro nostro compito, che è quello di non isolarci: “darsi ad una comunità superiore che chiama e integra le singole persone”.
Il superamento di una crisi che Mounier vede sfociata nel XX secolo ed è presente già a partire dai secoli XVIII e XIX è possibile solo a patto di dimenticare l’individualismo, responsabile di condurre l’uomo verso l’isolamento e la difesa di sé. L’io deve fare dono di sé agli altri, coesistendo con loro, “comprenderli comprendendosi, comprendersi comprendendoli”. Per sua natura la persona è comunitaria. Non è accettabile un atteggiamento di diffidenza verso gli altri, un rapporto che si basi sul calcolo, rivendicazione, egoismo per ottenere un profitto: sarebbe contro natura. La persona è una presenza volta al mondo e alle altre persone, che “non la limitano, ma anzi le permettono di essere e di svilupparsi; essa non esiste se non in quanto diretta verso gli altri, non si conosce se non attraverso gli altri, si trova soltanto negli altri”. La base dell’essere è relazionarsi attraverso un dialogo costante e produttivo, che è condizione per fare in modo che l’io non perda né se stesso, né il rapporto con l’altro da sé: “follia è uno scacco del rapporto con gli altri: l’alter diventa alienus, e io a mia volta divento estraneo a me stesso alienato”. Mounier giunge ad affermare che “essere significa amare” fino a prendere su di sé il “desino, la sofferenza, la gioia, il dolore degli altri”. Egli è consapevole delle difficoltà oggettive, ostacolo per la realizzazione di questo progetto che, infatti, non propone come meta concreta, ma come modello ideale cui tendere.
Parallelamente nella relazione d’aiuto, entrambi gli individui implicati, per intraprendere il percorso che li porterà all’altro, si volgono proprio a un modello ideale cui tendere, ma sono anche chiamati ad attuarlo concretamente nella loro storia: devono essere pronti a rivoluzionare la propria esistenza e lanciare un ponte verso una nuova struttura concettuale, un nuovo modo di pensare che li modificherà e li migliorerà: nel momento in cui l’io è invitato a riconoscere l’altro non perde una parte di se stesso, ma, al contrario, si arricchisce infinitamente.
Il problema è costituito dal trovare un terreno d’incontro per due individualità affinché si avvicinino, si possano riconoscere, scoprire, comprendere. Fino al momento in cui esse vivono distinte sono chiuse al rinnovamento, al confronto.
Andare all’altro non è un obbligo per l’individuo, che è libero nell’esistenza e che proprio in un contesto di estrema libertà è chiamato a effettuare le proprie decisioni dal momento in cui sarà in grado di farlo più o meno coscientemente, fino alla morte. Andare verso gli altri è anche scegliere.
Afferma Bauman che l’esistenza è costellata da bivi e ogni volta che ci imbattiamo in essi siamo continuamente chiamati a esprimere una decisione relativa alla strada che preferiamo. Possiamo astenerci: anche questa è una scelta, che come le altre sarà carica di conseguenze. Nel nostro cammino, nessuno potrà esimerci dalla responsabilità del dover scegliere e, nello stesso tempo, non potrà esimerci dal dover rischiare[12], in un gioco continuo contro (-con) la Vita.
Se l’individuo non è obbligato ad essere “animale sociale” come scelta personale, lo è, invece, dal punto di vista etico: la relazione con l’altro è, infatti, una relazione etica. Se l’individuo vuol essere “etico”, non si troverà di fronte ad un aut aut, ma l’unica strada da percorrere sarà quella di relazionarsi. La solitudine, l’emarginazione, l’incomprensione, l’assenza di solidarietà, la comunicazione egocentrica, l’indifferenza, la prevaricazione[13] non sono valori morali, ma oltre a questo -ciò che è peggio- riducono la dignità e la tipicità dell’essere umano. Il contatto con l’altro mette in questione l’egoismo.
Non solo ha diritto di essere rispettato come essere umano l’uomo che ha bisogno di aiuto, e ha diritto di essere aiutato nell’emergenza, nell’assistenza, così come nel sostegno psicologico, ma ha il dovere di essere degno dell’appellativo di uomo anche la persona che si può trovare nella condizione di rispondere alla richiesta di aiuto e che, rispondendo, dà senso al proprio essere ed esprime il proprio “essere etico“.
L’individuo solitario, che cerca di difendersi dall’altro ignorandolo, dimenticandolo, escludendolo dalla propria considerazione e, facendo questo, lo dimentica come uomo suo simile, è anch’egli investito da un imperativo categorico, universale, necessario che riguarda l’appello dell’altro: qualunque uomo, in quanto tale, non può sfuggire alla relazione intersoggettiva. Per l’educazione non è una legge naturale che può non attuarsi, ma una legge pratica, morale: il “devi perché devi”[14].
Nella relazione fra due persone, l’Altro di fronte a me mi rivolge l’appello di essere ascoltato, di essere, assieme.
1.1.1 Lévinas, il primato dell’etica
Il contributo di questo filosofo, rappresentante del pensiero fenomenologico, offre un importante spunto di riflessione per considerare in che senso si possa e si debba instaurare una relazione, un incontro “in profondità”.Il concetto di appello, dono, volto sono fondanti nella filosofia di Lévinas[15]. Egli non considera che per incontrare l’altro dobbiamo percorrere una strada che parte dalla nostra soggettività, ma, al contrario, la soggettività rappresenta il punto di arrivo, perché si costituisce a partire dall’alterità. Quest’affermazione spiega la rilevanza del dialogo e dell’incontro fra i singoli, ma, nello stesso tempo, sottolinea che non è l’opportunismo a rappresentare la motivazione del “darsi all’altro”: il soggetto non si spinge verso l’altro per “costruire” il proprio io, non accade che ci si serva dell’altro, piegandolo ai propri fini, soggiogandolo psicologicamente, riducendolo a strumento in direzione dell’affermazione personale. Lévinas, con il proprio pensiero ricco di umanità, non vuole usare l’altro per scopi che non travalicano l’io e che si soffermino esclusivamente al sé. Considera l’essere come qualcosa di secondario: per prima cosa viene l’etica, prima si viene interpellati dall’altro.
“ Noi chiamiamo volto il modo in cui si presenta l’Altro, che supera l’idea di Altro in me. Questo modo non consiste nell’assumere, di fronte al mio sguardo, la figura di un tema, nel mostrarsi come un insieme di qualità che formano un’immagine. Il volto d’Altri distrugge ad ogni istante e oltrepassa l’immagine plastica che mi lascia ” [16].
L’inizio del pensiero coincide con la possibilità di pensare l’alterità che si manifesta come un volto: il volto non è oggetto del pensiero, col rischio che diventi un “dato” da “afferrare”, ma al contrario mi guarda e mi riguarda, si pone e si impone di fronte a me, esce dall’anonimato e fa uscire da tale anonimato, tanto da rivoluzionare la relazione che si instaura fra due esseri trasformando il semplice incontro (o addirittura scontro) in un momento coinvolgente. Il volto dell’Altro mi coinvolge, mi pone in questione con la sua presenza. Riconoscere l’Altro vuol dire farsi interpellare da lui, dunque divenire responsabile nei suoi confronti.
Sottraendosi al “possesso”, l’Altro aiuta il soggetto a costruire la sua struttura originaria e fondante: la responsabilità[17]. Il pensiero di Lévinas può tradursi in termini empiricamente osservabili e attuabili nel concreto dell’agire educativo: nel pensiero pedagogico essere responsabile nei confronti dell’altro costituisce uno dei presupposti sulla base dei quali fondare una relazione d’aiuto. Parliamo di relazione d’aiuto, infatti, nel momento in cui l’altro si affida a chi lo può aiutare e questi risponde con responsabilità, con la presa in carico. Non vuol dire che tutto dipende dall’educatore, ma da lui dipende coinvolgere l’educando, instradarlo, spronandolo, facendogli superare, col supporto dell’aiuto, gli ostacoli che autonomamente non sarebbe in grado di superare. Anche per Santerini la professionalità si costituisce nella responsabilità.
Come diciamo che la presenza dell’Altro è essenziale per la soggettività, perché le permette di uscire dal solipsismo e dall’indifferenza e la costituisce come “essere etico” , così l’immagine di educatore che ne deriva è di soggetto interpellato, coinvolto in una relazione etica fondante anche per la propria esistenza. L’educatore nell’educando vede realizzata la possibilità di ampliare la propria visuale individuale, soggettiva, grazie all’incontro
1.1.2 Singer, un’etica “universale”
Il discorso relativo alla diversità, all’interno della filosofia, viene affrontato da più versanti. Fra questi può offrire uno spunto di riflessione particolare uno specifico settore dell’etica pratica: l’utilitarismo. Di questa corrente ho scelto come esponente Singer[18], che affronta in modo esplicito il tema della necessità di superare la diversità, ma con un accento che va oltre quello trattato fino ad ora, perché paragona addirittura l’uomo all’animale, dimostrando, in base al principio dell’eguale considerazione degli interessi[19], che entrambi possono vantare il medesimo diritto a non soffrire e a vivere.
L’autore si chiede, innanzi tutto, quale sia la base di pensiero su cui si fonda l’eguaglianza. Rawls ipotizza che, pur essendo tutti diversi, siamo comunque accomunati da una personalità morale che ha il senso della giustizia. Singer si ribella di fronte a questa affermazione, dimostrandone l’inconsistenza: sarebbero esclusi dalla razza umana e dai diritti cui quest’appartenenza conduce i neonati, gli handicappati, i bambini, oltre che gli animali; afferma, invece, che “l’eguaglianza è un principio morale di base”, indipendente dalla personalità morale, dall’intelligenza, dalla razionalità, dalla razza, dal sesso.
Singer, però, si spinge oltre: il principio dell’eguaglianza rappresenta una base morale valida anche al di fuori della nostra specie: gli interessi devono essere indipendenti dalla razza, dalle capacità, ma anche dalla specie. Per Bentham, auctor[20] dell’utilitarismo, il problema cruciale è costituito dal porsi la domanda: “Possono soffrire?”. Dal momento in cui sappiamo che anche gli animali, come noi uomini, possono soffrire, saremmo specisti se non li ritenessimo egualmente degni di partecipare alla vita. La caratteristica vitale che garantisce eguale considerazione è proprio la capacità e possibilità di soffrire: essendo il dolore un male, dovremo adoperarci in modo tale che nessuno ne sia vittima.
L’etica cui ci conduce Singer è davvero universale, perché varca i confini dell’umano e si amplia ad un orizzonte che generalmente non appartiene al pensabile e al pensato. Il messaggio di Singer ha infatti dovuto fare i conti con confutazioni, con opposizioni, indipendentemente dalle quali, però, mantiene la sua forza e la sua provocazione: permette ad ogni uomo, al di là del fatto che si condivida o meno il suo pensiero, di riflettere sul tema dell’eguaglianza, in modo approfondito. Di fronte alle sue affermazioni non è escluso ci si possa disporre con curiosità, senza necessariamente giungere ad una totale condivisione; solo leggendole, il lettore ne sarà coinvolto, perché queste questioni lo riguardano, in prima persona, per il fatto di vivere quotidianamente a contatto con l’altro, che si presenta a noi sotto diverse “forme”, sia bianco o nero, uomo o animale, donna o uomo. Singer, forse non volutamente, invita a riflettere sull’innegabilità del legame fra noi uomini, che, in quanto esseri viventi su una stessa Terra, indipendentemente dalle diversità, siamo esseri “etici”: è un’etica “universale” ad accomunarci, non un’etica “nazionale”. Dal momento in cui ci sono viventi, come gli animali, e umani, come i bambini, che non possono comprendere il significato dell’etica né la possono applicare, l’uomo “etico” è responsabile anche per loro. Egli ha il dovere di fare anche i loro interessi, non ha il diritto di approfittare di loro perché non possono difendersi. L’uomo è richiamato a rispondere alla propria coscienza oltre che ai propri doveri.
Non volutamente il ragionamento di Singer si accosta al messaggio evangelico, il quale con parole diverse, responsabilizza l’uomo di fronte al proprio simile: “Non fare all’altro quello che non vorresti essere fatto a te”.
Anche nella relazione educativa l’educatore deve disporsi ad avvicinarsi ad una persona, a un suo simile che richiede aiuto o addirittura a volte non lo chiede, ma ne ha estremo bisogno. E’ ancora l’etica, come per Lèvinas, la chiave che rende necessario intraprendere il percorso, articolato, difficoltoso, ma presupposto per essere “uomo”, che ci porta all’altro.
Ammettendo una possibilità di uguaglianza vastissima, tanto da inglobare uomini ad animali - dai quali fin dai tempi di Aristotele abbiamo preso le distanze -, Singer ha ridotto il discorso relativo all’eguaglianza uomo-fra-gli-uomini ad essere scontato, addirittura ovvio.
Ampliando ancora la veduta dall’oggi al futuro, Savignano[21], ritiene fondante per l’esistenza della razza umana pensare anche al bene dei nostri discendenti, facendo anche i loro interessi e tutelandone la possibilità di vivere nel benessere anche quando noi non ci saremo e avremo esaurito il nostro compito sulla Terra, che diventerà loro.
1.1.3 Taylor e il disagio della modernità
Nel contesto filosofico attuale, Taylor[22] offre alla nostra riflessione due ordini di spunti che arricchiscono la questione sull’individualismo: ne valuta il lato positivo, intendendolo come ritorno a sé, occasione per trovare in sé il proprio modo di vivere, e, nel contempo, lo indica come “disagio”, sottolineandone il lato negativo. Nella sua riflessione distingue tre “disagi” della modernità: l’individualismo, il primato della ragione strumentale e le conseguenze cui i due precedenti conducono.
Il primo disagio, l’individualismo, viene valutato sia come conquista che come perdita: conquista del diritto di scegliere, ma, conseguentemente a ciò, perdita dei vecchi orizzonti morali. Mentre nel passato ci si considerava parte di un orizzonte più ampio, si viveva stabilmente in un luogo, con un ruolo preciso, nella modernità gli uomini hanno perso la percezione della loro collocazione sociale e tendono a concentrarsi sulle proprie vite individuali.
“ (...) il lato oscuro dell’individualismo è il suo incentrarsi sull’io, che a un tempo appiattisce e restringe le nostre vite, ne impoverisce il significato, e le allontana dell’interesse per gli altri e la società ” [23]:
questa perdita è chiamata da Kierkegaard “mancanza di passione”, da altri mancanza della “dimensione eroica”. E’ una perdita di senso cui ne consegue un appiattimento delle nostre vite, a causa dell’allontanamento-disinteresse nei confronti degli altri e della società. Non di poco conto, nel contesto educativo, è anche il secondo dei disagi indicati da Taylor, il primato della ragione strumentale, in virtù della quale non si riconosce più un posto nella catena dell’essere a cose e persone, che rischiano di essere trattati come strumenti: si decide in termini di efficienza e si guarda solo l’obiettivo consistente nel massimizzare la produzione. Questa logica è responsabile della diseguale distribuzione delle ricchezze nel mondo e della perdita di umanità. Weber ha paragonato la condizione nella quale si trova l’uomo alla vita in una “gabbia di ferro”, della quale egli si può liberare solamente smantellando Stato e mercato, condizioni oggi ormai impossibili. Impossibile ormai tornare indietro.
La conseguenza di questa vita che l’uomo stesso si è forgiato è la perdita della libertà: le strutture sociali-industriali-tecnologiche e le istituzioni limitano le nostre scelte. Ne deriva una conseguente perdita di interesse per la politica e la partecipazione attiva, fino alla nascita del “dispotismo morbido”: non solo a livello microdimensionale, ma, ampliata alla massima potenza, a livello della società si verifica una perdita della capacità sociale e partecipativa. Con un’immagine significativa e chiarificatrice della condizione umana, si afferma che nella nostra società gli individui sono “rinchiusi nei loro cuori”. Gli uomini custodiscono i loro valori, le loro personali convinzioni, ma non sanno discutere, optano per il “relativismo” che trova parte del suo fondamento nell’individualismo dell’autorealizzazione, consistente nel porre al centro dell’interesse l’io, escludendo tutto ciò che lo trascende. Questo ragionamento da una parte comporta la paura che l’individuo dimentichi la socialità, dall’altra la valorizzazione dell’ideale su cui si fonda l’autorealizzazione: l’autenticità. L’autenticità non è spiegata in termini di “egoismo”, ma come un valore, che consiste nella fedeltà a se stessi; all’opposto egoismo è “forma degradata e deviante di questo ideale”:
“ C’è un certo modo di essere uomo ch’è il mio modo. Io sono chiamato a vivere la mia vita in questo modo, e non ad imitazione di qualsivoglia modo altrui. Ma ciò conferisce importanza nuova all’idea di fedeltà a se medesimi. Se non sono fedele a me stesso perdo la sostanza della mia vita, perdo ciò che l’esser uomo è per me.
E’ questo il potente ideale morale ch’è giunto fino a noi. Esso assegna una cruciale importanza morale a uno speciale contatto con noi stessi, con la propria natura interna (...). Esso asserisce quindi grandemente l’importanza di questo auto-contatto introducendo il principio dell’originalità: ciascuna della nostre voci ha qualcosa di suo proprio da dire. Non solo io non devo adattare la mia vita alle richieste della conformità esteriore, ma neppure posso trovare il modello su cui regolare la mia vita fuori di me. Posso trovarlo soltanto dentro di me.
Essere fedele a me stesso significa essere fedele alla mia propria originalità... Nell’articolarla, io definisco altresì me stesso... E’ questa l’idea che fa da sfondo al moderno ideale dell’autenticità... che conferisce forza morale alla cultura dell’autenticità... E’ questo che dà senso del “fare ciò che ci appartiene”, o “del trovare la nostra propria realizzazione ” [24].
Le condizione per fare in modo di superare il disagio della modernità non è rappresentata dalla necessità di schierarsi da parte dei lodatori o detrattori della modernità stessa, dandone un giudizio definitivo, ma dalla valorizzazione delle sue potenzialità e dall’impegno di non scivolare nelle sue forme degradate.
Tayolr, nel corso del suo testo “Il disagio della modernità”, offre degli spunti arricchenti per l’educazione:1) L’autenticità, o fedeltà a se stessi, è un ideale che fa riflettere l’uomo sulla propria interiorità. Già nel Settecento, si era consapevoli del fatto che gli uomini fossero dotati di senso morale e avessero un sentimento intuitivo del giusto, lasciandosi guidare ad una sorta di “voce interna”. La fonte di riferimento dei pensieri e delle azioni non sarebbe Dio o l’idea del Bene, ma noi stessi. E’ la svolta soggettivistica:
- noi stessi siamo dotati di profondità interne ( e ciò non esclude il collegamento a Dio, come nel caso di S.Agostino);
- la morale è “voce della natura che parla dentro di noi”, non udibile quando è sommersa dall’orgoglio. La salvezza è costituita dal recupero dell’ascolto, di un contatto morale con noi stessi: questo è il “sentiment de l’existence” di Rousseau. L’ideale dell’autenticità va di pari passo con la libertà, capacità di decidere da sé, senza condizionamenti;
- Taylor riporta il pensiero di Herder, secondo il quale ciascuno ha una sua “misura” nell’essere uomo. E’ un’implicazione del concetto di “fedeltà a se medesimi”, chiamato “principio di originalità”: ciascuna delle voci di ogni uomo ha qualcosa di suo proprio, di originale da dire. Dentro se stessi è possibile trovare il modello sulla base del quale regolare la propria vita e trovare la nostra realizzazione.
2) La caratterizzazione della vita umana in senso dialogico. A conferma di tale considerazione Taylor afferma[25]:
- definiamo ed esprimiamo la nostra identità attraverso i linguaggi (oltre a quello verbale anche quello della gestualità, dell’arte, dell’amore);
- siamo iniziati ai linguaggi attraverso lo scambio con gli “altri significativi” (Mead);
- non abbiamo una mente “monologica”, non possiamo chiuderci esclusivamente nella riflessione solitaria, ma per realizzarci, per definirci abbiamo bisogno di relazioni. Tayolr arriva addirittura ad affermare che “la nostra identità è formata dalle persone che amiamo”. Lungo tutto il corso della nostra vita la formazione e il mantenimento della nostra identità restano dialogici.
3) Non tener conto degli altri e delle loro esigenze non consente la realizzazione della nostra “autenticità”[26]:
- l’Io e l’Altro sono in continuo contatto e l’attenzione all’uno non esclude, anzi implica, l’attenzione all’altro. L’io ha continuo bisogno del riconoscimento degli altri;
- non è concepibile mettere al centro l’io, perché nel sociale è necessario dialogare e confrontarsi per mettersi d’accordo sui valori, sull’orizzonte di significati condiviso. Nel rapporto personale non si può ingannare l’altro fingendo un rapporto di reciprocità per strumentalizzarlo;
- non tutte le forme di autenticità per Tayolr sono legittime, solamente quella che “esige apertura a orizzonti di significato e autodefinizione nel dialogo”.
4) L’uomo è chiamato a essere responsabile[27]: può scegliere due strade opposte, quella dell’ “atomismo sociale”, dell’ “antropocentrismo”, oppure quella del miglioramento. Per percorrere quest’ultima strada ha importanza vitale il recupero dell’autenticità come ideale morale. Non ci stiamo dirigendo verso un destino ineluttabile: c’è timore, ma ancora possibilità di esercitare la libertà nella scelta di un destino migliore.
1.2 L’ALTRO AL DI LÀ DELL’ASSISTENZIALISMO
Anderson considera che se un essere umano è disposto a lavorare con un altro, anche quest’ultimo si dimostrerà incline alla collaborazione. Lo stesso vale per l’aiuto, essenza della crescita nell’interazione umana e attraverso di essa, e per il dono, il quale rappresenta il senso profondo che giustifica l’essere-con-gli-altri e per-gli-altri e fonda la relazione d’aiuto.
Parlare di aiuto e di dono dell’educatore nei confronti dell’educando non vuol dire intendere l’educazione in senso assistenziale.
Da un’educazione intesa come “controllo”, che ha condotto le persone devianti ad essere rinchiuse nelle istituzioni totali per allontanarle dalla vita normale, l’intervento di tipo riabilitativo, assistenziale, fondato sul un modello medico che vede l’utente come paziente da curare, rappresentava, nel passato, effettivamente un passo significativo in avanti verso l’umanizzazione. Eppure l’obiettivo normalizzante che ci si proponeva non rispettava ancora l’individuo nella sua singolarità, come portatore di diritti umani.
Solo negli anni ’60/’70 l’educazione supera questa limitazione e diventa “recupero delle potenzialità e delle capacità intrinseche”. Due sono i passaggi che rendono possibile la rivoluzione del modo di vedere l’utente e del modo di intervenire nei suoi confronti: il superamento del modello biologico medico e la nuova definizione di salute.
Con il modello cognitivo-comportamentale, per il quale è fondamentale la relazione uomo-ambiente, si supera la concezione biologistica derivata dalla medicina, secondo la quale l’uomo è essenzialmente il proprio corpo. Il rischio rappresentato da quest’ultima posizione consisteva nel vedere l’uomo solo come la parte malata, da curare, dimenticando la dimensione umana della cura stessa.
Il secondo passaggio rivoluzionario è rappresentato dall’intervento da parte dell’OMS[28], la quale cambia il modo di intendere il concetto di salute, non più legato esclusivamente alla malattia fisica, ma definito più genericamente come “assenza di benessere psichico, fisico e sociale”. Con l’articolo 32 della Costituzione italiana si sancisce che “la Repubblica tutela la salute e lo Stato si incarica di realizzare servizi”. Per tutelare la salute dei cittadini ci si rende conto che non è sufficiente il sistema sanitario, ma a questo servizio si deve affiancare l’assistenza psico-sociale.
Grazie a questi contributi, nasce la figura dell’educatore il cui intento non è punitivo o contenitivo, ma permette il recupero delle potenzialità residue del soggetto in difficoltà: non lo spinge a diventare quello che non è e che non può diventare, ma gli permette di essere ciò che è, nel rispetto dei sui limiti e nell’intento di guardare, più che ai suoi limiti, ai suoi requisiti. L’uomo viene valorizzato in tutte le componenti: non è soltanto la sua “parte malata”, il suo “ritardo”, la sua “insicurezza”, la sua “psiche disordinata, destrutturata”, ma è persona in grado di migliorare e di essere partecipe della relazione di aiuto, la quale si attua nelle svariate occasioni, anche della vita quotidiana, ogni qual volta ci sia un incontro che dà spazio alla realizzazione e all’espressione dei soggetti. Attraverso strumenti diversi, primo fra tutti la comunicazione, chi riveste il ruolo di educatore si propone all’educando come sostegno.
La relazione - chiamata educativa nella misura in cui si realizzano queste condizioni – garantisce un aiuto in senso globale alla persona, che sia soggetto handicappato e abbisogni di un educatore esperto del recupero; che sia giovane deviante e abbisogni di accoglienza in un Centro in cui trovare appoggio; che sia, in generale, l’uomo che cerca un consiglio, un’occasione di riflessione per riprendere con maggior forza e consapevolezza le redini della propria vita.
De Leo[29] considera che ogni periodo storico costruisce una propria concezione di intervento e che quelle di punizione, assistenza, trattamento - eredità dell’idea positivistica di correzione - hanno fallito il loro obiettivo dal momento in cui hanno favorito generalizzazioni e non hanno permesso un confronto con i problemi sociali realmente esistenti. Hanno prodotto, a livello del sistema giudiziario, un aumento dei procedimenti nei confronti dei minori, forme di istituzionalizzazione, una logica del controllo più che del bisogno, rischi presenti tutt’oggi.
L’educazione, oggi, non si propone solo come “cura”, ma relazione in profondità con l’utente, stimolo esistenziale, intervento “etico” per l’altro. A testimonianza di cosa si intenda, Chieregatti[30] riporta come esempio di una delle tante relazioni d’aiuto, che scandiscono la vita dell’individuo, il rapporto insegnante-allievo:
“ Quella che si instaura tra l’insegnante e l’allievo può essere definita una relazione d’aiuto, in quanto ci troviamo di fronte a uno che offre e a un altro che accetta.
(…) Della propria esperienza scolastica, in genere ciascuno ricorda non tanto il “sapere” che gli è stato trasmesso, quanto la relazione che si era instaurata con alcuni insegnanti che avevano saputo costruire un rapporto significativo, aprendo gli orizzonti di un modo nuovo di confrontarsi. Attraverso quella relazione , è rimasto anche il “sapere” che l’insegnante aveva trasmesso. Se non c’è una relazione significativa, è difficile che il “sapere” trasmesso dall’insegnante rimanga a lungo nell’allievo” [31].
I risultati della riflessione sulle teorie, gli strumenti e gli interventi concreti che De Leo ricava dalla sua esperienza nel campo della devianza minorile - una delle dimensioni delle problematiche educative - possono essere ampliati all’intero campo della relazione d’aiuto:
Una volta che il soggetto si trova dentro il sistema penale, l’obiettivo è quello di ridurre la sua permanenza e soprattutto di fare in modo che questa permanenza sia sempre accompagnata dalle più chiare garanzie e da interventi che…siano anche caratterizzati dall’attenzione alla personalità del minore e dal criterio dell’ ”utilità” per il minore. (…) La punizione deve consentire un chiaro, non violento, non distruttivo e non manipolante confronto fra l’individuo e la propria azione deviante (…) La dimensione più rilevante, più frequente nel concetto di trattamento è quella delle attività (di studio, di lavoro, attività di sostegno, di controllo, di osservazione, di attività terapeutiche individuali o familiari ecc.)…L’obiettivo non è quello di correggere il soggetto, di cambiare la sua personalità, ma di fare in modo che egli possa partecipare, elaborare, utilizzare risorse nella prospettiva di attivare qualche cambiamento nell’interazione con i servizi, le istituzioni e quindi, in un secondo momento, forse anche della sua personalità. Si tratta evidentemente di un obiettivo che risponde a una concezione molto più complessa e articolata del comportamento deviante, non più inteso come semplice espressione della personalità o della negatività dell’ambiente…andare oltre la storica necessità dell’istituzionalizzazione per ricercare modi alternativi e sostitutivi di intervento negli stessi luoghi e contesti di appartenenza del minore…Non si tratta di una delega di responsabilità, ma un tentativo di riattivare quel contesto spesso irrigidito, di sollecitare e stimolare quelle risorse e quegli spazi in modo da individuare nella famiglia, nella scuola, nel quartiere nuove strategie di contatto significativo con il minore [32].
Queste considerazioni sono importanti in merito ad alcuni punti fondamentali che caratterizzano l’aiuto, perché permettono di ricavare alcuni spunti di riflessione:
- L’immagine che rappresenta nel modo migliore il rapporto educatore ed educando è il camminare assieme. Qualche volta l’educatore precede l’educando per spianargli il terreno, per proteggerlo dalle sue paure, ma la maggior parte del rapporto si fonda sul camminare l’uno a fianco dell’altro, condividendo, costruendo certezze che insegneranno, poi all’educando, nel futuro, a slegarsi dall’intervento educativo e a camminare da solo;
- L’intervento nei confronti dell’utente deve essere realizzato nel rispetto dei suoi diritti, primo fra tutti quello di essere soggetto che si dispone a imparare, portatore di una particolare storia e visione del mondo che lo caratterizzano;
- Dev’essere aiutato a costruire un orizzonte di senso che gli consenta di superare il contesto di disagio nel quale si trova inserito. Per mirare a questo è opportuno offrirgli degli spunti, delle stimolazioni calate nello specifico della situazione e funzionali al raggiungimento degli obiettivi idonei a lui;
- Rispettare la personalità dell’utente orientandolo al cambiamento è tipico di ogni intervento valutativo, non mirato allo stravolgimento della sua personalità, ma alla valorizzazione delle sue qualità;
- Valorizzare la responsabilità e la partecipazione dell’utente è passo essenziale per non intendere più l’educazione come “servizio” che dall’educatore muove verso l’educando, ma come “responsabilità condivisa”, “lavoro assieme”, collaborazione di entrambi per migliorare;
- L’educatore non deve aver paura di mostrare all’educando l’errore. C’è occasione di migliorare superando gli errori e non vergognandosi di essi;
- La relazione d’aiuto non è solo dialogo, ma anche attività. Attraverso il fare l’educando sperimenta e scopre le proprie abilità, nella consapevolezza delle quali può muoversi con sicurezza, sapendo scegliere al meglio fra le possibilità che la vita gli propone;
- L’intervento educativo è volto a fare in modo che il soggetto impari ad aprire la sua vita agli altri: egli è sempre inserito in un preciso contesto di cui deve imparare ad apprezzare le occasioni e ad approfittarne;
- La situazione disagiata da cui l’utente può provenire non è “causa” a tutti gli effetti delle difficoltà manifestate dall’educando, ma è determinante il modo con cui egli l’ha elaborata ed interpretata.
Quest’ultima dimensione è stata valorizzata, accanto allo stesso De Leo, da Bertolini. Entrambi considerano necessario il superamento dell’ottica eziologia-deterministica del modo di intendere il disagio e, in particolar modo, la devianza dei “ragazzi difficili”[33].
L’educazione non è più considerata come lavoro nei confronti di un utente passivo, bisognoso di assistenza che solo riceve e che può solo ricevere. L’educazione rivendica invece un suo lato per lungo tempo nascosto, ma essenziale per ridare piena dignità all’utente: è luogo di incontro, dialogo, crescita, arricchimento per entrambi i soggetti coinvolti e va oltre le necessità del momento. L’educatore e l’utente sono l’uno complice dell’altro nel lavoro su di sé e sull’altro da sé e i presupposti per poter parlare di un tale rapporto, come già sottolineato anche dagli autori precedentemente citati, sono etici.
E’ necessario sottolineare che la questione relativa all’etica non è solo teorica, ma il suo campo di attuazione è la pratica. Proprio nella quotidianità della frequenza, nella relazione impostata secondo i criteri rispettosi della dignità umana, possiamo impegnarci a superare, concretamente e non solo a parole, gli ostacoli nel difficile percorso che dall’Io ci porta verso l’Altro.
Alla luce del contributo di Levinas, Singer e Taylor e del nuovo modo di vedere l’altro come persona con bisogni che vanno oltre l’assistenzialismo, ci disponiamo a riflettere sull’incontro così come si compie nella relazione d’aiuto.
1.3 IL CONCETTO DI RELAZIONE
1.3.1 L’Io – tu di Buber
Colui che ha spiegato in modo esemplare, anche per la pedagogia oggi, che cosa sia e in che cosa consista la relazione è stato Buber. Filosofo del dialogo, maestro dell’incontro, egli ha ritenuto che nell’affrontare e definire questa questione fosse seriamente in gioco l’essere dell’uomo, la sua dignità, “l’esistenza autentica”. Giuseppe Milan[34] ha letto la filosofia di Buber secondo un’ottica pedagogica, rendendo evidenti le implicazioni educative del suo pensiero, ma anche chiarendo come per Buber stesso la realtà dell’ “esistenza autentica” si costruisca attraverso un itinerario fondato sulla relazione educativa.
L’incontro è garante dell’umanizzazione dell’uomo, il quale, paradossalmente, è tale in virtù della presenza di un altro uomo. L’io esiste e ha senso di esistere, se si volge al tu, in caso contrario rischia di perdere il significato valoriale dell’esistenza. Nell’essere con l’Altro si esprime la dignità stessa dell’uomo.
Nel concetto di relazione sono compresi i legami fra questi altri concetti: tu, incontro, valore, dignità umana. C’è però una condizione prima fra tutte perché si possa parlare di relazione: il dialogo.
Il dialogo è, per Buber, argomento cardine su cui si fonda l’incontro, e, in pedagogia, è la base di tutte le dinamiche della relazione d’aiuto. Non è conditio sine qua non per l’uomo in generale, perché questi può scegliere l’isolamento, però è condizione perché si possa esprimere la dignità dell’uomo: colui che è lasciato solo a se stesso non sa né può valorizzarsi, perché nessuno gli insegna le qualità per cui vale la pena vivere e la possibilità grande, che gli è data, di metterle a frutto. Tutto ciò si valorizza nell’insegnamento, nell’accostamento di una persona ad un’altra, nel fidarsi reciproco, nell’incontro, nel dialogo, occasione di unione fra gli uomini e pieno riconoscimento dell’alterità.
Buber opera una distinzione decisiva, affermando che due possono esistere tipi di relazione a seconda noi consideriamo l’interlocutore “Tu” o “Esso”: “Il mondo ha due volti per l’uomo, in conformità del suo semplice modo di essere”[35]. Ciò che intende dire è che la distinzione non dipende dalla diversità della realtà, ma dall’atteggiamento del soggetto nei confronti dell’altro. L’Io-Tu è la relazione autentica, in cui l’Io si costituisce come “esistenza autentica”, prende coscienza di sé, si “educa” e costruisce il proprio dialogo con l’Altro nella reciprocità. Nella relazione Io-Esso, invece, l’Io agisce per proprio tornaconto, ha un atteggiamento oggettivante, utilizza, manovra gli esseri umani dei quali non coglie l’essenza, ma la loro rappresentazione; non vede nell’Altro una persona uguale a sé, perché il proprio sé viene prima di tutto e di tutti. Sta all’uomo la scelta fra le due possibilità. Se è vero che nella vita è auspicabile vivere l’incontro in modo autentico, e quindi consono alla realizzazione della pienezza umana – secondo il paradigma della relazione Io-Tu -, tuttavia, nell’uomo, la presenza di un istinto che lo porta a distorcere la relazione autentica è ineliminabile: questa è la tristezza della nostra sorte.
C’è, però, una speranza che non è rappresentata soltanto dal buonsenso, ma che si fonda nel rapporto con il Tu Assoluto, con Dio. La grandezza di Dio sta nel fatto che non può trasformarsi in Esso. La nostra relazione con Lui ci “impregna” e dovrebbe impegnarci a promuovere l’autenticità, permettendoci di acquisire coordinate etiche, valori positivi e il senso profondo della realtà.
Buber, inoltre, per sottolineare il ruolo fondamentale giocato da Dio e per dare speranza e fiducia ai rapporti umani, definisce la complementarietà fra il rapporto Io-tu finito e Io-Tu Assoluto: si può trovare Dio negli altri, o, viceversa, sperimentando la limitatezza della relazione umana si giunge al bisogno dell’illimitato, a un’ulteriore apertura nell’apertura. La relazione con Dio, però non basta, non è l’unica necessaria nella vita umana e la natura relazionale dell’uomo non si risolve solo sul piano religioso, ma anche sul piano concreto dei rapporti interumani
Oltre all’autenticità e alla mediazione divina, Buber mette in rilievo che si può fare affidamento anche all’autoeducazione, passo funzionale alla conoscenza della propria natura, intenzionalità e responsabilità.
L’obiettivo dell’educazione deve essere la formazione del “Grande carattere”[36], che rende ragione della grandezza dell’uomo e consiste nell’essere fedeli alla propria natura dialogica. La relazione dialogale, termine che è quasi una tautologia, costruisce l’uomo: gli dà la possibilità di rispondere all’ “appello” che proviene dall’Altro, di mettere in pratica il proprio potenziale di responsabilità, apre a Dio, ai tu finiti e al mondo.
Ci si auspica la relazione d’aiuto fra educatore ed educando si possa realizzare nei termini dell’autenticità
“ Basta porsi quest’unica domanda: A che scopo?; a che scopo abbracciare il mio cammino personale, a che scopo portare a unità il mio essere? Ed ecco la risposta: Non per me…
Cominciare da se stessi; prendersi come punto di partenza, ma non come meta; conoscersi, ma non preoccuparsi di sé “.
“ A nessun’anima è fissato un fine interno a se stessa, nella propria salvezza individuale. E’ vero che ciascuno deve conoscersi, purificarsi, giungere alla pienezza, ma non a vantaggio di se stesso, non a beneficio della sua felicità terrena o della sua beatitudine celeste, ma in vista dell’opera che deve compiere il mondo di Dio. Bisogna dimenticare si stessi e pensare al mondo. Il fatto di fissare come scopo la salvezza della propria anima è considerato qui solo come la forma più sublime di egocentrismo…Ciascuno deve, nella vita con se stesso e nella vita con il mondo, guardarsi dal prendere se stesso per fine” [37].
Il senso dell’essere sarebbe rappresentato dall’orientamento all’incontro: torna ancora, anche in questo autore, l’idea che il lavoro su di sé non solo per se stessi e anche il dialogo non è vero dialogo se il suo scopo è mezzo esclusivo per la propria realizzazione personale.
Ognuno, però, può decidere autonomamente la propria direzione, nel rischio che comporta la libertà di scegliere la solitudine:
“Gli uomini che si pongono seriamente le questioni del bene e del male – avverte Buber – si ribellano quando qualcuno detta loro ciò che è bene e ciò che è male, come se ci fosse una qualche verità, stabilita da tempo, e si ribellano proprio perché hanno sperimentato moltissime volte come sia difficile trovare la strada giusta” [38].
L’uomo “essere in relazione”, l’uomo che prende coscienza di sé, l’uomo interpellato, che risponde, che mette in gioco se stesso: questo è l’uomo “autentico” di Buber.
L’educazione ne valorizza l’unicità, non lo riduce, né lo generalizza, ma indirizza il suo cammino favorendo la riflessione sui temi fondamentali dell’esistere per orientarlo. Secondo Buder l’educazione si attua nella relazione, che riguarda l’intera comunità, il “Noi”, non si chiude nell’esclusività del rapporto a due, ma coinvolge tutti, fino a tentare di porre la basi per l’esistenza di una società autentica.
Buber si spinge oltre, considera che il Noi racchiude la relazione io-tu e, nello stesso tempo, la trascende: nella dimensione della comunità, dell’apertura, realizzare un reticolato di relazioni autentiche vuol dire cercare di garantire il benessere e la valorizzazione del vivere in comune, che dipende dall’assunzione di responsabilità di ciascuno. Questa dimensione può proporsi come risoluzione della crisi determinata dalla dilatazione del mondo dell’Esso e della solitudine conseguente.
Buber non disdegna la prospettiva utopica, perché non la ritiene illusione o rischio, ma possibilità costruttiva. Il suo ottimismo è affidato alle forze creativa ed educatrice dell’uomo, risorse e soluzioni per il superamento dell’inautenticità, attraverso il dialogo che permette di andare oltre gli scambi superficiali e di garantire un coinvolgimento dinamico di tutti gli uomini che nella comunità vogliono costruire il Noi. La speranza per l’uomo è dettata dalla conversione, apertura alla relazione e attuabile nella capacità di educare ed educarsi.
L’educazione è proprio la prima responsabile del rinnovamento dell’uomo e della sua apertura al divenire, perché sa mediare fra utopia e possibilità.
Milan chiarisce cosa significhi il Noi, che si fonda sull’impegno partecipativo del singolo, sottolineando che per Buber il senso della “comunità” è la struttura sociale per eccellenza, capace di rispondere alle esigenze più profonde degli uomini nel loro rapporto con altri uomini.
“ Il “Noi Esistenziale”, come Buber chiama – in altro modo – la comunità, si costituisce proprio in relazione a tali compiti comunitari, attorno ai quali si anima una convivenza umana che rischierebbe altrimenti di limitasi ad una banalità di scambi interni superficiali e allo sterile solipsismo di un individuo collettivo incapace di trascendersi verso l’esterno ” [39].
Facendo tesoro di questo contributo si capisce che il rapporto d’aiuto deve fondarsi anche sui presupposti buberiani per essere, a sua volta, “autentico”, a partire dal concetto di relazione, carico di implicazioni e di responsabilità per l’uomo, dalle quali egli, come essere “etico”, non può esimersi.
1.3.2 La relazione fra educatore ed educando
Quando si parla di relazione d’aiuto, si ha a che fare con un utente che ha alle spalle un vissuto complesso, difficile, e che ha bisogno di essere accompagnato per una parte della propria esistenza da una figura professionale, preparata, con la quale intraprendere un percorso che conduca al superamento del disagio.
La relazione d’aiuto, però, non si attua solo nel caso dell’emergenza, del disagio e nemmeno solo nel contesto professionale. Si realizza quando “due persone vogliono comunicare, mettere in comune i loro interrogativi o le loro certezze”; quando sono “in contatto diretto, nell’ambito di una relazione di prossimità visiva, con la possibilità di toccarsi, di raggiungersi direttamente”; quando assieme cercano di “collegare, avvicinare, amplificare fatti, comportamenti, avvenimenti apparentemente scollegati o estranei gli uni agli altri”[40]
La relazione d’aiuto rappresenta il luogo d’incontro fra educatore ed educando. Perché si dia un intervento intenzionale, professionale, mirato a obiettivi precisi e funzionali allo sviluppo educativo, devono essere rispettate delle regole, devono essere possedute competenze da parte dell’educatore e, da parte di entrambi, deve essere manifestata la disponibilità a intraprendere un percorso assieme.
Sia dall’educatore che dall’educando dipende la riuscita o meno dell’intervento: è determinante la loro capacità di relazionarsi e la qualità della loro interazione.
L’interazione che si crea vede realizzati nel concreto i presupposti etici evidenziati dai diversi autori, alcuni dei quali sono stati precedentemente citati. Soprattutto, come dice la parola stessa, è “scoperta o conferma del fatto che ciò che accade ad uno dei protagonisti agirà sull’altro e viceversa”[41]. Salomè dimostra che i momenti in cui si richiede l’aiuto dell’altro sono svariati nell’esistenza dell’individuo, la scandiscono e la costituiscono. Nascono dal desiderio e dalla necessità dell’incontro, in cui sia chi si propone come sostegno, sia chi lo cerca devono dimostrare disponibilità: il primo nei termini della libera adesione, il secondo nei termini della fiducia a lasciarsi aiutare.
La relazione dal punto di vista dell’educatore
Il presupposto della relazione d’aiuto: il rispetto della “libera adesione”
“ Ritorna più volte il sospetto che l’operatore di un consultorio, così come altro consulente e consigliere, possa ledere con il proprio intervento la “libera scelta” dell’utente, tentando di manipolare e/o di coartare le sue motivazioni e le sue convinzioni personali” [42].
Il rispetto della libertà dell’educando, il quale può anche rifiutare l’aiuto, è un argomento delicato che viene generalizzato agli interventi di tutti gli educatori, oltre che dei consulenti.
All’educatore è richiesto di rispettare l’altro, di riconoscerlo, identificando le sue paure e i suoi bisogni. Non deve imporre la sua presenza, e questo è il motivo della difficoltà di intervenire nei confronti delle persone che non vogliono essere aiutate. Porto come esempio di questa problematica l’intervento nei confronti della devianza minorile, presentata, per la Caritas, da Nanni.
Dal momento in cui le risorse necessarie per il trattamento dei minorenni (in particolare comunità e servizi pubblici ad hoc per l’assistenza) sono insufficienti, in alcune Regioni italiane i ragazzi fino ai 14 anni vengono inseriti nei centri di neuropsichiatria infantile, ma, dopo tale soglia di età, l’unico istituto di accoglienza è costituito dai Centri di Igiene Mentale, che prendono in carico un’utenza prevalentemente adulta. In quest’ultimo caso, oltre al problema di adattamento, di stigmatizzazione e di identificazione negativa che la frequentazione di una struttura pubblica specializzata sul disagio mentale produce presso i ragazzi, l’inserimento del giovane e l’avvio di un programma di trattamento sono subordinati alla libera adesione dell’interessato[43].
Il problema di avvicinamento dell’utente è particolarmente delicato: per poter avviare l’intervento, l’educatore deve sospendere il giudizio e proporsi come “ascoltatore”, dimostrando la propria disponibilità e la propria disposizione positiva ad aiutare e a comprendendere difficoltà e resistenze.
L’educatore non solo deve lavorare per acquisire il punto di vista[44] dell’educando, ma deve infatti saper disporre l’educando stesso ad essere partecipe della relazione, attivo nel dialogo, sollecitandolo, incoraggiandolo, rendendolo consapevole delle sue risorse, affinché sviluppi una positiva immagine di sé e si disponga ad avviare un incontro mirato al cambiamento migliorativo.
Secondo Miodini e Zini[45], l’educatore deve cercare di collocarsi a mezza via fra gli eccessi che potrebbero caratterizzare il suo intervento: non deve avere atteggiamenti né di “impotenza”, né di “onnipotenza”. I primi possono essere dettati dalla sfiducia nei confronti della riuscita dell’intervento o dall’amplificazione dei fallimenti; i secondi rischierebbero di alimentare un rapporto simbiotico cui l’utente potrebbe aspirare per desiderio di protezione.
Sarebbe, inoltre, opportuno che gli obiettivi messi in campo nella relazione educativa venissero “negoziati” anche con l’educando, perché egli possa saper il perché dell’intervento, il fine al quale mirare, gli sforzi a lui richiesti, la scommessa sulle sue capacità, occasione anche per trasmettergli la fiducia di poter riuscire. Se l’educatore ha un’immagine negativa dell’educando, per la vita che questi ha vissuto, o per gli atti che ha commesso, non sarà possibile procedere, perché la relazione si fonda inequivocabilmente sull’accettazione incondizionata o disposizione verso l’altro e perché l’educando stesso percepirebbe il rifiuto. Molti dei vissuti che crediamo di nascondere una volta per tutte tacendoli a livello verbale, sono invece evidenti a livello gestuale, comportamentale, e come tali vengono recepiti. Il detto e il non detto fanno parte della relazione con gli altri, ed è fondamentale conoscerli perché proprio da noi educatori, dalla nostra fiducia, dalla nostra disposizione l’educando può trarre forza.
La maieutica
Attraverso l’ascolto, la comprensione, la comunicazione[46] l’educatore deve riuscire a essere maieuta.
La maieutica trae le proprie origini dal pensiero socratico. Platone descrive questa pratica, attribuendo a Socrate queste parole:
“Ora, la mia arte di ostetrico, in tutto il rimanente assomiglia a quella delle levatrici, ma ne differisce in questo, che opera sugli uomini e non sulle donne, e provvede alle anime partorienti e non ai corpi. E la più grande capacità mia è ch’io riesco, per essa, a discernere sicuramente se fantasma e menzogna partorisce l’anima del giovane, oppure se cosa vitale e reale. Poiché questo ho in comune con le levatrici, che anch’io sono sterile (…) di sapienza; e il biasimo che già tanti mi hanno fatto, che interrogo sì gli altri, ma non manifesto mai io stesso su nessuna questione il mio pensiero ignorante come sono, è verissimo biasimo. E la ragione è appunto questa, che il Dio mi costringe a fare l’ostetrico, ma mi vietò di generare. Io sono dunque, in me, tutt’altro che sapiente, né da me è venuta fuori alcuna sapiente scoperta che sia generazione del mio animo; quelli invece che amano stare in mia compagnia, ne ricavano, purché il Dio glielo permetta, straordinario profitto; come veggono essi medesimi e gli altri. Ed è chiaro che da me non hanno imparato nulla, bensì proprio e solo da se stessi molte cose e belle hanno trovato e generato; ma d’averli aiutati a generare, questo sì il merito spetta a Dio e a me”[47].
Socrate non si ritiene sapiente, afferma che la sua grande sapienza consiste nel saper professare la sua ignoranza. Non può essere, di conseguenza, dispensatore di verità, ma è colui che può aiutare gli altri a far emergere la verità dentro di loro. L’arte della quale Socrate si serve per far venire alla luce la verità è la maieutica, arte ostetrica spirituale. La verità si trova dentro l’uomo, quello è il luogo in cui deve essere cercata. L’uomo da solo può non sapere della risorsa di cui è portatore, per questo è necessario chi glielo insegni e lo aiuti a scovare le proprie risorse inaspettate e sconosciute.
La stessa è l’arte dell’educatore, “lettore” dell’altro, delle sue doti, delle sue capacità, come dei suoi desideri. Egli ha il compito di “tirarle fuori”, di scoprire e far scoprire quello che l’educando ha dentro e di cui non si è mai accorto di essere portatore. Non è un compito facile, richiede tempo, richiede l’avvio di una relazione; richiede, di pari passo, il rispetto dell’altro, perché non è di forzatura che si deve trattare, ma di “lavoro assieme” e, anzi, di apertura alla libertà dell’educando. La scoperta della propria soggettività, trampolino di lancio per andare all’altro, diventa anche occasione vitale per rafforzare la stima di sé.
Per l’educando vedere nell’educatore il maieuta, deve equivalere a vederlo come una persona disposta nei propri confronti, che può aiutare e di cui potersi fidare. La possibilità-necessità di riporre fiducia sono atteggiamenti che l’educando può imparare a ritenere leciti e privi di alcun rischio, vista la disposizione di interesse dell’educatore e la sua disponibilità assoluta nella gratuità, senza chiedere alcunché in cambio.
Nel testo del Congresso dell’ ANPE[48], chiamato “Educazione come relazione d’aiuto ed etica professionale”, Luisa Verdoscia[49] tratteggia proprio secondo la dimensione di maieuta la figura dell’educatore:
“ Credo che l’educazione debba far maturare delle convinzioni, quindi gli educatori devono avere il coraggio e la forza di far scoprire ai giovani quelli che essi ritengono che sia il senso della vita facendo conoscere il loro io più profondo.
(…) La pedagogia che è riflessione su noi stessi, espansione della coscienza, autorinnovamento, può fornire un qualificato aiuto a conseguire la padronanza di sé e la consapevolezza del proprio posto nel mondo.
(…) Peraltro l’informare, l’organizzare, cioè produrre una situazione di apprendimento, l’animare, cioè il motivare e il consigliare sono tecniche di azione pedagogica…” [50].
Tanti sono i compiti e i “ruoli” dell’educatore: deve aiutare, favorire il dialogo, disporsi all’ascolto, comprendere, camminare accanto e, nello stesso tempo, deve essere insegnante, animatore, amico, supervisore, compagno di viaggio. Tutto il percorso d’aiuto si fonda su un’unica irrinunciabile certezza, che è presupposto di tutte le azioni educative: la consapevolezza che l’educando sappia pensare da solo, sappia dare senso al vissuto, sappia ragionare e avere un personale, unico, peculiare punto di vista su fatti passati e presenti, che sia un “essere attivo”. Come ben spiega Platone, non è Socrate in persona che dirige gli uomini, ma dagli uomini stessi scaturisce la verità. L’unico aiuto di cui abbisognano, la maieutica, seppur fondamentale perché sia possibile la lettura di questa verità nascosta, presuppone l’esistenza della verità nell’altro: Socrate può “tirar fuori” la verità, perché è sicuro questa esista nell’altra persona, così come l’educatore può relazionarsi con l’educando – costruendo la relazione di aiuto, dialogica, di confronto, bidirezionale -, perché è sicuro la capacità di dialogo, di relazione esistano nell’educando. L’educatore crede nell’apporto unico dell’educando nella relazione d’aiuto e confida in questo.
La maieutica fa parte dei presupposti della relazione educativa, in quanto l’educatore deve agire nei termini con cui agisce il maieuta per portare aventi il proprio compito di “facilitatore del potenziale umano”. Essere maieuta vuol soprattutto dire rispettare e valorizzare le potenzialità umane dell’educando, per realizzare lo scopo educativo che consiste nel guidarlo per poi farlo camminare con le proprie gambe.
Rogers offre un importante contributo per spiegare in che termini l’educatore debba agire per rispettare l’educando nella libera adesione e come essere umano, garantendogli la possibilità di sviluppo. Il counselling nasce con le scuole psicologiche americane di stampo umanistico, in primis con la terapia centrata sul cliente di C.R. Rogers, nella direzione soprattutto di favorire l’autodeterminazione del “cliente”. Nel campo pedagogico non parliamo di cliente, ma di interlocutore, utente, di “educando”. Knowles[51], nel racconto del suo percorso di vita e di formazione professionale, nella parte dedicata alla riflessione su come abbia imparato a liberare le energie degli altri, fa riferimento esplicito alle caratteristiche comportamentali che secondo lui devono avere i leader creativi, traendo spunto dal contributo di Rogers e di McGregor. Egli afferma che
“Essendo cresciuto nell’era dello scientific management di Frederick Taylor, percepivo il ruolo di un leader principalmente come un ruolo di controllo dei suoi seguaci o sottoposti. Mi era stato insegnato che sono efficaci quei leader in grado di ottenere obbedienza, cioè persone che eseguano gli ordini. L’effetto di questa ideologia era naturalmente che i risultati prodotti non potevano andare oltre quello che la lungimiranza e la capacità del leader prevedevano” [52].
Secondo la linea conduttrice di questo approccio, che egli ben presto supera, non è messo in gioco il contributo che può apportare l’educando, né è considerata la possibilità che egli ne possa apportare uno. Lo spazio di azione è totalmente riservato all’educatore, con tutte le conseguenze che questo comporta e il carico di responsabilità, che interamente grava su di lui: la capacità di agire e di essere responsabile sembrano essere solamente sua prerogativa. Knowles, gradualmente, si accorge che la funzione della leadership avrebbe dovuto essere diversa e, invece che controllare, all’opposto, avrebbe dovuto occuparsi di “svincolare “ e “incanalare” le energie delle persone operanti nel sistema, proprio come fa il maieuta. Esprime questa idea con il termine di leadership creativa, intesa come “ quella forma di leadership che svincola l’energia creativa delle persone guidate dal leader”. Queste le idee sulla natura e il comportamento umano ricavate dal contributo di Rogers[53]:
Ipotesi implicite nell’istruzione tradizionale CONTROLLO:
Non ci si può aspettare che lo studente porti avanti da solo il suo apprendimento.
La presentazione dei contenuti corrisponde a ciò che si è appreso.
Lo scopo dell’istruzione è accumulare mattone dopo mattone un sapere basato sui fatti.
La verità è conosciuta.
Partendo da discenti passivi, si formano cittadini creativi.
Valutare è istruire, istruire è valutare.
Ipotesi relative al modello dell’apprendimento esperenziale SVINCOLO:
Gli esseri umani hanno una capacità naturale di apprendere.
Un apprendimento significativo si verifica se l’argomento è percepito dallo studente come pertinente ai suoi scopi personali.
Gran parte dell’apprendimento significativo viene acquisito nel fare qualche cosa. L’apprendimento è facilitato dalla partecipazione responsabile degli studenti al processo di apprendimento.
L’apprendimento intrapreso in maniera autonoma, che coinvolge l’intera personalità – sentimenti e intelletto – è quello più profondo e duraturo.
La creatività nell’apprendimento viene maggiormente facilitata quando si dà più importanza all’autocritica e all’autovalutazione rispetto alla valutazione da parte degli altri.
Quello che è socialmente più utile imparare nel mondo moderno è il processo di apprendimento, l’apertura continua all’esperienza, l’ incorporare in se stessi il processo di cambiamento.
Il contributo di Rogers, che ben si inserisce all’interno della sua teoria della non direttività, è da considerarsi spunto di riflessione non solo per l’azione del formatore, ma per l’educatore, il quale si propone come compito chiave la scoperta e l’espressione della creatività e delle capacità dell’educando.
Knowles elenca le caratteristiche di coloro che come educatori sanno essere “maieuti”, vale a dire dei così chiamati leader creativi:
a) I leader creativi possiedono un insieme di premesse ( essenzialmente positive ) sulla natura umana che sono diverse da quelle (essenzialmente negative) dei leader che controllano.
Come dimostrato nella teoria di Rogers, precedentemente esposta, fatta propria da Knowles, i leader creativi sono coloro che “hanno fiducia nelle persone, offrono loro delle opportunità che le stimolano e delegano responsabilità”. La persona, nel nostro caso l’educando, deve sentire di essere protagonista a pieno titolo del percorso d’aiuto; il fatto che sia strutturato appositamente per lui rende lecito e, nello stesso tempo, indispensabile il suo personale coinvolgimento.
b) I leader creativi accettano come legge della natura umana il fatto che le persone si impegnano rispetto a una decisione solo nella misura in cui sentono di avervi partecipato.
E’ importante e motivante il coinvolgimento, non solo nelle varie tappe del percorso, ma anche nella definizione delle stesse, nella valutazione dei bisogni, nella formulazione degli obiettivi, fino alla valutazione dei risultati.
c) I leader creativi credono nel potere delle profezie che si autorealizzano e lo usano.
Il principio di riferimento è il così chiamato “effetto Pigmalione”[54], che si verifica nella corrispondenza fra le aspettative degli insegnanti nei confronti degli studenti e i risultati di questi ultimi che confermano le aspettative iniziali. Questo processo non dimostra la capacità degli insegnanti di anticipare chi sia effettivamente bravo nella classe, bensì il contrario, vale a dire la capacità degli studenti di sapere soddisfare le aspettative degli insegnanti. I leader creativi sanno bene che le persone tendono a essere all’altezza di quanto gli altri si aspettano da loro.
d) I leader creativi tengono in grande considerazione l’individualità.
E’ necessario la persona sia libera di dimostrare le proprie “forze”, sia perché possa dimostrare quello che effettivamente ha dentro, possa credere, grazie al sostegno dell’educatore, di potercela fare, di potersi ricostruire, di poter andare avanti, ma anche per il proprio bene, perché all’indomani della chiusura del rapporto di aiuto sappia essere autonoma.
e) I leader creativi si impegnano costantemente in un processo di cambiamento e sono esperti nel gestirlo.
Questi ultimi due punti si costituiscono sull’assunto in base al quale è proprio la creatività il requisito fondamentale dell’uomo che vive nella società postmoderna, in cui cambiamento e flessibilità non sono tanto delle scelte, ma obblighi e dati di fatto.
f) I leader creativi sottolineano maggiormente i fattori di motivazione interni rispetto a quelli esterni.
Fattori di motivazione esterni sono salario, status, sicurezza di impiego, condizioni di lavoro, relazioni interpersonali. Quelli interni hanno a che fare con ciò che va oltre i precedenti, e che chiama in causa la parte più profonda dell’uomo: sono il successo, i riconoscimenti, la gratificazione, la responsabilità, la crescita.
g) I leader creativi incoraggiano le persone a essere autonome nell’apprendimento.
Con quest’ultimo punto ci si collega alla questione delineata nel paragrafo precedente, relativa alla “libera adesione”. Il formatore dispone al cambiamento, ma per prima cosa è necessaria la disponibilità del soggetto; parallelamente, anche se l’educando può e deve essere aiutato, è lui per primo che deve volere l’aiuto. Nel caso non si dia disponibilità, nel caso in cui l’educando non aiuti ad essere aiutato, rischiano di crearsi degli ostacoli nella relazione d’aiuto che impediscono il suo svolgersi.
Una raccomandazione viene rivolta all’ “educatore-maieuta”: non prendere il posto dell’educando: il lavoro ermeneutico deve essere lasciato al soggetto. Infatti, non ritengo che il lavoro d’aiuto consista nell’ “argomentazione persuasiva”, definita da Platone, nel “Fedro”[55], come “forma di argomentazione propria della retorica, parte della conoscenza, per arte ed esperienza, della natura dell’anima per infondere persuasione e virtù con ragionamenti e savie ordinazioni”; nemmeno consiste nell’azione persuasiva che si fonda sulla psicagogia, o conduzione delle anime, proposta da Pascal, il quale afferma che “occorre aver riguardo, al di là della cosa della quale si vuole persuadere, della persona che si vuole persuadere, della quale occorre conoscere l’esprit et le coeur, i principi che sostiene, le cose che ama”. Il lavoro educativo è lungi dalla persuasione in sé, perché, pur trovandosi l’educatore-maieuta nel ruolo di conduzione, tutte le sue azioni sono rivolte al bene dell’educando, alla scoperta e all’espressione della sua interiorità. Non usa armi contro di lui, nemmeno se l’obiettivo ultimo è eticamente giustificato, se è il suo bene.
In questa sede introduttiva sulla relazione d’aiuto, è opportuno, prima di addentrarsi nel corso del lavoro, schematizzare[56] compiti, responsabilità, capacità dell’educatore, per averne un’idea, prima sommaria, che verrà arricchita successivamente. Non c’è pretesa di esaurire completamente il ruolo educativo in pochi concetti, ma il desiderio di chiarire schematizzando, dando ordine a una realtà che si presenta caratterizzata da estrema complessità: è questa, infatti, la caratteristica delle “questioni umane”, e il loro fascino.
Fig 1. Qualità, capacità e operato dell’educatore.
Il lavoro è centrato sull’educando, con l’obiettivo di lavorare sul futuro. Perché questo percorso si possa attuare si devono realizzare delle condizioni, relative al rispetto, alla responsabilità, alla presa in carico. L’educatore deve imparare a fronteggiare, a conclusione del rapporto, sia il successo che il fallimento.
La relazione dal punto di vista dell’educando
Il presupposto della relazione d’aiuto: lasciarsi aiutare. La fiducia come rischio e apertura
La condizione che rende impossibile l’intervento è la mancata disponibilità di una delle parti relazionantesi. E’ necessario sottolineare a più riprese il carattere costituitivo della relazione d’aiuto, caratterizzato dalla perfetta specularità, soprattutto di “requisiti” e di orientamento al cambiamento, fra l’educatore e l’educando: la relazione d’aiuto non vede solo l’educando come soggetto di cambiamento, ma vede l’educatore stesso concretamente coinvolto e passibile di cambiamento; viceversa non “scommette” solo sull’educatore, sul suo contributo, ma considera la partecipazione dell’educando necessariamente funzionale alla buona riuscita dell’intervento. Soprattutto in un’ottica che vuole l’educando sia attivo, non è concepibile egli si disponga, anche a livello di progettazione, con il proposito di subire passivamente la relazione. Possibilmente, se non sarà subito, perlomeno a livello di progettazione avanzata, una volta avviato il precorso, deve partecipare, fornendo un contributo funzionale, per esempio, a far capire i propri bisogni: è auspicabile l’incontro venga costruito assieme.
Se metaforicamente educatore ed educando potessero essere rappresentati da due punti equidistanti, immaginiamo che minor fatica sarà fatta per l’uno di arrivare all’altro, se entrambi si muovessero. L’avvicinamento potrà realizzarsi in virtù del rispetto dell’ ”eterocronia”[57] , ma è auspicabile che l’educatore, in un certo momento, si metta ad aspettare la risposta dell’educando alla sua prima mossa di avvicinamento. La chiave della relazione d’aiuto è comunque costituita, uscendo dalla metafora, dalla necessità di ricevere un contributo di disponibilità da entrambe le parti.
Capita che l’educando non dia la propria disponibilità a relazionarsi per incapacità, per resistenza o disinteresse. A volte è difficile, da parte degli operatori, la preparazione delle basi per ottenere la fiducia. Addirittura vista la difficoltà - tanto grande da aver fatto parlare anche di impossibilità - a relazionarsi con alcuni utenti particolarmente disinteressati e reticenti, alcune associazioni della città di Roma, nell’opera di intervento sul territorio, si sono trovati a dover escludere alcune componenti giovanili[58]. Una volta cresciuto in una subcultura per la quale la normalità è costituita dall’adozione di comportamenti devianti, sembra raro il caso in cui il minore la rinneghi spontaneamente per volgersi ad un contesto culturale nonché ad uno stile di vita diversi da quelli assimilati e incontrati fino a quel momento: se i presupposti per rientrare nell’educabilità non sono mai stati introiettati né incontrati, per il soggetto risultano lontani dalla realtà che vive e soprattutto non funzionali a continuare a stare accanto al gruppo e alla famiglia di cui continua a far parte.
E’ certamente consistente il fenomeno della corresponsabilità degli adulti nella produzione sociale della devianza minorile: per alcuni soggetti in crescita, nel caso in cui le prime esperienze di contatto con strutture e servizi pubblici siano prevalentemente di tipo conflittuale, si determinano per il resto della vita possibili atteggiamenti di distanza, di sospetto o di sfida verso le istituzioni, se non addirittura verso l’intera società, percepita come ostile. Nel testo della Caritas[59], “famiglia-deviante” e “famiglia-portatrice sana” emergono come famiglie-ostacolo nei programmi di trattamento: la prima costruisce un cordone protettivo attorno al minorenne già agganciato al giro malavitoso e fa in modo che non venga recuperato da nessun intervento educativo; la seconda tende a coprire i figli, minimizzando l’azione deviante commessa.
Bisogna spiegare la mancanza di disponibilità da parte dell’educando non solo da un unico punto di vista: oltre alla difficoltà-disinteresse, anche ereditati, relativi al recupero, bisogna tener conto anche della convinzione di non farcela. Quest’ultimo senso lascia spazio al versante della pedagogia intesa come “terreno di speranza”, che si proietta verso il futuro con disposizione positiva e con proposte, competenze, convinzioni concrete in merito alla riuscita dell’intervento. Inevitabilmente e costitutivamente l’educazione è caratterizzata dal rischio, dall’incertezza, ma si propone di organizzare al meglio le proprie risorse per riuscire.
Bertolini sostiene che la condizione essenziale perché sia possibile un intervento educativo di recupero è la conoscenza, oltre che del vissuto, del senso che il soggetto attribuisce al vissuto stesso. La relazione d’aiuto è possibile se l’educando vi partecipa attivamente e se attribuisce un senso positivo al proprio ruolo nell’esistenza[60]. Dal momento in cui si trova a chiedere aiuto, con messaggi diretti o inconsciamente, può non avere la capacità, o la forza, di superare da solo il negativo che vede nella propria esistenza: questa è “responsabilità” cui deve potervi arrivare con l’aiuto dell’educatore.
Salomè definisce la relazione d’aiuto come intervento caratterizzato da ambiguità, da fasi di progresso, di ristagno o di regressione. Nella sua attuazione entrano in gioco le emozioni dei protagonisti, anche caratterizzate da ambiguità fra il desiderio di riuscita e il tentativo di ostacolare gli obiettivi di cambiamento, visto come rischio di “allontanamento da sé”. Come sono previste delle “trappole”, messe in atto da parte di chi aiuta – una fra tutte, e forse la più grave, è il tentativo di alimentare il legame di dipendenza, invece di lavorare gradatamente per scioglierlo -, possono esserne messe in atto anche da parte di chi è aiutato:
“ Chi è aiutato cerca, in alcune fasi della relazione, di mettere alla prova chi lo aiuta. Ad esempio fa di tutto per conservare il controllo della relazione, cercando di evitare le responsabilità dei suoi atti, sentimenti e pensieri.
Molte trappole così costruite hanno lo scopo di controllare la relazione per non cambiare (mantenere lo stesso guadagno con minore spesa). Attraverso questi tranelli chi è aiutato cerca di non assumersi le responsabilità del proprio cambiamento. Tutto avviene come se egli preferisse rimanere nel noto ( anche se insoddisfacente) piuttosto che andare verso l’ignoto ( troppo incerto). E’ come se la sofferenza (possibile motore di cambiamento) non fosse sufficiente per comportare una rinuncia ai guadagni o ai “vantaggi” consolidati in una situazione conosciuta e mantenuta ( questo ci fa ricordare una cosa evidente: un sistema relazionale, per sofferente e bisognoso che sia, per sopravvivere ha bisogno della collaborazione di tutti i suoi protagonisti: boia, vittime e spettatori…) ” [61].
Vengono anche indicati in modo specifico alcuni esempi di trappole messe in atto da chi è aiutato: la confusione, inconsapevole o ricercata, fra rapporto con l’educatore come persona e come professionista; il tentativo di dimostrare l’inutilità dell’aiuto, sia a causa l’estrema gravità della propria situazione, tanto che nessuno la potrà migliorare, sia perché il fatto di sentirsi inutile giustificherebbe il disinteresse nei suoi confronti anche da parte degli altri; l’attribuzione all’altro, e quindi anche all’educatore, dei propri pensieri, anche distruttivi.
Salomè qualifica questi atteggiamenti come una persecuzione, come un tentativo di imposizione, quasi l’educando si senta di desiderare la competizione con l’educando e di uscire vincitore, dimostrando di aver interpretato i fatti-il passato-la situazione causa di disagio e di aver già capito che non si può far niente per migliorare.
Qualche volta, l’educando può manifestare una mancata disponibilità ad intraprendere la relazione d’aiuto parlando di ciò che non lo riguarda, di altri, per sviare l’attenzione, per non lavorare su di sé. Questo atteggiamento può manifestare non solo sfida, ma più precisamente il rifiuto, l’incapacità di riconoscere le proprie difficoltà. Se l’educando si dimostra certo delle proprie interpretazioni, sarà più difficile raggiungerlo, perché potrebbe interpretare l’intervento dell’educatore come un’intromissione, come un tentativo di frammentazione delle proprie certezze.
Come pone il problema, così Salomè cerca di trovarvi una soluzione: punta sull’educatore che dovrebbe agire con “permissività”, che consiste nel “lasciar essere”, facendo però comunque attenzione a non lasciare carta bianca a chi viene aiutato; sulla “potenza”, garantendo un intervento fermo e deciso; sulla “protezione”, per trasmettere all’altro la possibilità di lasciarsi andare; sulla “permanenza”, dimostrandosi punto di riferimento costante.
Per chiarire ruolo e compiti di educatore ed educando, e, in particolare, dell’uno rispetto all’altro, i due pensieri di Nanni e Pellerey si completano vicendevolmente:
“ La tradizione pedagogica ha sempre più vivamente messo in luce che ogni azione educativa trova la sua diretta collocazione all’interno di un rapporto dinamico tra persone ( sia in termini inter-individuali o inter-personali o di gruppo o collettivi). E si comprende sempre meglio che l’esito educativo è funzione non tanto dell’educatore o dell’educando, ma, piuttosto, della loro relazione e della buona qualità di essa”[62] .
“In fin dei conti il responsabile del processo formativo è il soggetto in formazione stesso, l’educatore non può far altro che porre le condizioni necessarie o convenienti affinché egli possa e voglia agire in prima persona: Ma non per questo l’educatore svolge un ruolo irrilevante nell’intero processo. Senza di lui, senza il suo stimolo, il suo orientamento, la sua guida, il suo sostegno, il suo ascolto e la sua comunicazione, in una parola senza una conversazione educativa valida e coinvolgente, non è possibile che il soggetto cresca umanamente e professionalmente”[63]
Educatore ed educando agiscono insieme, l’uno accanto all’altro e, insieme, giungono a coordinare le loro azioni. Dando nel contempo ragione a Nanni che considera le due azioni parallele ed egualmente indispensabili, Pellerey attribuisce la “responsabilità” del processo formativo all’educando: l’educatore è “guida”, ma chi realmente rende possibile l’intervento è l’educando, perché a lui spetta il compito decisivo di accettare l’aiuto. Si può affermare sia una “responsabilità primaria”, che dà il via all’innescarsi di tutta una conseguente serie di responsabilità, che però non si potrebbero dare nel caso di rifiuto dell’educando.
Anche per quanto riguarda compiti e paure dell’educando ritengo opportuno avviare a una lettura introduttiva e generale, attraverso uno schema dei presupposti che spiegano perché egli compie il passo dell’adesione alla relazione d’aiuto. Anche se inizialmente superficiale, l’intento è di chiarire gli aspetti fondamentali, riassumendoli.
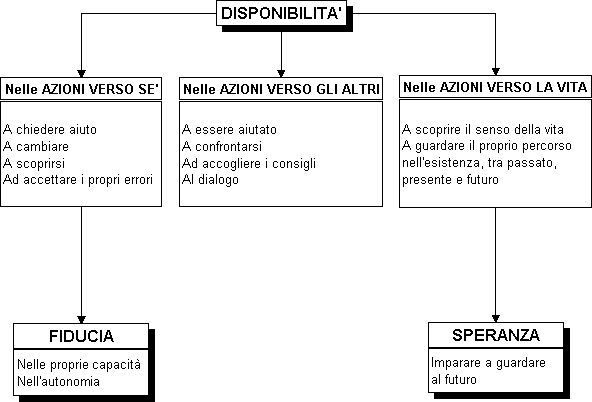
Fig.2. Si ritiene che tre siano gli ambiti di disponibilità che l’educando deve dimostrare. Oltre a permettere la costruzione del rapporto con l’educando, favoriscono la maturazione, in lui stesso, di fiducia e speranza.
1.4 IL CONCETTO DI AIUTO
L’intervento di aiuto è insegnamento: una persona più esperta si dispone accanto ad una persona meno esperta, la quale necessita di essere avviata a nuove conoscenze.
I campi della relazione d’aiuto possono essere molteplici, esistono, infatti, diverse modalità di intervento, ma tutte hanno a che fare inequivocabilmente con la dimensione dell’essere, con i valori umani. L’educatore entra nelle vite di queste persone, coglie i loro vissuti e li comprende. Lo fa “in punta di piedi”, rispettando silenzi e segreti. Insegna e impara egli stesso.
Si dà per scontato che l’individuo debba imparare nella prima infanzia, ma per quanto riguarda gli adulti sembra che le chiavi che danno accesso alle domande che l’Uomo si pone siano già state tutte trovate, eppure anch’essi sono “in cammino”. S.Agostino rappresenta emblematicamente l’immagine dell’uomo che cerca la propria strada, la propria vocazione, già in un’epoca, il secondo secolo dopo Cristo, in cui sembrava d’obbligo, da maturi, aver già trovato il proprio posto stabile. I filosofi tutti rappresentano l’Uomo alla ricerca, spinto dalla curiosità, dallo stimolo di fare quanto più fosse possibile nell’arco di una vita.
I miti[64], citati anche da Demetrio nel suo libro sull’Educazione degli adulti, ci tramandano storie e leggende fantastiche di uomini che imparano, viaggiano, trovano nuovi paesi e personaggi sconosciuti. Imparare non è solo una necessità pratica, come imparare delle abilità propedeutiche a svolgere un lavoro manuale, ma è un’abilità umana che coinvolge tutte le attitudini, anche quelle intellettuali.
Nel testo di Carracciolo e Rovetto, “Ritardo mentale” [65], vengono citate le tre concezioni del comportamento verbale per Catania. Fra queste il “controllo istruzionale” è uno degli aspetti più interessanti, per la nostra riflessione: è la possibilità, che il comportamento verbale offre a ciascun uomo, di istruire un altro individuo. E’ da questa dimensione che deriva la caratteristica del comportamento umano di essere governato da regole, costituite appositamente dagli uomini stessi per insegnare ai propri simili. In questo senso è chiaro che imparare non è segno di subordinazione di fronte ad un altro individuo, né di inferiorità, ma distingue l’uomo.
Ecco perché l’educando deve disporsi nella relazione educativa senza paura di essere aiutato, senza paura del “nuovo”, senza paura di essere giudicato per la propria diversità. La sua diversità, anzi, al contrario, sarà garanzia di arricchimento e, in un lento processo in cui il tempo dimostra tutta la sua forza costruttiva, potrà essere - se egli collaborerà - valorizzata, grazie all’intervento dell’educatore, e volta in termini positivi.
Insegnare e imparare sono fin dai tempi più antichi il modo più semplice di costruire e trasmettere la propria umanità: nessun uomo da solo potrebbe compiere quei passi rivoluzionari che tanti uomini hanno compiuto assieme. Anche sulla base di questa immagine, è possibile leggere la relazione d’aiuto.
Sul tema dell’aiuto è necessario sviluppare due ordini di considerazioni. La prima riguarda le condizioni alle quali si può parlare di aiuto in senso educativo, la seconda riguarda un’ampia veduta di questo concetto.
Secondo Chieregatti[66] l’aiuto non si realizza nei termini pedagogici a qualunque condizione: non deve imporsi né offendere chi lo riceve, non deve’essere volto a se stessi e al proprio interiore bisogno di sentirsi utili, non deve’essere valutazione. Egli elenca alcune domande tipo che capita tutti si pongano prima di aiutare: “Che cosa ci guadagno?”, “Che cosa ci perdo?”, “Posso permettermelo? Sono in grado di dare aiuto?” [67]. Sono funzionali a stabilire, anche a livello inconscio, la nostra disponibilità ad andare incontro all’Altro, valutando:
- livello finanziario richiesto,
- tempo ,
- serenità, o il fatto di attraversare un periodo particolarmente felice,
- desiderio di non sentirsi in colpa o non sentirsi una cattiva persona,
- tipo di impegno,
- non da ultimo, il grado di rapporto-partentela-conoscenza della persona bisognosa.
Di fronte ad un elenco come questo, dettato più dall’individualismo che dall’amore interumano, già si capisce che l’aiuto è generalmente subordinato a una riflessione sull’opportunità di intervenire, non è incondizionato, né immediato.
Può addirittura accadere che ad alcune condizioni nessuna persona si senta implicata. E’ il caso di eventi disastrosi come una guerra, che fa sentire impotente il singolo e lo fa pensare all’opportunità-comodità di delegare l’aiuto alle Associazioni umanitarie.
Oltre a questi meccanismi di pensiero, consci o inconsci, che si attivano nei casi di bisogno, si consideri che a monte della disposizione verso l’altro c’è sempre, oltre ad una valutazione del rapporto costi-benefici, anche una valutazione “del merito”: solo alcune persone “meritano” di essere aiutate. Questo giudizio è “emarginante”, perché priva dell’aiuto coloro che sono ritenuti responsabili primi dei propri guai e porta a considerare che i gesti di solidarietà non sono dovuti, ma meritano sempre riconoscenza: si mercifica, si riduce quasi a fatto economico l’agire umano, privato della gratuità, del dovere etico che coinvolge tutti gli uomini.
Possono essere effettivamente considerate disarmanti tali premesse, fondandosi sulle quali una relazione d’aiuto sarebbe indubbiamente estraniata dalla sua specificità umana, si fonderebbe sulla strumentalizzazione.
Nel Convegno di Roma sull’Educazione, tenutosi nell’ottobre del 1999, cui parteciparono personalità come Dantoni, Romiti, Fossa, si era già espressa la preoccupazione per il futuro: l’Europa fondata esclusivamente sul “fatto economico” non può reggere. E’ necessario un fondamento economico-politico ineludibile, ma è anche e soprattutto necessario costruire un’unità nuova, attraverso l’educazione, lavorando per un potenziamento dei valori dell’educazione stessa, quali rispetto delle diversità, senso dell’altro, partecipazione. L’educazione si propone e viene riconosciuta come valore, avente punto di riferimento e oggetto di tutela l’uomo, da salvaguardare, da aiutare.
L’aiuto si realizza nel contesto di un rapporto, di una relazione tra chi aiuta e chi è aiutato, e ogni uomo ne è strettamente coinvolto perché, a sua volta, ha sempre bisogno degli altri. E’ essenziale che siano rispettati i ruoli di soccorritore e soccorso e che entrambi siano valorizzati a livello umano e nelle loro potenzialità, non dimenticando che chi riceve aiuto ha diritto a riceverlo è lo può dare a sua volta.
Fra educatore che educando ci sono dei divieti, non rispettando i quali non si dà aiuto. Quelli di primaria importanza sono:
1. Il divieto di imporsi sull’altro, di non rispettare le sue idee;
2. il divieto di impedire la libertà di espressione, la riflessione critica, impedire dialogo e confronto costruttivo;
3. il divieto di dimenticare il proprio ruolo di “responsabilitàL’aiuto non deve creare un obbligo, non deve far sentire il destinatario inferiore né dipendente, ma lo deve trattare come persona, con le sue ricchezze, ma anche le sue carenze e con la capacità di saper ammettere queste ultime e soprattutto di poterle superare. Sottolinea Chieregatti
“ …perché si instauri una relazione d’aiuto è necessario che uno ammetta di essere in difficoltà, di trovarsi in un momento particolare, di mancare di qualcosa; ma questo è possibile soltanto nei confronti di qualcuno che si è dimostrato amico, solidale, disponibile, e soprattutto anch’egli bisognoso di qualcosa “ [68].
Il secondo ordine di considerazioni che mi sono proposta di trattare riguarda una consapevolezza e una riflessione generale che attraversa tutto il testo: l’aiuto, in educazione, non prevede solo di entrare nel campo della riabilitazione, dell’assistenza e del recupero, ma tiene conto del bisogno in senso lato, cerca il modo migliore per accogliere, sostenere, consigliare, accompagnare la persona.
Si attua per “rialzare” la persona, per cercare assieme a lei delle motivazioni, garantendo un supporto. E’ disposizione ad aiutare chi lo chiede, ma anche chi ha bisogno e non se ne rende conto o non vuole ammetterlo, chi si incontra nella propria vita quotidiana, nella famiglia o nell’ambito lavorativo, chi è accanto a noi, chi è l’Altro.
L’aiuto è ascolto, comprensione, alternarsi fra parole e silenzio[69], donare e domandare[70], condividere intenzionalmente, disponibilità[71]. Questi sono alcuni dei concetti che per Salomè definiscono il colloquio di aiuto.
L’aiuto si attua come segno di solidarietà, non solo nell’emergenza, nell’assistenza, nella professione, ma in ogni incontro.
2 LA RELAZIONE D’AIUTO
2.1 LA RELAZIONE D’AIUTO COME TENSIONE AL CAMBIAMENTO
Foucault, fra i quattro tipi fondamentali di tecnologia da lui distinti, che stanno alla base della pratica, colloca la relazione d’aiuto all’interno delle tecnologie del sé:
“ Le tecnologie del sé, che permettono agli individui di eseguire, coi propri mezzi o con l’aiuto degli altri, un certo numero di operazioni sul proprio corpo e sulla propria anima – dai pensieri, al comportamento, al modo di essere – e di realizzare in tal modo una trasformazione di se stessi allo scopo di raggiungere uno stato caratterizzato da felicità, purezza, saggezza, perfezione o immortalità ” [72].
Nella relazione d’aiuto l’educatore si propone come esperto per aiutare, servendosi del supporto della sua preparazione teorica e pratica e della mediazione fra le due dimensioni. I campi di applicazione della relazione d’aiuto sono indicati in modo preciso da Blezza[73]: i rapporti fra genitori e figli in età di sviluppo, la scuola di base e ogni altro campo scolastico di istruzione- formazione, i rapporti tra genitori e figli di altra età; i rapporti reciproci fra genitori; i rapporti familiari e parentali; il volontariato; lo sport e le attività giovanili; le attività per l’adultità e la terza età, l’educazione permanente; la gestione della risorsa uomo come soggetto di cultura; la giustizia; la sanità; i servizi sociali e le comunità di accoglienza e di terapia; la formazione e gestione del personale delle aziende; la relazione fra strutture pubbliche e private. Egli indica nella relazione d’aiuto una pratica di intervento avente lo scopo di ristabilire l’equilibrio e il dialogo, di orientare nella vita, di aiutare e di insegnare a stare bene.
Lagache definisce il colloquio come “situazione provvisoria di interazioni e influenze reciproche, essenzialmente verbali fra due persone in contatto diretto con obiettivi prefissati”.
Rogers afferma che si può parlare di relazione d’aiuto “quando almeno uno cerca di favorire l’altro nella crescita, nello sviluppo, nella maturità, per arrivare a massimizzare la capacità di affrontare la vita”.
Entrambe queste definizioni possono indirizzarci per capire meglio a che cosa conduce la relazione d’aiuto, perché viene intrapresa e, una volta intrapresa, quali vantaggi porta.
Gli aspetti chiave sono rappresentati dalla compresenza di due personalità, una di fronte all’altra, che attraverso il colloquio si relazionano e dal fatto che di queste una ha il controllo della situazione, la responsabilità di far riflettere e di riflettere per sviluppare nell’altro delle capacità, rispetto a un piano stabilito, condiviso, ma non predeterminato.
Afferma Scurati che “la relazione educativamente valida è una relazione d’aiuto, nella quale ci si assume la responsabilità e il rischio della guida perché essi altro non sono che dei doveri verso la personalità che cresce; ma, nello stesso tempo, è una relazione che intende accettare in tutta la sua estensione il diritto dell’altro a diventare se stesso. E’ quindi una relazione funzionale a un progetto i cui termini ultimi stanno in un disegno originale che l’educatore può soltanto cercare di interpretare ma non può certamente tracciare egli stesso in tutte le sue linee”[74].
La relazione d’aiuto è questo, ma è molto altro, perché non implica semplicemente un incontro fra due persone, ma un incontro che verte su temi “esistenziali”, come dice Rogers, che hanno implicazione con la vita: è un contributo sempre più richiesto nel nostro secolo - in cui è manifesto il crescente bisogno di “educazione” - perché aiuta l’uomo “nel suo incessante processo di liberazione, di valorizzazione, di qualificazione, così che egli diventi, in certa misura, responsabile del suo presente, inventore e artefice del suo futuro e critico di se stesso, capace di adattarsi liberamente, creativamente e costruttivamente a un mondo che cambia, e capace altresì di collaborare con gli altri all’edificazione di una società più giusta e più umana” (Santomauro, 1975).
Si è parlato di intervento che può risultare difficile nella sua applicazione, fra le altre cause, per la mancata disponibilità o per la difficoltà-resistenza dell’educando a cambiare, specie se egli si trova in situazioni caratterizzate, per esempio, da radicamento nella devianza, ereditato da generazioni, sviluppato attraverso una forma di educazione deviante che i genitori trasmettono ai figli; questo è solo un esempio, perché l’intervento educativo non si colloca esclusivamente nei casi di emergenza o di “recupero impossibile”: è lavoro sul passato, sul presente, sul futuro, nel conteso dell’educazione permanente, rivolta a tutte le età della vita, per rispondere al bisogno di ritrovarsi, di riscoprirsi, di ricollocarsi, dopo il disagio, così come dopo il passaggio più o meno difficile ad una nuova età , a un nuovo ruolo. La relazione d’aiuto è un’occasione di riflessione e di cambiamento dello stile di vita, del modo di intendere i rapporti, del modo di relazionarsi con gli altri, del modo di attribuire senso alla propria esistenza.
De Natale ritiene sia necessario superare la paura di cambiare:
“l’educazione, quindi, nel suo qualificarsi come diritto alla persona, mira a sottolineare e generare una tensione capace di alimentare un cambiamento esprimentesi in termini di disponibilità, di apertura, di trascendimento verso forme di vita esperenziale più ricche nell’ordine personale e verso orizzonti culturali più ampi e comprensivi, perché ogni cambiamento non sia vissuto come perdita di sé, ma come prospettiva di autopotenziamento, di affermazione, di espansione, come testimonianza della propria capacità produttiva e generativa” [75].
Il cambiamento fa realmente paura, perché può rischiare di essere associato all’idea di perdita di sé e di dimenticanza del passato. L’uomo del presente, l’uomo che nella relazione d’aiuto si proietta verso il futuro trova forza, infatti, proprio in ciò che è stato, perché è questo il suo punto di partenza: deve fare continuamente i conti con il passato, parte di sé, di cui non si può liberare facilmente. Questo è un pensiero che rassicura, ma nello stesso tempo rende difficile l’intervento, caricandolo di malinconia e del rifiuto a guardare avanti.
Aiutare a considerare la propria storia come cammino, insegnare all’educando la dinamicità intrinseca della realtà e dimostrarne gli effetti positivi è una soluzione per superare la paura del nuovo: l’educatore deve dimostrare all’educando che diverse sono le possibilità di cui egli può usufruire, solo se si fida a lasciare “ un po’ ” di ciò che era, per costruirsi “ un po’ ” in termini nuovi.Nel contesto dell’autobiografia Demetrio[76] usa il termine “frammentazione”, che è processo in base al quale l’uomo scopre di essere tanti “io”, col rischio di perdere la propria identità, il “centro di riferimento del sé ”, ma che è anche una risorsa : “…proviamo l’emozione di rinascere, perché assistiamo alla nascita di molti io che siamo stati, li seguiamo nei loro primi passi, li vediamo confondersi tra loro senza più continuità nei passaggi che hanno attraversato” [77]. Per l’autore scopriamo la varietà del nostro essere in tutto quello che siamo, ma scopriamo anche che vivendo abbiamo assimilato qualcosa dalle persone incontrate, che ci hanno accompagnato, e ci scopriamo anche nelle nostre fantasie. “Noi non soltanto un po’ tutto e tutti coloro che abbiamo effettivamente incontrato. Mille altri siamo, anche: evanescenti immagini, eroi soltanto desiderati, personaggi del cinema e della letteratura, sogni d’amore e di benessere” [78].
Non c’è motivo di impaurirsi, perché l’educando è guidato in questo “viaggio” alla scoperta di sé dall’educatore che controlla i suoi sentimenti, attua la funzione di contenimento, dosa riflessioni più profonde, forse più difficili, alternandole alla sdrammatizzazione. L’educatore insegna a cogliere la funzione, che a volte rischia di rimanere nascosta, dell’ “io tessitore che collega, intreccia; che, ricostruendo, costruisce e cerca quell’unica cosa che vale la pena cercare (…) costituita dal senso della nostra vita e della vita” [79]. L’io tessitore è quella parte interna che riprende i fili della nostra vita, che ricostituisce unità, ci rende conoscibili a noi stessi, nonostante i cambiamenti e, nello stesso tempo, ci fa trovare delle risposte su di noi e sulla vita in generale, in modo approfondito, in una riflessione non occasionale.
Si tratta di riorganizzare la vita individuale, ma non tagliando i ponti con il passato, bensì recuperando il passato e reinterpretandolo da un nuovo punto di vista. Demetrio spiega il compito dell’educazione con il concetto di tensione anagogica (a?na´gw, che in greco significa ”condurre in alto”), che è desiderio di perfezionamento, di elevazione e miglioramento conscio o inconscio negli uomini, fin dall’antichità. La tensione anagogica fa parte di quei significati più profondi che muovono il soggetto verso la relazione educativa. L’uomo è naturalmente, costitutivamente votato al cambiamento, lo cerca, anche se inizialmente e consciamente ne può avere paura, ma riconosce che dà senso all’esistenza e che l’arricchisce.
Si è parlato dell’altro, del problema teorico di andare all’altro, della disposizione sia dell’educatore che dell’educando a confrontarsi col diverso, della fatica che comporta la rinuncia al proprio egoismo e dei requisiti per intraprendere una relazione educativa: questi passaggi comportano un’innovazione, un vero e proprio “cambiamento” nella vita dell’educatore e dell’educando, perché li chiamano a mettersi in gioco.
La motivazione che spinge a mettersi in gioco e a intraprendere un cammino difficile può essere solo quella che si fonda sull’idea di ottenere un vantaggio, certamente non in termini di convenienza - il che ridurrebbe la relazione ad essere strumentale -, ma un vantaggio inteso come aiuto, apertura alla “comprensione” dell’esistenza. Non c’è, però, un “insegnante” che la spieghi, ma c’è un educatore che dispone il soggetto che intraprende la relazione d’aiuto a darsi da sé una risposta, a trovarsi da sé una strada: dapprima sarà guidato, poi sarà in grado di farlo da solo. L’educatore ripone piena fiducia nell’utente, nella sua possibilità-volontà di cambiamento e miglioramento, nella sua capacità di crescita.
Sia educatore che educando devono conoscersi, riflettere su di sé e conoscere il proprio potenziale relazionale. In questo senso Donadi[80] valorizza il “tempo dell’individualismo”, inteso come “attenzione e preservazione di sé”, funzionale a un miglior tempo sociale. Non è, infatti, nemmeno da lei concepito come esperienza della singolarità, ma ha significato sociale: è necessaria una “ricostruzione-rilettura di sé in vista della relazione con l’altro”. Bisogna quindi distinguere l’atteggiamento individualistico dalla valorizzazione della vita privata; quest’ultimo è quello che ci si auspica sia perseguito, la “cura di sé”, “lavoro su di sé” o e?pime´leia ( in greco “cura”, “sollecitudine”, “attenzione”), per arrivare all’altro.
Nel “tempo per sé” la donna per la Donadi, ma potremmo dire più in generale l’individuo, recupera lo spazio necessario per rileggere il quotidiano, per lasciare da parte almeno per un momento l’agire, che ha spazio privilegiato nella vita di oggi, per il pensare. Diversi sono i significati di “tempo per sé”, riassunti dalla Donadi in questo modo:
- lavoro di intelligenza e attribuzione di significati agli eventi quotidiani;
- riappropriazione del rapporto con l’altro;
- tempo di attenzione al corpo;
- tempo per l’ozio.
E’ un modo per conoscersi, per attribuire senso alla propria vita, soprattutto in seguito ad avvenimenti destabilizzanti per l’io. E’ “spazio intrapsichico, luogo di autoriconoscimento, ripiegamento su di sé necessario all’uomo e alla donna per la costruzione di un identità autonoma adulta, (…) ma non è rappresentazione di sé indipendentemente dall’altro”: alla fine del percorso personale, è importante riconoscersi soggetto sociale. Il “tempo per sé” è, infatti, premessa, non negazione del percorso rivolto all’esterno, tenendo presente che solo riconoscendosi interiormente l’uomo può in seguito riconoscersi nella relazione.
Così nella relazione d’aiuto l’educatore conoscendo le carenze, i bisogni, le capacità dell’utente prospetta una crescita; conoscendo le proprie abilità, le competenze, i saperi scientifici, le attitudini può farvi affidamento per creare le migliori condizioni per una relazione di fiducia e per far progredire il soggetto che chiede aiuto. Tutto questo è presa di coscienza - magari proprio nel tempo per sé - per volgersi a un cambiamento ponderato e ricercato.
Viene valorizzato da Demetrio[81] un altro aspetto del cambiamento, dimenticato o non addirittura contemplato. Egli afferma che l’ “educazione è intenzionalmente volta a generare cambiamenti” , è “esigenza di cambiamento”, ma puntualizza di preferire il termine “apprendimento” al termine “cambiamento” per un motivo preciso, illuminante nel nostro campo dell’educazione: educare è imparare qualcosa che ci cambia in meglio, ma è necessario contemplare anche la possibilità di cambiamenti degenerativi. Generalmente, infatti, non si contempla il disimparare, il non mutare, il rifiutarsi di apprendere che sono valutati come “mali” di cui in educazione non c’è, né ci dovrebbe essere traccia alcuna. L’esperienza negativa, però, afferma Demetrio, consente anche di far emergere qualche interrogativo in più: hegelianamente il negativo acquisisce un senso costruttivo.
Riscoprire sbagli del passato o riflettere su quelli del presente, sono entrambe aspetti che fanno parte della vita: l’uomo purtroppo non è esente dall’errore, dal disimparare, dall’imparare male, dallo sbaglio, ma proprio grazie a queste “non qualità” può emergere il suo desiderio di fare meglio, può essere spronato a impegnarsi di più, a rifletter più approfonditamente sul motivo dello sbaglio, cogliendone, infine, il suo significato “pedagogico”. Interrogarsi, occuparsi del senso profondo del vivere, arricchirsi, rinnovarsi, rigenerarsi: questa è l’educazione per Demetrio, il cui obiettivo è ottenere una struttura di vita soddisfacente, che permetta autorinnovamento, espressione del sé, distacco perché possiamo ironizzare su noi stessi, sugli errori, confidando, nello stesso tempo, sulle capacità. Questo è cambiamento, che contempla errore e correttezza, che valorizza il potenziale di ogni individuo e che può nascere proprio dalle esperienze difficili della vita, dalle quali traiamo spunto per comprenderci meglio e comprenderne di più il senso, ritrovandoci poi fiduciosi di poter continuare il nostro “viaggio”
2.1.1 Alcune relazioni d’aiuto
Miodini - Zini[82] indicano alcuni soggetti con i quali intraprendere la relazione d’aiuto.
Sulla traccia da loro fornita, focalizzo l’attenzione su come si interviene nei loro confronti e a quali competenze pedagogiche e, da supporto a queste, a quali competenze relative in generale alle scienze dell’educazione si può fare riferimento.
L’educatore si dispone ad aiutare[83]:
1. i minori in condizioni di disagio psico-sociale.
Sono stati abbandonati dalla famiglia, hanno vissuto in modo partecipato alcuni eventi difficili o, nel corso della socializzazione primaria, hanno introiettato delle regole comportamentali che non corrispondono a quelle condivise dalla società. Manifestano difficoltà nell’inserimento sociale.
L’operatore deve disporsi a conoscere gli eventi critici che hanno segnato il minore e, successivamente, intervenire anche nel suo contesto familiare di provenienza.
Santerini[84] mette in evidenza come in ogni intervento educativo non si possa prescindere dall’attenzione nei confronti dell’ambiente, nel quale l’individuo si muove, che è “parte integrante del sistema della vita”. Lo dimostra affermando che c’è una stretta “interdipendenza tra la dimensione della personalità individuale – nelle sue componenti cognitive, motivazionali (…) - e gli aspetti socioculturali”. Per ambiente si intende, in generale, il contesto nel quale l’individuo è inserito, ma, in particolare, anche le stesse relazioni tra individui. Gli scambi, infatti, sono fondamentali per capire in che termini si siano sviluppati i processi di apprendimento e di formazione primaria.
L’educatore deve fare attenzione alla contestualizzazione dell’azione, valutando il senso che l’utente ne dà anche in rapporto agli insegnamenti che ha ricevuto e all’elaborazione di questi ultimi. L’approccio educativo non si cala dall’alto, non è standardizzato, valido per chiunque, ma deve tener conto delle particolarità, dell’unicità della combinazione soggetto – azione - contesto.
Soprattutto se l’utente è giovane e non ha maturato ancora la capacità di far fronte agli eventi, l’educatore deve aiutarlo nel “contenimento”, facendo da filtro nelle sue relazioni con l’esterno. Agendo secondo questa prospettiva, si sottolinei che la funzione dell’educatore non è sostituire i genitori, ma aiutare anche loro ad “accompagnare” il figlio, permettendogli di non sovraccaricarsi di difficoltà e di vivere la sua età, come gli spetta.
Si cerca di leggere il contesto e di attuare il tentativo di coinvolgimento non solo per questo intervento, ma per ognuno di quelli elencati che riguardano, in special modo, i minori.
Le competenze richieste sono animative e psico-relazionali.
2. i minori portatori di handicap psico-fisici.
In linea con quanto precedentemente affermato sull’importanza del “contesto” attorno all’educando, è ancora necessario ricordare che non solo i soggetti handicappati devono essere al centro dell’intervento, ma anche le persone che stanno a loro più vicino: i genitori, in particolare, devono poter essere aiutati ad agire per il bene del figlio e a rapportarsi a lui favorendo la sua espressione di sé, il dialogo e la sua autonomia.
In quest’ottica si capisce bene che anche i genitori necessitano di sostegno per poter imparare ad acquisire un stile di comportamento che non li porti a sostituirsi al figlio, non permettendogli di crescere né di essere progressivamente sempre più adulto nell’espressione della sua libertà. E’ rischiosa la nascita di un rapporto simbiotico, attraverso il quale i genitori possono avere l’impressione di fornire un supporto, mentre in realtà bloccano il figlio nello sviluppo dell’autostima e dell’istinto di scoperta , necessari per ogni essere vivente. E’importante, invece, insegnare al soggetto handicappato a essere autonomo, a decidere. Tali conquiste non escludono il legame familiare.
A questo scopo sono previsti dei veri e propri corsi per genitori, parent education o parent training[85], i primi più specifici, i secondi più generali. Nell’ottica dell’educazione permanente si cerca il coinvolgimento parentale “per migliorare la relazione con i figli; sviluppare la capacità di analizzare i problemi educativi; far conoscere lo sviluppo del figlio, nelle sue potenzialità e limiti; diffondere metodi educativi più efficaci; rendere la vita familiare più piacevole”[86]. I contenuti degli incontri sono rappresentati dall’insegnamento dei principi educativi di base, di tecniche educative, ma anche da discussioni su difficoltà-successi-insucessi e “compiti per casa” per rafforzare le conoscenze apprese.
Le competenze richieste all’educatore sono di riabilitazione fisioterapica ed educativa. Quest’ultima non solo, come si è detto, è funzionale alla valorizzazione delle capacità del minore, ma anche a fare in modo che le persone che gli stanno attorno imparino a relazionarsi con lui nel modo più appropriato, per il suo bene.
3. gli adolescenti a rischio.
L’adolescenza è per eccellenza il periodo “critico”, delle “ambivalenze”, in cui il giovane sente il desiderio di rendersi autonomo dalla famiglia. Il passaggio all’autonomia è possibile e non avverrà in modo disfunzionale solo se nel ragazzo permane il sentimento di appartenenza alla famiglia, se la famiglia è stata fino ad allora presente e se è disponibile ad accompagnarlo nelle sue difficoltà, da lontano, evitando di “dirigere” tutte le sue scelte.
In alcuni casi, se per esempio si sono manifestati comportamenti a rischio come tossicodipendenze, malattie mentali, delinquenza, sarà importante il sostegno medico, ma è anche ineliminabile quello psico-sociale. All’educatore sono richieste competenze educative, psico-relazionali, relative alle tecniche di conduzione di gruppi e alla creazione di stimoli
4. gli adulti con difficoltà psico-sociali e fisiche. Ci si riferisce a malati di mente, devianti, alcolisti.
L’educatore deve supportarli nell’affrontare le difficoltà, l’insicurezza, che non caratterizzano solo il giovane nel percorso della sua crescita, come precedentemente affermato, ma anche il percorso dell’uomo in età avanzata, che dimostra pari bisogno e diritto di aiuto. Assieme all’educatore si fanno dei passi verso una vera e propria risocializzazione, che conduce il soggetto a ri-ottenere l’autonomia e il reinserimento nel lavoro e nella vita sociale.
Le competenze richieste sono animative, riabilitative.
Tramma[87] rende completo questo modo di vedere l’adulto, proponendo una diversa chiave di lettura: attribuisce anche all’adulto la possibilità e opportunità di essere educabile e di essere utente di interventi migliorativi, non solo nell’ottica dell’educazione riabilitativa o “democratico emancipativa”, ma anche nell’educazione come “ricerca del benessere” e come “pratica del cambiamento”.
Sempre più ci si auspica che dopo il 1900 - secolo del bambino, al quale è stata data la possibilità di vivere a tutti gli effetti la sua età -, il XX sia il secolo dell’adulto, al quale attribuire concretamente la facoltà di essere educabile.
La vita è, dice Tramma, “laboratorio di formazione” soprattutto oggi che si parla di “sgretolamento dell’adulto” non più, come un tempo, finalmente giunto alla meta e alla conclusione dello sviluppo. L’educazione al cambiamento si occupa di insegnare all’individuo a gestirsi nell’ambito professionale sempre più mutevole, sempre più dipendente dall’evoluzione tecnologica, bisognoso di nuove figure professionali che si rinnovano continuamente; a trovare nuove motivazioni, una volta compiuto il passaggio al pensionamento; a fronteggiare gli eventi spiacevoli che “cambiano” l’esistenza e che richiedono una riscoperta del senso, come la morte delle persone care con le quali si è condivisa una vita; a scoprire parti subordinate del sé, a conoscersi, trovare occasioni per esprimersi, conoscere meglio il mondo, sviluppare il desiderio di essere utili, di socializzazione, di crescita personale, culturale e di coltivare, in questo senso, il tempo libero.
Bauman[88] afferma che l’individuo non è più paragonabile alla figura del pellegrino - che lo caratterizzava nell’epoca moderna - , il cui camminare era “orientato di senso” e corrispondeva al cammino di costruzione della propria identità, senza temere ostacoli repentini. Oggi il problema è mantenere l’identità, in un tempo non più lineare, ma caratterizzato da discontinuità e paragonato da Bauman ad un insieme di pozzanghere, non più ad un fiume. Quattro sono le figure che designano l’uomo contemporaneo:
- flaneur, bighellone, senza meta, estraneo fra gli estranei, si fa sedurre dalle proposte che incontra;
- vagabondo, non radicato in nessun luogo;
- turista, ha una casa di cui ha bisogno, ma dalla quale necessita di staccarsi, per fare nuove esperienze;
- giocatore, rischia con la fortuna e con la vita stessa, guidato dalle proprie abilità.
L’adulto non può adagiarsi una volta raggiunta questa età, ma deve continuamente mettersi in gioco, continuamente cercare una nuova strada di realizzazione di sé, perché lo richiede il mondo, perché è lui stesso cambiato, rispetto all’uomo del passato, e necessita/ desidera stare al passo con i tempi.
5. gli anziani.
Nella nostra epoca del disorientamento, l’adultità non è più considerata come momento apicale dell’esistenza al quale riferire tutte le altre età, meta e conclusione della crescita: acquistano valore e significato autonomo tutte le età della vita, anche la vecchiaia, in cui non solo si è scoperta le persistenza di molti tratti di adultità, ma a cui è attribuita possibilità di sviluppo. Anziano non è colui che si avvia verso il “deterioramento fisico”, ma una persona che può ancora evolvere: cambia l’immagine di vecchiaia, si riconosce un’ “eterocronia” anche nella decadenza.
Sottolinea Tramma che è necessario superare l’associazione invecchiamento-incapacità fisica e riconoscere che il tempo dell’anziano non è, né deve essere “tempo vuoto”, di attesa. Si valorizza il bisogno relazionale dell’anziano, di avere informazioni sul mondo e di essere ancora immerso nel mondo, di educabilità, di interessi. Non bisogna abbandonare l’idea secondo la quale l’uomo, fino alla fine della sua vita, è tale in virtù della sua dignità, della sua liberà, delle sue passioni, del suo amore per la vita stessa: tutte queste componenti umane permangono sempre, non sono una prerogativa dell’età giovane.
La vecchiaia è anche l’età del bilancio, il periodo in cui l’uomo fa i conti con il precedente vissuto. La sua speranza, la sua serenità dipendono molto dal modo con cui guarda e interpreta le età precedenti. E’ pericoloso che l’anziano sia lasciato solo e non sia considerato come portatore di saggezza e della ricchezza della vita. L’educazione della terza età e dell’autobiografia, come modalità di recupero della vita vissuta, trovano il loro senso nel desiderio, a volte espresso e altre nascosto, dell’individuo di lasciare un segno e di non dimenticare il proprio passato.
Erikson rende ragione di quanto la “tarda età adulta”[89] sia delicata e di quanto, quindi, meriti grande attenzione. Egli la definisce con due termini opposti: integrità o disperazione. Secondo questo autore la vecchiaia è il periodo della vita in cui si effettua il bilancio di ciò che è avvenuto e di ciò che si è stati. La sensazione di avere avuto un “posto” nel mondo, di aver raggiunto degli obiettivi consoni alle proprie capacità e ai propri interessi, la sensazione di aver “fatto” qualcosa, di aver potuto lasciare un segno a qualcuno che porti con sé il proprio ricordo consolida l’integrità dell’io e fa accettare il declino nella serenità, nella consapevolezza di aver saputo/potuto realizzare un progetto positivo. In mancanza di una tale percezione è facile che prenda piede la disperazione, dovuta all’autovalutazione negativa e alla constatazione che non è più possibile recuperare quanto si è perduto.
E’ giusto che l’educazione prenda posizione e si adoperi per garantire serenità anche alle persone che hanno perso speranza e certezza, per permettere loro una rielaborazione in senso positivo della loro esistenza. Tramma[90] afferma, infatti, che se c’è un termine dell’educazione, questo è rappresentato solo dalla morte. L’educazione, infatti, è “incoraggiamento, sostegno”, rivendicazione della centralità dell’uomo, ed è “stimolo per continuare a vivere”.
Per approfondire l’idea di costruzione di sé, mi riferisco in particolare a due età chiave della vita: l’infanzia e l’adultità. Le considerazioni di fondo portano ad un’unica base di riflessione, funzionale alla scoperta di come l’uomo si sviluppi, di quali siano i suoi “bisogni”, in riferimento a come gli studiosi considerano e hanno considerato queste due fasi di cambiamento.
L’infanzia è la fase della vita nella quale l’individuo compie i primi passi nel mondo ed è interessante osservare come sia stato considerato chiave in base alla quale interpretare tutto il resto dell’esistenza. Freud è lo studioso dell’infanzia per eccellenza, non certamente nel senso che è stato lui a sviluppare il più completo studio su questo periodo, ma perché l’ha investita di un ruolo determinante, affermando che con essa sempre si sarebbero dovuti fare i conti: in base a com’è stata vissuta, la personalità si sviluppa in un modo preciso e predeterminato, tanto che nemmeno una volta adulto l’uomo ne è indipendente. In un’epoca in cui si cominciava a parlare di infanzia, Freud (1856-1939) la considera determinante nello stabilire i termini nei quali il futuro adulto si sarebbe sviluppato e avrebbe affrontato la propria vita. E’ l’età nella quale si stabiliscono le “fondamenta” dell’intera esistenza, è per eccellenza “tempo di formazione” , unico momento in cui l’individuo si gioca il proprio destino. Nel modello dello sviluppo psicosessuale, l’analisi si conclude con i 18-20 anni, dopo i quali sembra non esserci “sviluppo” e che tutte le possibilità per l’individuo siano già state “giocate”: l’individuo attraversa lo stadio orale (dalla nascita ai 18 mesi circa), lo stadio anale (dai 18 mesi ai 3 anni circa), lo stadio fallico ( dai 3 ai 5 anni circa), lo stadio di latenza ( dai 5 ai 12 anni) e genitale ( dai 12 anni ai 18-20).
Tramma colloca questo modello fra le “concezioni stadiali”, caratterizzate per il fatto di concepire la vita secondo fasi evoluzionistiche, una succedente schematicamente all’altra secondo una visione aprioristica.
Anche il modello dello sviluppo psicosociale di Erikson è collocato nella stessa classe di concezioni da Tramma, ma Erikson, rispetto a Freud, ha sviluppato un nuovo elemento di riflessione, attribuendo a tutte le età della vita possibilità di sviluppo. C’è un rischio sotteso a entrambi questi modelli: dimenticare il ruolo attivo dell’individuo, vederlo come risultato delle interferenze dell’ambiente.
E’ molto più complessa, infatti, la vita dell’individuo, difficile da essere incasellata in modelli, per la sua imprevedibilità e inesauribile ricchezza: l’azione dell’uomo non può essere ridotta a risposta a stimoli, non si può dire che a precise cause seguano gli stessi determinati effetti. Ognuno di noi, in base alla propria sensibilità, alla background storico, alla cultura e al tempo in cui vive, all’educazione che gli è stata impartita, vede gli eventi con occhi diversi. Nel corso della vita di ognuno, queste variabili possono anche cambiare e determinare una “rivoluzione” del modo in cui si vede la realtà.
Secondo il paradigma interpretativista[91], nato come reazione al positivismo, la realtà è inafferrabile proprio per questo motivo: non è costituita da “fatti oggettivi”, coglibili attraverso strumenti scientifici, oggettivabili, che si fondano sulla base di regole precise e costanti. Al contrario, è come ognuno la vede. Ne possiamo ottenere delle interpretazioni, che combinate assieme ci aiutano a costruire un quadro ricco, ma mai completo: non otterremo mai una fotografia che la rispecchi nella sua complessità.
Rende ragione di questa complessità, secondo Tramma, la “concezione non stadiale”, per la quale l’esperienza individuale è un tragitto in cui lo sviluppo non è teleologicamente orientato, né prevedibile deterministicamente in sequenze progressive.
Per Tramma considerare un paradigma all’interno di una delle due concezioni non ha una funzione classificatoria, ma chiarisce il significato dell’educazione: per la concezione stadiale la funzione dell’educazione è favorire il passaggio da uno stadio all’altro, per la concezione non stadiale l’educazione è invece occasione anche quando non è prevista e per lei c’è sempre posto e possibilità di arricchire l’uomo.
L’altra età della vita che ho scelto per approfondire la riflessione sullo sviluppo è l’adultità. A questo proposito Demetrio[92] fornisce una chiave interpretativa del perché gli adulti siano portati ad apprendere, chiarendo, nella mappa euristica, la funzione dell’apprendimento, che è:
- condizionamento
nel processo di apprendimento l’uomo sceglie il proprio percorso educativo, in base agli stimoli che riceve. Oltre ai fattori positivi, deve anche fare i conti con quelli inibenti, eventi o vissuti delle precedenti fasi della vita che tendono a dissuaderlo dalla curiosità di apprendere.
L’educazione possibilmente deve intervenire in modo tale da favorire il desiderio di conoscere, attraverso occasioni, l’organizzazione di eventi, coltivando gli incentivi individuali; deve fare in modo che gli individui imparino a vedere i condizionamenti non come impedimento, ma come risorsa e occasione di autoriflessione.
- cambiamento
è indispensabile strumento di valutazione e caratterizzazione ineliminabile del processo educativo. Non solo in educazione, ma anche nella vita, ogni esperienza ha una valenza pedagogica quando è apportatrice di mutamenti, non letti in chiave fatalista.
- comunicazione
è ciò che un soggetto riesce a ridare di quanto ha appreso, dimostrando se e come si è imparato. Generalmente una volta vissuta un’esperienza esistenziale tanto significativa da rivelarsi apprenditiva, si sente il bisogno di farne partecipi gli altri [93].
Due sono gli aspetti rilevanti che sono stati messi in evidenza, nell’approfondimento sul tema dello sviluppo, in riferimento all’infanzia e all’adultità:
il ruolo attivo, partecipativo dell’individuo, protagonista a tutti gli effetti della sua esistenza e inevitabilmente votato ad esserlo anche nella costruzione del suo processo di sviluppo;
dall’altra parte ancora si valorizza il ruolo significativo che l’Altro ricopre nello sviluppo, nelle esperienze che l’individuo vive e, non da ultimo, nell’aiuto: anche l’educatore che si dispone a rendere l’educando soggetto attivo e in relazione costruttiva con gli altri è a sua volta “altro che aiuta”, determinante esterna che interviene sul soggetto e a cui sarà, in ogni caso, il soggetto stesso a darvi significato.
Il processo di significazione è nelle mani dell’utente, ma l’educatore deve avviare l’educando a svilupparlo e fare in modo che egli se ne serva.
Ampliando il presente contributo, vengono di seguito approfonditi, nello specifico, tre tipi di relazione d’aiuto: con gli adolescenti, gli immigrati e i malati terminali.
Relazione d’aiuto con gli adolescenti
Nella carrellata appena presentata da Miodini - Zini sulle relazioni d’aiuto è già stato spiegato il caso dell’adolescenza. Quello che ci si propone di fare ora è entrare nel merito dell’argomento, ampliando la visuale oltre ai casi d’emergenza, riflettendo sull’attenzione che “costitutivamente” tale età merita.
L’adolescenza è un’età di mezzo fra l’infanzia e l’adultità. Non si caratterizza tanto per il cambiamento, perché la recente lettura proposta dall’Educazione degli adulti lo considera elemento tipico dell’intero corso della vita. Piuttosto l’adolescenza sarebbe caratterizzata dall’esigenza di riorganizzare se stessi.
La crisi nasce, in quest’età, a causa dello sviluppo fisico che determina ripercussioni anche a livello mentale. Non è l’unica nell’esistenza, ma si potrebbe considerare come la prima vissuta a livello cosciente: mentre nell’età precedente, quella della fanciullezza, il bambino non capisce i propri cambiamenti, li capisce l’adulto che intraprende la strada verso la vecchiaia. L’adolescenza apre l’Uomo verso i primi problemi dell’esistenza, i quali dovranno da lui essere affrontati – con fatica e a volte anche contro il suo volere, ma con la sua possibilità acquisita di farvi fronte – , da questo momento, per sempre.
Questo periodo della vita viene distinto da Inghilleri[94], nonostante il disaccordo di alcuni studiosi, in tre fasi: la preadolescenza, in cui non si verificano grosse rotture; l’adolescenza vera e propria che è un prolungamento della preadolescenza, è momento di avvio verso la prima età adulta, caratterizzata da condizionamenti sociali e dall’adesione al gruppo; l’adolescenza protratta, sempre più presente nella nostra società nel fenomeno della “famiglia lunga”, a causa del prolungamento degli studi, dalla posticipazione dell’assunzione di responsabilità.
De Natale[95], trattando il tema della devianza minorile, giunge a tratteggiare l’immagine di una società carente, responsabile della determinazione dei comportamenti devianti. Questi ultimi sarebbero indicatori di un disagio esistenziale espresso dai ragazzi delinquenti, ma proprio dell’intera area giovanile. L’aiuto, compito della pedagogia, dovrebbe essere rappresentato dal sostegno nei confronti del soggetti, per fare in modo si percepiscano persone libere, perché imparino ad agire con autonomia morale e motivazione intrinseca[96]:
“E con molta incisività G.Vico ha precisato che l’iter evolutivo è sempre lo stesso: disagio-disadattamento, devianza, in una crescente e lineare evoluzione che ci interpella tutti. Questo percorso può essere interrotto, infatti, solo se si incentra l’attenzione sull’uomo, sulla persona, e sul rispetto della sua dignità e della sua capacità di libertà responsabile in un preciso orizzonte di valori” [97].
L’adolescente è “essere in cammino”. Non deve essere lasciato solo, sia perché deve percorrere una strada, a volte difficoltosa, sia perché non sarà forse subito capace di gestire una libertà appena maturata.
Gli orientamenti cui ha fatto appello De Natale per spiegare la devianza dell’adolescente sono:
- psicoanalitico: studia l’evoluzione psicosessuale dei soggetti.
L’adolescenza sarebbe età fragile, per l’irrompere delle forze istintuali, in una fase della vita in cui l’Io non è ancora sufficientemente strutturato. L’adolescente svilupperebbe comportamenti devianti per la sua costitutiva inidoneità a dominare conflitti e crisi;
- sociale: studia il rapporto fra giovani e società, analizzandone gli ostacoli.
I giovani non hanno ancora la possibilità di inserirsi nella società, né di decidere. Trovandosi in una situazione di deresponsabilizzazione hanno difficoltà ad accumulare sicurezza sul proprio valore e sulle proprie competenze. In questo senso è importante che il soggetto si riconosca nel gruppo dei pari, con i quali condivide la propria situazione e con i quali, soprattutto, può esprimersi;
- cognitivo: studia lo svilupparsi dell’adolescenza come scambio fra pensiero e ambiente.
Il fatto che gli adolescenti dedichino attenzione alla propria interiorità non deve far parlare di “egocentrismo intellettuale”: è questa una fase delicata, in cui il soggetto ha bisogno di “cercarsi” e di cercare soprattutto un equilibrio fra la propria interiorità e l’esteriorità per acquisire la capacità di adattarsi alla realtà.
De Natale, facendo ricorso a questi tre modelli, cerca di focalizzare l’attenzione su tre aree problematiche che riguardano da vicino i giovani.
L’adolescenza è per eccellenza età della ricerca: anche se questa è un’attitudine che l’uomo manifesta per tutto il corso della vita, si può dire che l’adolescente sia l’uomo che comincia a cercare. Egli è alla ricerca di un’identità propria - diversa da quella richiesta dalla famiglia e, forse, da questa imposta -, del rapporto con i coetanei, di sé, per realizzare una stabilità che gli garantisca continua sicurezza.
Sono significativi i titoli di due lavori sull’adolescenza, uno di Cospers e uno di Crepet, rispettivamente “L’età incompiuta” e “Non siamo capaci di ascoltarli”: sollecitano ad avviare una riflessione ragionata e profonda sui bisogni dei giovani e, nello stesso tempo, sui compiti educativi degli adulti.
Per esempio, si può ipotizzare che alla base della trasgressione che la devianza comporta, ci sia un senso di “noia”, la sensazione di vivere una vita senza senso. Per superare le difficoltà adolescenziali, l’educatore deve orientare l’intervento verso la centralità della persona, presupponendo l’idea dell’adolescenza come “età ricca” e convincendone l’educando. All’educatore spetta il compito di dimostrare – aspetto che è fondante della retrospezione – il valore formativo delle difficoltà, la gratificazione del loro superamento, la soddisfazione di ricomporre la propria vita in modo proficuo per la crescita personale. Proprio Crepet esplicita il valore del “negativo”, anche già nella prima adolescenza:
“ Il dolore diventi materia pedagogica, grammatica quotidiana: le mamme e i papà – ma anche gli insegnanti e gli educatori – non temano di parlare di un evento luttuoso con i propri piccoli, non insegnino che nella vita bisogna prevenire ogni frustrazione. E’ importante prendere qualche brutto voto a scuola, riuscire a far fronte a una disillusione amorosa, essere in grado di reagire a un’ingiustizia patita. Il bimbo impara così a conoscere i propri limiti, a misurarsi con la delusione, a familiarizzare con il proprio meraviglioso meccanismo psicologico.
(…) La paura riunisce le persone.
(…) Per sentire di esistere ognuno cerca anche la propria tragicità ” [98].
Nella relazione d’aiuto si devono decodificare e leggere i nuovi bisogni, dimostrandone la possibilità di soddisfazione e aiutando in questo intento. Nessun educando sarà perfettamente in grado di elaborare da sé i propri insuccessi della vita, ma lo potrà fare con successo, nell’accompagnamento. Crepet invita anche a riflettere, dal lato opposto, a non chiedere troppo ai giovani, per esempio, non affidando al rendimento scolastico la valutazione complessiva della persona, non insegnando ad emergere a tutti i costi.
Egli denuncia preoccupazione seria nei confronti degli adolescenti e la necessità che si senta un senso di responsabilità nei loro confronti da parte della società tutta, da parte delle generazioni precedenti che si devono occupare di far trovare loro un posto nella vita e di dare libera espressione alla loro personalità, alla loro creatività:
“ Non è poi passato tanto tempo dalle notti in cui i ragazzi lanciavano pietre dai cavalcavia delle autostrade. Anche allora polemiche e cattiva coscienza sono durate il tempo di un telegiornale. Anche allora definizioni, ipocriti palpiti nei confronti di generazioni “che non sanno più distinguere tra bene e male…che non sanno più cosa sono i valori”. E quando il teatrino del dolore collettivo si chiude, cosa succede? La nostra comunità sa davvero cogliere il senso dei comportamenti di quei giovani delinquenti, riesce a capire che quelli altro non sono che metafore, ovvero segnali che potenzialmente riguardano migliaia di loro coetanei? ” [99].
Il suo tono provocatorio è un modo per attirare l’attenzione nei confronti di un problema che seppur emerso, non è abbastanza seriamente affrontato. Con troppa facilità si incolpa, senza saper di seguito costruire un percorso di aiuto, di espressione, di lavoro sui valori, di non abbandono.
“ …una ragazza mi fa leggere un questionario elaborato con un gruppo di amici e sottoposto ai compagni di scuola. Le domande vertono sulla loro vita: aspettative, speranze, progetti. Sfogliando le pagine di quell’inventario noto che non compare mai una parola: felicità. Chiedo spiegazioni alla ragazza: se ne sono accorti anche loro, ma trovano quel termine “imbarazzante”.
Questo imbarazzo nasconde una prematura paura di vivere? La nostra cultura fatica a incontrare la felicità e sono soprattutto gli adulti imbarazzati a parlarne con i giovani. Siamo ancora vincolati dalla paura atavica della precarietà che ha accompagnato l’esistenza dei nostri predecessori. Secoli di cristianesimo pauperista ci hanno insegnato a vivere le gioie come dovessimo solo temerle, aver paura di incontrarle, quasi arresi all’obiettivo della mera sopravvivenza. Per Sigmund Freud
Il prezzo del progresso della civiltà si è pagato con una crescente riduzione della felicità dovuta all’intensificarsi del senso di colpa…l’uomo ha sempre maldestramente barattato la felicità con la sicurezza.
(…) conquistato il necessario abbiamo preferito l’accumulare – oggetti, denaro, cose: la nostra identità? – al comunicare, al sentire “ [100].
Questa citazione rende esplicita una questione dimenticata, su cui si è abituati a passare sopra nella vita quotidiana, ma che deve essere argomento primo di riflessione nel colloquio di aiuto. Il compito dell’educatore è quello di esplicitare le problematiche, di creare con l’educando un campo di confidenza, di liberazione dagli imbarazzi, in cui – come propone Crepet - si possa facilmente parlare di felicità e proiettarsi verso la sua realizzazione.
Spesso, nel testo della Caritas, “Ragazzi al margine”[101], nella carrellata di alcuni interventi che sono stati attuati dal ’91 in Italia, si usa questa terminologia: “dare un’alternativa”. In questo si gioca l’aiuto, nella dimostrazione, anche concreta, di poter mirare ad una vita migliore, nell’insegnamento delle possibilità personali e che il contesto può offrire. La relazione d’aiuto abbraccia diversi campi di intervento concreto, per “tirare fuori” i ragazzi dalla vita di strada, ma non è detto debba affrontare solamente questioni d’emergenza e di gravità primaria. Si affrontano anche questioni relative all’interiorità, per avviare il ragazzo alla conoscenza di sé.Crepet di fronte all’analisi della condizione adolescenziale propone una soluzione: l’ascolto. L’ascolto è comprensione delle esigenze, dei bisogni, delle “assenze” che i giovani vorrebbero veder colmate, fra cui la materialità non occupa certo il primo posto, ma lo occupano le assenze relazionali. Questo atteggiamento dovrebbe essere acquisito da tutti coloro che hanno il ruolo di educatori e tutti loro dovrebbero poter instaurare una relazione d’aiuto con i giovani. La relazione d’aiuto non esiste solo a livello professionale, ma è anche sinonimo di “ascolto autentico”, di “profondità”, di “acquisizione del coraggio di parlare”, di “dimenticanza degli impegni”, trovando tempo per “costruire un noi”, fra genitori e figli per esempio.
Guerra mette in luce un importante ambito di responsabilità degli educatori:
“ Le ricerche come “generazione della vita quotidiana” individuano la defuturizzazione come criterio interpretativo di una condizione giovanile alla quale non sembra più tanto mancare il “passato”, quanto il “futuro”. (…) Il problema centrale diventa quello di restituire a questi giovani una capacità di regia fondata su nuove motivazioni e competenze.Le generazioni del passato erano fortemente orientate al futuro: la loro vita quotidiana era fatta di macrodesideri ( al maschile: da bambini, il capostazione; da giovani, la rivoluzione) e di microconsumi: mancavano i soldi. La generazione del presente sperimenta quotidianamente il macroconsumo ( ci sono soldi per l’alimentazione, l’abbigliamento, il tempo libero e via dicendo) ma vive una forzata realtà di microdesideri…” [102].
Guerra afferma la necessità di un modello educativo che sappia orientare di senso i giovani, che sappia fornire - e aiutare i giovani stessi a fornirsi - motivazione, progetti per imparare a guardare il proprio futuro, per essere curiosi di viverlo, entusiasti di immaginarlo e costruirlo.
Relazione d’aiuto con gli immigratiDesinan[103] ritiene necessario fondare una pedagogia transculturale. Il presupposto per affrontare questo discorso è considerare che l’immigrazione non sia un disturbo. Citando De Rita, considera il problema “padroneggiabile”: non bisogna avere “paura dell’invasione”, ma potrebbe essercene ragione qualora non si riuscisse ad assicurare servizi adeguati.
Per la necessità di presentarsi preparati, in primo luogo, dal punto di vista assistenziale, la presente riflessione sull’aiuto nei confronti degli immigrati tiene inizialmente conto del contributo di Cecchini e Bodogna[104] che attribuiscono alla questione sanitaria importanza preminente: considerano la dimensione fisica strettamente intrecciatacon quella psichica e che il campo sanitario è il primo ambito di incontro tra gli stranieri e la cultura autoctona, cui si rivolgono per esplicitare le loro necessità, prima di tutto di benessere. Si tenterà, in seguito, di ampliare l’idea di aiuto, andando oltre l’assistenza primaria, comprendendo in termini più specifici l’orizzonte educativo.
“ Per le tecniche transculturali possiamo contare su di una nostra memorizzazione dei fatti culturali, del nostro luogo di nascita, della nostra famiglia, del nostro muoverci nel sociale, delle nostre emozioni e sofferenze per perdite e ritrovamenti ( che lo rendono irriconoscibile) di un territorio fisico e mentale che era stato culturalmente nostro ” [105].
“ La stessa storia dell’immigrazione italiana in Belgio, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada, Australia dovrebbe darci esempi e testimonianze concrete del disagio legato all’immigrazione e delle scarse forme di sostegno messe in atto dagli Stati.
Sulla base di questi documenti storici non si dovrebbe esitare ad impegnarci per modificare strategie, inventarne di nuove che l’elaborazione scientifica può suggerire ed alla fine mostrare più interesse verso le masse di forza-lavoro straniere “ [106].
Gli obiettivi dell’intervento nei confronti degli stranieri, così come si ricavano dalla lettura del testo di Cecchini – Bodogna, possono essere riassunti in due considerazioni che nascondono un unico intento: non approdare a livelli di successo dovendo per forza passare attraverso le sofferenze degli utenti; non far passare anche gli stranieri che arrivano in Italia attraverso le esperienze di sofferenza che gli Italiani hanno a loro tempo affrontato, ma fare in modo che la nostra esperienza possa garantire miglioramento.
La modalità di aiuto proposte partono dall’approccio medico-sanitario di tipo assistenziale, per poi andarvi oltre. E’ chiaramente importante garantire il funzionamento del sistema socio-sanitario cui gli stranieri si rivolgono, soprattutto per conquistare la loro fiducia, per dimostrare attenzione nei loro confronti.
Il passo ulteriore, proponendosi sempre l’obiettivo di cercare di instaurare una relazione sulle più solide basi, è la conoscenza dei “modi di essere” delle persone immigrate, espressioni della loro cultura di riferimento. Dal momento in cui si considera la cultura come “disposizione ad affrontare la realtà”, si capisce che la persona non può mai esserne privata, perché per lei è appiglio, punto di riferimento di base, sicurezza a partire da cui muoversi verso nuove conoscenze e nuove culture.
La presa in carico deve tenere conto del senso clinico, dello stato psicologico del soggetto, deve partire dalla consapevolezza che gli individui sono “culturotipi”, vale a dire portatori di una propria cultura sulla base della quale si sono formati e che è strumento di lettura della realtà. Mettere a proprio agio l’utente è modo per entrare in dialogo con lui, occasione anche di miglioramento e apertura dei propri orizzonti:“ La quotidianità del lavoro medico e sociale spesso frustrante ( sindrome di burn out ) viene resa molto più interessante dall’ascolto di “cose nuove” che l’incontro di una nuova cultura narra e che produce riflessione, nuove prospettive di intervento e soprattutto, come indica A.Kleinmann ( 1990 ), trasforma la sofferenza da soggettività isolata a intersoggettività dinamica tra operatore socio-sanitario ed utente.
(…) L’apprendimento attraverso l’interazione con le valenze soggettive della persona è la grande forza dell’uomo “ [107].
A coloro che operano nel campo delle scienze umane è richiesto di “mobilitarsi” per contribuire a costruire una società multiculturale.
Ogni cultura ha risposto in modo peculiare alle esigenze mediche, quindi, come gesto di prima accoglienza, è necessario tener conto delle diverse pratiche cui sono abituati i nuovi utenti. Questo aspetto della relazione d’aiuto è fondamentale, non opzionale, in quanto esperienza e cultura costituiscono l’identità dell’individuo, non sono elementi transitori nella sua vita. L’aiuto è funzionale a far affrontare nel miglior modo possibile le difficoltà del cambiamento, il disorientamento di fronte a un nuovo stile di vita richiesto dal contesto della società ospitante. Diversi sono i rischi cui deve far fronte lo straniero: l’inadeguatezza, la nostalgia, l’ambivalenza.
L’identità è prodotto del costituirsi del nostro culturotipo e nel caso in cui l’ambiente umano e materiale, il territorio, i suoi abitanti e le strutture non siano in armonia con il nostro cuturotipo, ci si sente inadeguati, si perdono certezze. “L’immigrato, se ghettizzato, viene privato delle opportunità descritte ed anche la nostra cultura viene privata dell’apporto di nuove abilità, di diversi pensieri, di saggezze antiche da articolare con moderne, ma spesso deludenti prospettive”: l’immigrato dovrebbe essere messo nelle condizioni di attuare le proprie abilità, per il proprio bene, per sviluppare la fiducia in sé e anche per il bene della società ospitante, la quale si può arricchire nel confronto, con l’apporto di altre culture, nate da diversi punti di vista sulla realtà.
Il cambiamento è apportatore di forza vitale, di spinte motivazionali. Affermano Cecchini–Bodogna, che “la necessità di nomadismo fa parte della natura umana in quanto fattore di arricchimento”. Il cambiamento può essere positivo per lo straniero nella misura in cui non è traumatico, nella misura in cui è equilibrato, in cui non vede dominatori e dominati: questo è anche compito dell’intera società, oltre che dell’educatore.
Le autrici sostengono che, oltre al puro e semplice cambiamento d’ambiente e di abitudini, è anche il disagio psichico responsabile dell’aggravarsi dello stato di salute dello straniero. La nostalgia fa ricordare la propria cultura anche migliore di quello che effettivamente è. Questo processo si chiama cristallizzazione, che è “mitico ricordo del Paese d’origine” come luogo di sicurezza, punto d’appoggio. In termini educativi si dovrebbe cercare di volgere il problema in positivo: proprio in quanto è punto d’appoggio, paradossalmente, dalla propria cultura d’origine ci si può allontanare. La distanza, il cambiamento, la nostalgia, infatti, possono avere un effetto negativo sull’identità, ma anche positivo se opportunamente “contenute”:
“ Può tuttavia realizzarsi una metabolizzazione in qualche modo felice dei nuovi modelli (culturali): l’identità può essere preservata; l’articolazione con il nuovo può essere filtrata dall’Io culturale capace di valorizzare la sua esperienza interiore percepita come forte base di un sapere che dà maggiore pregnanza a ciò che di nuovo viene acquisito: una vera operazione transculturale soggettiva che può dare l’emozione della conquista di più vasti spazi mentali” [108].E’ compito dell’educatore sviluppare nell’utente le capacità transculturali, vale a dire la capacità di monitoraggio delle esperienze, nella ricerca di un equilibrio tra il sapere tradizionale dell’immigrato e il sapere della nuova cultura di accoglienza.
L’educatore, che deve saper essere lui stesso “transculturale”, deve saper conoscere l’utente, valutandone il legame rispetto alla cultura d’origine. Vengono proposti da Cecchini – Bodogna quattro livelli diagnostici di riferimento per l’educatore nella valutazione sull’Io culturale soggettivo:
Soggetto “T” (tradizionale): integro nei riferimenti ai suoi parametri culturali. Si muove con questa solidità, al contempo, fragilità, perché può rallentare l’adattamento;
Soggetto “M” (modificato): è portatore di elementi della sua cultura, ma anche di esperienze che li hanno “intaccati” e hanno immesso nuovi stimoli, col rischio di confusione e di errori nella comprensione del nuovo;
Soggetto “A” (acculturato): non ha assimilato nuovi valori in un processo di scelta consapevole, si integra senza elaborazione, forse anche per opportunismo;
Soggetto “TR” (in situazione transculturale): è stato in grado di operare un passaggio “indolore” dalla tradizione a una cultura diversa.
L’ultimo è il quadro socio-culturale più favorevole, quello verso cui è opportuno l’educatore indirizzi lo straniero, nella relazione d’aiuto.
Desinan arricchisce la riflessione di Cecchini – Bodogna, affrontando il tema dell’immigrazione con una consapevolezza nuova: recupera il tema dell’importanza del soggetto, che deve essere considerato persona.
Il primato spetta all’individuo a cui oggi viene attribuita sempre più importanza, perché ritenuto a tutti gli effetti capace di elaborazione delle nozioni, di significazione. Ci si rende conto che l’immigrato possiede un mondo individuale con il quale assume e modifica la cultura di accoglienza. Il merito di aver orientato in questo senso la riflessione sull’immigrazione spetta al relativismo di cui, se il risvolto negativo e più rischioso è rappresentato dalla perdita dei valori universali in nome della pari dignità di ogni cultura[109], il risvolto positivo è rappresentato dall’aver ritenuto necessario riflettere sull’uomo, sulla sua libertà, sui valori in nome della responsabilità esistenziale. Il compito della filosofia e delle altre scienze dell’uomo è difendere la persona, rivalutarla e restituirle la consapevolezza delle sue capacità: questo è anche il progetto della pedagogia interculturale i cui fini trovano giustificazione nell’attenzione all’uomo. Considerare sopra di tutto l’uomo, uguale nella sua dignità attraverso tutte le culture, è il primo mezzo per superare le ingiustizie sociali, le contrapposizioni e la resistenza di fronte alle diversità.
Il concetto di cultura recupera la sua dinamicità, perché riconosce l’agire umano capace di flessibilità, di ragionamento: è in discussione l’idea secondo cui un sistema culturale rifiuta ciò che estraneo ad esso, mentre si ritiene possibile e auspicabile l’integrazione fra più culture che si trovano a convivere. Piuttosto che interazione, il termine integrazione richiama, da una parte, il rispetto dell’ “integrità” della cultura dell’immigrato e, dall’altra, la necessità essa diventi parte “integrante” della società di accoglienza.
Desinan, inoltre, ritiene non basti una “pedagogia dei buoni propositi” per intervenire nei confronti dell’immigrazione - come in realtà in tutti i campi dell’educazione - , ma un’azione concreta e diffusa. L’educazione interculturale è “educazione alla disponibilità, al decentramento”. I suoi fini si orientano verso la necessità di riconoscere il valore culturale dell’apporto dell’immigrato; verso l’imperativo etico che richiede il mantenimento dei tratti importanti della sua identità. Desinan più volte afferma che un’educazione che non è interculturale non è competa, ricorrendo anche a queste raccomandazioni:
- si deve superare l’atteggiamento di “closed mind”, riconoscendo legittimità anche agli altri modi di pensare, disponibilità a conoscere e farsi conoscere, ritenendo il dialogo indispensabile per una convivenza costruttiva:
- la disponibilità si riconosce nella capacità di mettersi al servizio dell’altro, presupposto chiave per un’educazione alla giustizia, alla pace, al rispetto dei diritti civili e per un’ “apertura sul mondo” ( Ouellet).
Il rifiuto iniziale di sforzarsi per venire per primi incontro allo straniero, non deve essere inteso come rifiuto tout court dell’aiuto, disinteresse di allacciare rapporti costruttivi. Non si può biasimare la paura nei confronti del “nuovo” - la resistenza al cambiamento non ha di per sé valenza necessariamente negativa, a meno che non sia atteggiamento cronico di rigidità -, perché segno di semplice paura, tentativo di difesa. Desinan fa riferimento alla lettura di Camilleri che studia le modalità per superare il conflitto nei confronti della diversità, chiamandole “strategie identitarie” che, come dice la parole stessa, vogliono raggiungere lo scopo di mantenere l’identità personale:
- rigetto radicale,
- assunzione radicale.
Queste due operazioni vengono attuate senza prendere in esame la cultura nuova. Entrambe appaiono come soluzioni, ma non lo sono realmente perché, in un caso, per eliminare il conflitto intrasoggettivo viene portato alle estreme conseguenze quello intersoggettivo, e viceversa nell’altro.
Altre strategie sono caratterizzate dal fatto che l’individuo affronta la contraddizione, ma approda semplicemente a una parvenza di coerenza:
- strategia di convenienza: l’individuo entra nella nuova cultura per interesse. Il rischio è una vita sdoppiata, il “mascheramento delle intenzioni”;
- strategia che conduce all’identità di opposizione: gli immigrati, oggetto di pregiudizi, si sentono rifiutati e preferiscono il sistema culturale di origine. Accentuano le peculiarità della propria cultura e in essa rischiano di restare confinati;
- strategia dell’investimento: fra le due culture si stabilisce una forma di continuità, elementi nuovi vengono interpretati in riferimento ai significati tradizionali;
- strategia dell’intervento futuro: accetta i nuovi presupposti, ma trova una giustificazione nei vecchi;
L’educatore, oltre a conoscere i significati che nascondono in sé queste azioni, deve saper garantire la costruzione delle basi che possono permettere una risoluzione del conflitto, nel superamento della diffidenza. L’immigrato non deve essere considerato come colui che vive tra due culture, ma come colui che appartiene ad entrambe, senza tradirne nessuna, che deve imparare ad assumere atteggiamento interculturale. L’educatore deve aiutare in questo percorso l’immigrato e, dall’altra parte, deve garantire la società faccia altrettanto.
Per Cecchini – Bodogna le competenze richieste soprattutto si devono fondare sulla tolleranza, sul rispetto “della diversa identità, delle diverse espressioni culturali e religiose”, come occasioni di scambio e confronto, “per realizzare la partecipazione ed il coinvolgimento anche degli utenti stranieri”, per conquistarne la fiducia. L’educatore deve imparare a contestualizzare l’utente, comprendendo il suo diverso punto di vista, la diversità di comunicazione, valori, atteggiamenti, frutto di altri parametri culturali. Egli deve rivedere i suoi comportamenti, disponendosi a tutti gli effetti nella dimensione dell’apertura mentale, della disponibilità per instaurare un clima di “accoglienza culturale”.
Relazione d’aiuto, casi limite
L’aiuto nei confronti di soggetti con mali incurabili o a bassa aspettativa di guarigione
“ Non mira necessariamente al cambiamento, quanto ad intraprendere un cammino di sostegno nel tentativo di rivalorizzare il percorso di vita di ogni persona; di attribuire dignità e accompagnare attraverso le fasi della vita che non sono solo sofferenza e degrado fisico; di aiutare la persona ad uscire da una situazione di vittima affinché assuma consapevolmente la responsabilità della sua vita ed entri a pieno diritto in un contesto sociale che lo accolga, lo aiuti a percepirsi come individuo ancora utile ed ad intessere relazioni positive e cariche di significato in cui trovi posto la gioia di vivere ” [110].
Malaguti definisce in questo modo le caratteristiche dell’intervento nei confronti delle persone malate di AIDS[111]. Queste persone oltre a dover affrontare la difficoltà umana di pensare alla fine dell’esistenza, devono affrontare un'aggravante che rende ancora più problematico il sperare: lo stigma sociale. Il giudizio della società annulla, segna distanze, sottolinea diversità di fronte a cui i malati stessi non hanno potere, perché non hanno scelto un ruolo nel destino, ma questo è stato imposto loro.
La costruzione della relazione d’aiuto si fa difficile, forse come mai in nessun altro caso, perché sarà difficile trovare il senso degli eventi e doverlo accettare. Di fronte al proposito educativo di costruire sembra si stringano irreparabilmente gli orizzonti del futuro.
Nello stesso testo, Chieregatti, affrontando la riflessione relativa ad un’altra drammatica prova cui è stata sottoposta l’umanità, lo sterminio, si sente di affermare che, anche se “la cancellazione della memoria è un modo di difendersi”, è necessario dar voce alla storia che sta dietro ad ogni persona. Un esempio tanto estremo fa riflettere sulla necessità di realizzare il lavoro di aiuto fondandolo sulla base di un rapporto autentico di conoscenza e presa in carico reciproca. L’educatore si occupa di dimostrare all’educando la sua possibilità di vivere ancora, ma anche l’educando si sente responsabile dell’investimento umano che l’educatore compie nei suoi confronti e per non renderlo vano lo accetta come segno di amicizia.
Il legame nei confronti di una persona per la quale le possibilità di sopravvivenza possono non esserci richiede di aiutarlo a conquistare serenità di fronte alla sua vita, di cui è ancora protagonista e responsabile. Verso questa direzione l’educando deve essere portato a riflettere, ma la libertà di accettazione dell’aiuto non rende lecita nessuna imposizione: prima di tutto viene la scelta dell’aiuto, poi l’educatore può operare.
A sua volta anche l’educatore deve disporsi a riflettere. Il suo oggetto d’attenzione deve riguardare la consapevolezza di trovarsi di fronte a un uomo, una donna, prima che ad un malato. Secondo Malaguti, egli è chiamato a chiedersi chi sia l’altro e a lui lasciare possibilità di espressione per poterlo conoscere: oltre a intraprendere un cammino assieme, in cui l’educatore dà spazio alla storia dell’altro e gli insegna a valorizzarla, è necessario interpellare l’educando in prima persona, risvegliando e ricostruendo il suo impegno e la sua determinazione nel vivere ancora.
All’educando è richiesto di curarsi, di assumersi, primo fra tutti, la responsabilità di desiderare ancora di vivere per rivalorizzarsi, sentirsi ancora utile, per uscire dalla situazione di vittima e reagire. Il rapporto si gioca sull’esplicitazione, sulla messa in campo delle esperienze di vita e del senso che le stesse assumono per il malato, che come singolo uomo - accompagnato da un altro uomo il quale dimostra interesse nei suoi confronti - trova difficoltà ad orientarsi in ciò che è indeterminato e inaccessibile ai suoi pensieri, come la morte. L’educazione, infatti, in nome della vita, sfida i limiti dell’uomo e affronta il tema della morte e, nel contempo, della speranza e delle possibilità. Esplicitare questi argomenti, che fanno paura se restano nascosti, e affrontare i grandi temi vitali è modo per garantire la chiarezza nel rapporto di sostegno con l’educatore: “si riesce ad affrontare una relazione d’aiuto fondata sui criteri della reciprocità dove vengono dichiarati i limiti, le ragioni, i compiti e le funzioni sia di chi porta l’aiuto sia di chi lo riceve, offrendo a quest’ultimo la possibilità di esprimere i bisogni, le aspettative e le motivazioni che lo spingono ad accettare l’offerta con la possibilità di scegliere un percorso alternativo”. La relazione resta asimmetrica, ma si caratterizza per la costruzione di legami forti, qualora sia possibile, per una vicinanza umana che va al di là del tempo e dello spazio dell’aiuto.
Di fronte al grande sconforto, alla solitudine, alla preoccupazione di dover lasciare nella vita terrena tutto ciò che è stato punto di riferimento – sia esso materiale o affettivo -, l’educazione punta sull’idea dell’uomo attivo, dell’uomo ricco di potenzialità, che cerca sempre nuove strade per il miglioramento, che supera le difficoltà, e propone all’educando di reagire. Cerca di sostenere l’uomo di fronte ai suoi limiti, alla sua incapacità di orientarsi nella fine, nell’incertezza che lo aspetta. L’autobiografia, come nuovo metodo concreto per esercitare la soggettività, per andare oltre i tradizionali paradigmi, per ri-percorrere l’esistenza e riflettere sull’esistere ancora, può dar voce all’educando.
Come più avanti[112] si afferma la distanza dell’educazione dalla psicologia, c’è un altro ambito di distanza che fa emergere le caratteristiche dell’aiuto educativo, specialmente quando, come in quest’ambito, diventa intervento estremamente delicato: la differenza fra modello educativo e modello medico. Groppo[113] considera che, mentre il secondo si caratterizza per la sequenza diagnosi-definizione di caso-terapia, l’intervento educativo è centrato sul rapporto interpersonale e che, mentre il medico interviene in un tempo limitato, il tempo in cui l’educatore si occupa del soggetto è certamente continuato o addirittura lungo. Il medico interviene per la cura, l’educatore si prende cura, opera per garantire un contenimento emotivo, fino al raggiungimento della sicurezza dell’educando.
L’educatore è una presenza consapevole, matura, responsabile, instaura una relazione dialogica, una comunicazione umana, una “vicinanza comprendente”. Non ha il “distacco clinico”, che, invece, è strumento di lavoro del medico, dello psicologo o dello psicoterapeuta. Il suo strumento è l’empatia: si prende dentro i problemi, prova dentro la situazione problematica proposta dall’interlocutore.
Il lavoro del medico non si caratterizza necessariamente per la “freddezza”, ma si può arricchire se diventa anche “relazione d’aiuto”. In questo senso la figura professionale del medico e dell’educatore lavorano nei confronti del soggetto in modo complementare, sul fisico e sulla sua interiorità. Nell’intervento nei confronti dei malati terminali non si tratta tanto di guarire, ma di accompagnare, pur non abbandonando la speranza della guarigione, senza disporsi all’attesa di un miracolo repentino. E’ necessario convincere il soggetto dell’importanza della sua partecipazione, sia nelle cure, sia nell’accettazione dell’educazione che si fa “aiuto spirituale”.
Savignano[114] dal punto di vista dell’etica narrativa, variante dell’etica delle virtù, affronta l’argomento del rapporto medico-paziente, rivolgendo l’attenzione ad una questione egualmente importante in entrambi i campi, dell’aiuto e dell’intervento medico: la questione etica. La disposizione del prendersi cura, la “compassione” nel senso etimologico del termine ( da p?qo? , sentire), è all’origine della vita morale. Afferma Svignano che i nostri pazienti non sono tanto preoccupati del rispetto per la loro autonomia e di ottenere scrupolose informazioni sulla loro malattia, quanto sono interessati a essere seguiti da un medico nel quale aver fiducia. Il medico ha la prerogativa di agire secondo il principio di beneficità, per il “bene” del paziente, che nello stato di malattia, dal momento in cui questa compromette “l’integrità personale”, può disporre di un’autonomia molto limitata, può provare ansietà, paura, dolore, timore. La situazione difficoltosa nella quale il paziente si può trovare può indurlo a cercare nel medico un aiuto di tipo “paternalistico” e a sottovalutare l’importanza della sua autonomia decisionale.
Fra il paternalismo e l’autonomismo, c’è una terza via, che Savignano chiama della “beneficità fiduciaria”: il medico e il paziente sono chiamati ad agire per il reciproco bene, sulla base del dialogo. Ad entrambi sono richieste delle “virtù” e quelle del medico, sono tali da affiancarlo alla figura dell’educatore: l’abilità tecnica; ma anche la compassione, consistente nel “sentire in sé qualcosa della malattia del paziente”; la beneficità e benevolenza, consistenti nel fare e volere il bene del paziente; l’onestà e fedeltà; il coraggio. Si può, in un certo senso, affermare che è auspicabile il medico acquisisca alcune delle caratteristiche educative, fino a creare un vero e proprio rapporto col paziente, tanto che Engelhardt parla di “amicizia medica”
I principi base da attuare nel campo del confronto con la malattia, stabiliti nel “Belmont Report”, alla fine degli anni ’70, sono:
a) il principio di autonomia e del rispetto delle persone;
b) il principio di beneficità , che implica la valutazione dei rischi-benefici;
c) il principio di giustizia nella ripartizione rischi-benefici, in rapporto a bisogno, impegno, contributo della società e merito.
Il documento citato pone un forte accento sulle scelte e azioni autonome: bisogna rispettare l’autonomia delle persone, dar valore alle loro aspirazioni e scelte. Bisogna superare ogni attitudine solipsistica a favore dell’idea di uguaglianza degli interlocutori. Per colui che aiuta, sia egli medico o educatore, è fondamentale riconoscere anche la dimensione individuale della persona e che le decisioni scaturite dai vissuti non sono meno degne di quelle che derivando dall’esperienza professionale. Rispettare l’autonomia vuol dire porre il paziente nelle condizioni di poter decidere “in accordo con sé”, alla luce dell’idea di autorealizzazione: il paziente è degno di essere trattato come un interlocutore valido.
La prospettiva, secondo Svignano, che consente di evitare atteggiamenti estremi come paternalismo o autonomismo è quella dialogica: da una parte, il soggetto può, a pieno diritto, pronunciarsi su questioni attinenti alla propria salute-vita; dall’altra, riconosce il suo bisogno di aiuto fisico, ma anche etico. L’ideale auspicabile è la medicina umanistica che si costituisce sulle competenze tecniche ma anche sul carattere morale, sullo sfondo dell’etica narrativa e dell’etica delle virtù. I suoi fondamenti sono la dimensione comunicativa; il rispetto delle decisioni libere dell’altro; la promozione della dignità del paziente; l’impegno ad accompagnarlo e assisterlo anche nelle decisioni, oltre che nel corso della malattia, promuovendone il coinvolgimento a pieno titolo nel processo decisionale; la preoccupazione di garantire il bene del paziente; la valorizzazione della dimensione affettiva, accanto alla sensibilità religiosa per affrontare le domande cruciali dell’educando sull’esistenza e sul significato della sofferenza..
Svignano sottolinea la necessità di stare vicino al soggetto malato: “la malattia fa sentir soli”. Il paziente ha bisogno di condividere con qualcuno la propria sofferenza.
Il medico, anche e possibilmente assieme all’educatore, deve opporsi al solipsismo, affermando la ricchezza umana e soprattutto la necessità dell’incontro intersoggettivo.
Una figura trattata in “Volti dell’educazione”, che a mio avviso pare trovare anch’essa giusta collocazione in questo caso particolare di aiuto è la guida spirituale[115]. Per Nanni
“ Se pare essere esigenza diffusa uno speciale aiuto per poter dare risposte interiori non facili da prendere in sé e per sé e specialmente da soli, non meno forte – anche se forse meno cosciente – è l’esigenza di non essere soli sia nei momenti decisivi della vita, quando si è come a incroci o a bivi che indirizzano definitivamente per questo o quel percorso sia più quotidianamente lungo il corso dell’esistenza “[116].
Il compito della guida è rappresentato dal tentativo di dare un “orientamento esistenziale”, di essere accompagnatori. La figura è proposta in termini professionali, ma, specialmente nel caso del malato terminale, ritengo che possa essere delineata, invece, anche nei termini di “proposta”, “modello” cui vi si possano accostare anche i genitori o gli educatori stessi assieme ai medici, coloro che più di tutti stanno accanto al soggetto malato.
In realtà, la giuda spirituale non interviene solo nei casi estremi, però - trattando questioni relative al “mistero dell’essere”, facendo in modo le persone si rendano conto dei “movimenti dello spirito”, aiutando a entrare in profondità con se stessi e nella dinamica relazionale diadica –in particolare in questi si colloca il suo intervento. Nanni stesso afferma che
“ …può diventare difficile fare i conti con l’esperienza della sofferenza, del dolore, della morte “ravvicinata”, o dei semi di morte cosparsi nella terra e nel tempo in cui si vive (…) O, all’opposto, nel cercare di andare a fondo a sé e nel fervido impegnarsi per e con gli altri si può pigliar coscienza sia della contingenza di ogni agire storico e sentirsi presi da un desiderio d’infinitezza, di ulteriorità e di profondità senza misura oltre i modi umani… ” [117].
Nella relazione d’aiuto c’è bisogno dell’incontro con il senso dell’esistenza, con il suo mistero e col mistero di Dio. A queste questioni il malato vorrebbe trovare una risposta e la guida lo può sostenere, non lasciandolo solo nemmeno nel momento della riflessione, che è personale, ma che può essere condivisa, anche per confrontare le ipotesi di risposta.
E’, infatti, un compito educativo primario analizzare, far chiarezza sulla vita. La spiritualità è tema pedagogico e, nel contempo, risposta pedagogica alle esigenze delle persone che all’educazione si accostano. Questo approccio, però, non si sofferma al riflettere, ma va oltre per innescare un profondo desiderio di azione, di non “staccarsi” dalla vita, ma di farvi ancora parte, trovando nel rapporto con l’educatore-giuda spirituale, nuovi spunti di aggancio da mettere in pratica, cui rifarsi per “ripartire”.
La “filosofia della vita” è occasione per tentare di calarsi nelle dinamiche che stanno al di sotto della superficie del nostro agire quotidiano. Serve per acquisire consapevolezza, per darsi delle mete che vanno oltre il contingente e permettono di guardare vita-mondo-malattia-rapporti attraverso un ottica che rende ragione della loro ricchezza, del loro senso. La riflessione è arricchimento in sé, è tentativo di intravedere la “strada”, in un momento difficile, senza la pretesa di trovarla per certo. Il fatto di tentare è segno di nuova vita, di rinnovato e ricostituito vigore, speranza e forza, al di là di tutte le sofferenze e difficoltà percorse e da percorrere.
2.2 LA RICERCA DI SENSO
Ogni individuo vede la realtà attraverso i propri occhi, non raggiungendo mai l’obiettività. Riflette sugli avvenimenti dandovi un proprio senso, che dipende dal contesto in cui è vissuto, dalle abitudini che ha acquisito, dalla società nella quale è cresciuto, ma molto dipende dal sé.
Bronfenbrenner, con la teoria sullo sviluppo umano, spiega il perché di quest’affermazione. Non solo l’uomo, né solo l’ambiente sono responsabili dello “sviluppo”, ma entrambi, interagendo fra loro, ne sono responsabili assieme: è, infatti, difficile isolare un’unica causa negli eventi umani, mentre è più probabile leggere la realtà facendoci guidare dall’idea della complessità.
Anche il “senso” è un fatto complesso. Non viene affrontato da subito in pedagogia come modo di spiegare l’individuo e le azioni da lui compiute. Inizialmente si ricorreva al paradigma causale: ricercando la causa dei comportamenti si sarebbe potuto “capire” l’azione umana, mossa da una o più motivazioni e fattori scatenanti. Questa interpretazione, però, porta con sé un risvolto estremamente negativo, perché svuota l’uomo di complessità, dando l’impressione, rivelatasi errata, che le sue azioni siano semplicemente risposte a stimoli: quasi matematicamente dato il presupposto A, si sarebbe ottenuta una risposta già nota prima che effettivamente si potesse compiere. Per esempio, nel campo dello studio sulla devianza minorile, qualora il minore crescesse in una situazione esistenziale suscettibile di essere vissuta come “difficile”, si sarebbe ritenuto certa, o quantomeno molto probabile, una evoluzione in senso deviante del ragazzo. Secondo la lettura causale, l’individuo sarebbe puro destinatario di uno squilibrio e il suo comportamento non ne sarebbe che l’esito determinato e prevedibile. Il rischio che questo ragionamento comporta, oltre ad essere l’etichettamento, è anche rappresentato dalla predizione autorealizzantesi: se diamo per scontato che un fatto avvenga è probabile che effettivamente si realizzi. La maggior parte dei minori che compaiono tra gli arresti nelle statistiche giudiziarie appartengono effettivamente alle classi sociali più svantaggiate o provengono da aree urbane marginali, cosa che sembrerebbe confermare l’ipotesi predittiva di senso comune. Ma è importante, nel leggere i dati, spogliarsi di qualunque pregiudizio, per non “forzarne” la lettura: infatti, analizzando meglio il perché di una rivelazione tanto eclatante, è facile scoprire come i giovani delle classi inferiori non siano tanto quelli che commettono più reati, quanto quelli che hanno maggiore probabilità di venire arrestati. E questo è solo un esempio di come sia necessario scoprire a fondo i perché degli eventi e i perché delle azioni umane, le cui risposte sono probabilmente sempre molto più difficili e immediate di quello che sembrano.
Da questo “excursus” sulla devianza si capisce bene, in primo luogo, che l’uomo non è una macchina le cui risposte possono essere prevedibili; in secondo luogo, considerazione derivante dalla precedente, che gli uomini non sono tutti uguali.
Come educatori possiamo presupporre che il nostro utente abbia agito per determinati motivi, ma, in realtà, non è detto siano gli unici, né, addirittura, che siano corretti. Sembra, a questo punto, che non esista un’unica realtà.
La pedagogia sviluppa questa difficile riflessione sul senso non per scardinare le certezze umane, ma per dare delle risposte più corrette e più rispettose della dignità e ricchezza umana. Infatti, la conclusione al quesito circa le cause degli avvenimenti trova risposta nel superamento dei paradigmi di stampo positivista-eziologico-deterministico, per riconoscere la centralità del soggetto e del suo personale contributo nella costruzione di sé e della realtà stessa.
Non esiste più di una realtà, ma ne esistono tante nella mente degli individui: il valore dei fattori alla base delle azioni umane non è eziologico, ma interpretativo. L’uomo interpreta la realtà, fin dalla sua prima infanzia non è vittima degli avvenimenti, del contesto, di ciò che è già “dato”, ma “legge in modo personale” tutto ciò. Diversi soggetti, e perfino lo stesso in diversi momenti, potrebbero elaborare un’identica situazione esistenziale in svariati modi: questo non vuol dire che la realtà sia effettivamente diversa, ma che gli uomini la vivono in modo diverso[118].
Bertolini[119] valorizza questo paradigma di lettura e di approccio pedagogico, per proporre la valorizzazione del soggetto come concreto stile di intervento, in modo che non resti unicamente un’utopia. Questo presupposto teorico, infatti, fa sì che la relazione educativa, nella prassi, si strutturi in modo tale da tener conto del contributo soggettivo, personale, unico dell’educando nella costruzione di sé, analizzando le elaborazioni cognitive in base alle quali attribuisce significato agli eventi, agli scopi e giustifica il suo agire. Bisogna capire le ragioni che hanno spinto “quel” ragazzo ad entrare in “quel” gruppo, quali siano i significati che egli attribuisce a “quei” modelli, bisogna entrare nella sua particolare visione del mondo.
L’educatore deve cercare di capire, proprio attraverso il dialogo, volto alla scoperta dell’altro, “il contributo del soggetto nella costruzione del proprio modello di interpretazione del mondo e di azione nel mondo”.
Bertolini sottolinea che esiste un senso “soggettivo”, dato dal del soggetto stesso dell’azione, e un senso “oggettivo”, dato dall’osservatore, dell’azione. E’ chiaro che l’intervento educativo si deve costituire sulla base di entrambi: del primo, per superare il rischio di generalizzazione e per valorizzare, invece, l’apporto originale e del tutto personale del singolo, nella lettura della realtà e nella espressione delle proprie esigenze; del secondo, per garantire il confronto e una lettura razionale, partecipata, ma meno coinvolta.
“ ...vi è qualcosa di utile sia nella significatività soggettiva che in quella oggettiva. Ciascuna deve scrollarsi di dosso la pretesa di rappresentare un valore assoluto e autosufficiente.
Non è sensato che io consideri significativo unicamente ciò che è tale per me. E’ bene che io apprenda anche ciò che è significativo per altri “ [120].
Dire che il soggetto non è mai del tutto “determinato” da pressioni esterne, non significa svuotare di incidenza i contesti in cui egli si sviluppa e di responsabilità le persone da cui riceve formazione, ma vuol dire che tutto ciò che egli vive passa al “vaglio” delle sue emozioni e della sua cognizione. E’ l’uomo a “decidere” come agire nella realtà e che cosa recepire da essa.
Canevaro esprime questo concetto richiamando una citazione di Jacquard (1983):
“Io non sono come gli altri. Certamente, perché il mio patrimonio genetico, frutto di una doppia combinazione, è unico; unica anche l’avventura che ho vissuto. Quello che ho in comune con tutti gli altri è la possibilità, a partire da ciò che ho ricevuto, di partecipare alla mia propria creazione. Però bisogna che si lasci la possibilità. Grazie, genitori (…) Grazie famiglia (…) Grazie a chi mi ha trasmesso con l’insegnamento le conoscenze lentamente accumulate dall’umanità da quando interroga l’universo(...).
Grazie a chi mi ha amato, per l’amore insostituibile. Ma sono io che devo completare l’opera, tocca a me posare la trave portante. Dimenticate quello che avreste voluto che io fossi. Non devo realizzare il sogno che avete fato per me; sarebbe tradire la mia natura umana.
Perché io sia veramente umano, mi dovete un ultimo regalo: la libertà di divenire quello che ho scelto di essere” [121].
Ritengo che questo testo - pur essendo tratto da un contesto diverso da quello della ricerca di senso - può essere anche portato a testimonianza del fatto che la capacità di significazione costituisce una salvezza. Anche nei lager, per esempio, una delle più forti e più disarmanti esperienze di annullamento che abbia vissuto l’Uomo, la facoltà di significazione ha fatto sopportare l’assurdità della vita che si stava scagliando contro gli individui. Anche e addirittura in questi contesti estremi, l’uomo ha a disposizione uno spazio privilegiato di elaborazione personale che nessuna dittatura e nessuna usurpazione della liberà gli possono togliere. Di fronte all’orrore dei maltrattamenti umani rappresenta ben poca cosa, ma è una forza di cui l’individuo può disporre.
In casi meno tragici, ma tuttavia difficili - come il giovane costretto al carcere, il tossicodipendente che vuole disintossicarsi, l’anziano che è lasciato solo a se stesso, le ragazze immigrate sfruttate nel giro della prostituzione, ma anche, in generale, nei casi in cui la persona cerca qualsiasi tipo di aiuto – l’educando riscopre di essere protagonista della propria vita e degno, quanto tutti gli altri, di disporre di questa facoltà. L’educatore, ma anche l’insegnante, il volontario o colui che per professione, per disposizione personale vede nelle relazioni interpersonali il centro focale della propria esistenza, deve aiutare a non far dimenticare all’Altro la sua capacità di significazione. L’individuo può chiedere aiuto, ricostruirsi per ricominciare, realizzare un cambiamento in senso migliorativo, se prende coscienza della possibilità di ri-guardare e ri-conoscere la realtà.
“L’appartenenza a una comunità – afferma Canevaro - permette di portare le proprie ragioni ma di non considerarle un assoluto”.
“ ... ogni individuo, come diversità singola, rappresenterebbe una garanzia di comunicazione, grazie al noto assioma secondo cui comunichiamo in virtù delle differenze…” [122] .
Un ulteriore passo avanti nella presente riflessione consiste nel rendersi conto della limitatezza del processo di significazione qualora sia prodotto da una singola individualità. E’ vero che ogni individuo vede la vita in modo del tutto personale e che in base a questo suo personale punto di vista si muove nel mondo, ma è anche vero che la costruzione di senso assume valore positivo quando non si chiude all’Altro, ma “si arricchisce nel mondo-con-gli-altri”.
La costruzione non è mai solipsistica, ma continua incessantemente - in un arricchimento coerente con l’idea di Educazione permanente, lungo tutto il corso della vita - anche grazie alla presenza degli altri. Prendere coscienza di processi di significazione diversi dal proprio è
- garanzia di arricchimento;
- garanzia di conoscenza oggettiva, costituentesi in un processo di negoziazione, che ci permette di accordarci e vivere nella società condividendo valori, leggi, cultura, mentalità;
- è dimostrazione della parzialità del punto di vista di ciascuno.
Dall’esperienza vissuta e dall’elaborazione soggettiva scaturisce la visione del mondo, che comunichiamo attraverso il nostro agire. L’azione comunica un po’ di noi, trasmette agli altri i nostri valori o disvalori, le priorità che abbiamo deciso di seguire nella vita. L’educatore legge tutto questo e deve lavorare sul presente, prima di tutto, sulle capacità e sull’attuazione di nuove esperienze positive, creando in questo modo un disorientamento nell’educando che ha creduto il proprio stile di vita fosse l’unico immaginabile e attuabile da cui trarre soddisfazione. Il confronto con la diversità, con un altro modo di intendere la vita, generatore anche di nuove felicità e soddisfazioni, conduce a prendere le distanze da un passato emarginante, senza sbocco sul futuro.
Nel testo di Demetrio, “Manuale di educazione degli adulti”, vengono indicate tre mappe che orientano la lettura della vita adulta: sono il punto di partenza per fondare una teoria sistematica dell’ Educazione degli adulti.
Mi soffermo sulla prima, già in precedenza citata[123], e sulla terza mappa, alle quali Desinan[124] ha aggiunto alcune considerazioni, che desidero ripercorrere e motivare.
Nella mappa euristica, che studia le caratteristiche dell’apprendimento adulto e il perché si torni ad apprendere da adulti, oltre al condizionamento, al cambiamento e alla comunicazione, non si può prescindere da un ulteriore canale dell’educazione: la riflessione. I primi tre provengono dall’esterno, sono estrinseci all’individuo: qualora fossero unicamente queste le motivazioni per apprendere rischieremmo di ridurre l’uomo e il suo ragionamento a essere conseguenza dell’ambiente. E’invece importantissima la riflessione personale, anche come momento di incontro fra esterno e interno, ma non solo. Valorizzare la capacità di riflessione dell’uomo vuol dire non perdere il protagonismo e l’originalità di ciascuno. Siamo noi uomini, singolarmente, a dare valore al vissuto, è come se la realtà si mostrasse a ognuno nello stesso modo, ma di essa ogni persona rilevasse diverse sfumature.
In secondo luogo, rispetto alla mappa tecnologica, la quale indica cinque strategie attraverso le quali l’adulto impara (modalità dell’imitazione, tecnica argomentativi, innovativa, decostruttiva, dell’immaginazione ), viene aggiunta da Desinan la narrazione. L’adulto impara e “si insegna” nel momento in cui si spiega agli altri: impara a raccontarsi, esplicitando la propria attività solitaria, gli argomenti della propria riflessione.
Questo contributo mette in evidenza i due risvolti che stanno alla base del presente paragrafo: la capacità di significazione individuale e la spendibilità della stessa nel contesto collettivo.
Le consapevolezze raggiunte grazie al contributo teorico possono e devono essere spese nella prassi, campo in cui permettono il raggiungimento di risvolti immediati: aiutano a garantire la scommessa pedagogica che consiste nella valorizzazione dell’uomo, come anticipato, ma prima di tutto garantiscono la possibilità del recupero, del superamento delle difficoltà, nella consapevolezza dell’importanza di darsi aiuto anche da sé e, nel contempo, di ricevere aiuto. Attribuire all’educando la capacità di esercitare il pensiero, di interpretare da sé e non essere solo destinatario degli eventi che gli accadono, di pensare criticamente, coscientemente, autonomamente, di auto-osservarsi e attribuirgli, inoltre, la capacità di raccontare le personali interpretazioni, nella relazione d’aiuto e, più in generale, nell’incontro con l’altro, rende l’uomo passibile di miglioramento, libero di sceglierlo e condividerlo.
La relazione d’aiuto ha, per questo motivo, senso di esistere, perché scommettere sulle possibilità dell’educando e garantisce una coscientizzazione dell’esistenza permettendoci di vivere in modo più profondo, più umano, ma anche più solidale nell’arricchimento reciproco.
In questo modo siamo sicuri come educatori di realizzare il grande intento di rendere all’uomo la sua dignità, che a volte rischia di essere dimenticata, calpestata e di recuperare la sua dimensione sociale, anch’essa sempre più a rischio di essere sottovalutata. Anche questa è la ragion d’essere dell’educazione, che dimostra ancora di identificarsi con la vita, con il suo senso, con le sue scommesse sull’uomo.
Presento di seguito due modalità di ricerca del senso: sperare, avere interesse a orientare la propria vita verso un futuro auspicato, e fare autobiografia, ripensando al passato, per riconoscersi e progettarsi ancora.
2.2.1 La speranza
La speranza è un valore che proietta l’uomo verso il suo destino. E’ argomento di riflessione dell’educazione perché essa si orienta proprio al futuro, restituendolo a chi non lo vede più nella propria vita, a chi non l’ha mai visto, non ci crede o non vuole vederlo, a chi per un periodo lo perde di vista, a chi non conosce la sua portata motivazionale.
L’educazione si occupa dell’educando e lavora costruttivamente sul suo passato, che è trampolino di lancio a partire dal quale aiutarlo a guardare oltre e a scommettere su di sé, insegnandogli a contare sulle sue possibilità, sul suo valore, sull’indole della sua natura umana, volta spontaneamente alla ricerca di un cambiamento migliorativo, alla espressione-realizzazione di sé, alla soddisfazione della sua curiosità, alla sfida, anche con se stesso, per misurarsi. L’uomo possiede queste ed altre capacità, ma è necessario - per fare in modo che l’educazione dimostri di aver ragione a credere in lui –dimostri di possederle. L’educatore si adopera ad aiutare l’educando a essere cosciente di chi sia, di quali siano le sue potenzialità.
Bauman[125] esemplifica la condizione umana attraverso una metafora: l’uomo gioca e scommette con la vita. Mantenendo la visione emblematica di questo autore, immaginiamo che, nel corso del gioco, l’uomo possa vincere oppure perdere, e il fatto che in un passato difficile egli abbia perso non deve fargli perdere la speranza di poter/voler vincere in futuro. Ha sempre una successiva possibilità, può sempre riscattarsi, e, in educazione, per compiere questo riscatto, è aiutato dall’educatore, assieme al quale può costruire le premesse per rientrare nel gioco, per ricominciare a vivere nel presente e avere degli obiettivi, nel futuro, che lo orientino e gli indichino le mosse per una prossima partita. Giocando e scommettendo su di sé, agendo con fiducia nelle proprie possibilità, l’uomo dà senso all’esistere, con l’aiuto dell’educatore.
Passato, presente, futuro sono tre momenti della vita umana sui quali si focalizza l’interesse della relazione d’aiuto: l’uomo del passato è l’uomo che ha vissuto esperienze difficili o che gli hanno fatto desiderare di cambiare e di introiettarsi; l’uomo del presente è colui che chiede aiuto; l’uomo del futuro è l’uomo della speranza, l’uomo su cui scommette l’educazione.
Per spiegare che cosa intendere per speranza, mi sono affidata alla definizione che ne dà Alberoni[126]:
“La speranza è il coraggio di pensare con fiducia al domani che, senza di essa, ci apparirebbe solo come il luogo dell’inquietudine, del mistero e del pericolo. Invece, illuminato dalla speranza, il mondo diventa il regno delle infinite possibilità.
(…) La speranza non è un semplice entusiasmo ingenuo e generico. Ma è saldamente ancorata nella forza morale, nel coraggio, nell’intelligenza, nella fede, nella capacità di vivere e in antiche virtù troppo spesso dimenticate. La speranza scaturisce dalle forza positive del nostro essere (…) principio unificante che dà senso alle nostre azioni” [127].
Avere speranza vuol dire avere un obiettivo, un progetto, un desiderio da realizzare, vuol dire continuare a migliorare la propria vita, che si costruisce sullo slancio ed è sempre in potenziale evoluzione. L’educazione lotta per valorizzare l’uomo fino alla morte, finché la vita c’è.
In ognuno c’è posto per la speranza, ma non è detto che esista effettivamente nell’oggi, spesso è da conquistarsi e la sua conquista non è facile, né ci esime da rinunce e fatiche. Coloro che hanno alle spalle vissuti difficili, che non credono in se stessi e nella facoltà di essere costruttori della propria storia o coloro che hanno vissuto nella mancanza devono riconquistare, o conquistare del tutto, questo ineliminabile valore. L’educatore è colui che restituisce speranza, dimostra all’educando di volere il suo bene e di non lasciarlo solo.
Hegel con “fatica del concetto” intende che l’uomo può conquistare uno stadio superiore rispetto a quello presente, solo con “fatica”: è ciò che accade anche nel percorso educativo, in cui la speranza - condizione per andare verso la meta che educatore ed educando si prospettano - non è un dono innato, ma un “punto di vista sulla realtà”, una concezione positiva dell’esistere, che dev’essere acquisita, concettualizzata[128] dall’educando nel confronto delle proprie visioni del mondo con quelle dell’educatore.
Sperare, però, non vuol dire lasciarsi andare alla fantasia e alla fiducia cieca senza fondamento, ma lavorare e impegnarsi in modo concreto, perché tenacia, applicazione e speranza stessa assieme possono portare al risultato desiderato. Non viene mai meno, anche in questo frangente positivo, il rischio e la possibilità-necessità di dover accettare e superare il limite e la sconfitta, che fanno parte dell’educazione quanto della vita. Afferma Alberoni[129] che “la speranza ha il potere di placare le nostre ansie, di rendere sopportabile il presente e di rafforzare la nostra volontà, di combattere per realizzare ciò che desideriamo”, ci permette di scegliere la meta, sulla base dei nostri desideri, e di cercane la realizzazione.
Anche la relazione educativa si fonda su questi principi e, da parte di entrambe i soggetti, per la paura di non riuscire e per le resistenze, non sarà priva di sconforto. Lo sconforto, secondo Alberoni, è la “spinta” che ci permette di prendere le forze dopo una sconfitta; allo stesso modo il rimorso ha il valore positivo di non farci dimenticare gli sbagli commessi: entrambi ci impongono un altro modo di pensare, agire, di “riorientarci” e per questo devono essere valorizzati come ”risorse”.
Le sfide che l’essere umano incontra nel corso della propria vita sono, in fondo, una necessità “per tener desto il suo cervello, per tener attivo il suo ritmo vitale”[130]: l’essere umano ha bisogno di problemi. Paradossalmente sono proprio i problemi ad avvicinare gli uomini e in campo educativo a investire l’educatore di responsabilità, a spingerlo a “prendersi” cura dell’altro. La speranza, infatti, non è solo cura di sé, argomento che è prevalso nella definizione del termine fino ad ora, ma in realtà è sorretta dalla cura degli altri: addirittura può nascere dalla presenza dell’altro, su cui poter contare e in cui trovare alimentazione.
Diversi sono i terreni della speranza, che ognuno può cercare dove desidera o dove il destino lo conduce: S.Agostino l’ha trovata in Dio; Heidegger la indica nella presenza degli altri e nella condivisione con loro del proprio destino; Bertolini la identifica nel sé - che possiede tutte le potenzialità per scegliere di vedere la vita sotto l’ottica più positiva per andare avanti - che tuttavia per esister, comunque, abbisogna di un altro cui rivolgersi e con cui confrontare la propria visione del mondo.
Pur nella loro diversità, queste tre letture della realtà condividono due elementi comuni che per noi, che operiamo nel terreno dell’educazione, rappresentano uno spunto di riflessione e un oggetto di attenzione peculiare in questo terreno delicato della speranza: sono la fiducia nella capacità di scelta dell’uomo e la presenza dell’Altro.
Per quanto riguarda il primo punto, per ognuno di questi autori la scelta è sempre dell’uomo: è l’uomo di S.Agostino ( che è anche Agostino stesso) che cerca la sua strada nella vita, di Heidegger che si interroga sull’esistenza e sul suo senso, in modo privilegiato come nessun essere vivente, di Husserl che, dotato di coscienza, intenzionalmente si volge all’oggetto di attenzione che lei stessa può decidere. Prima viene l’uomo: l’ “uomo risorsa”, l’ uomo speranza per l’educazione, la quale scommette su di lui, e speranza per se stesso. Ha delle potenzialità a partire dalle quali costruirsi, decidere verso dove indirizzare la propria vita, cammino che non ha deciso di intraprende, ma che può decidere come intraprendere. L’uomo può tutto questo, ma non solo l’uomo “teorico” di questi autori[131], ma l’uomo vero che ognuno è, che l’educando stesso è, imparando a disporsi in questo modo verso la vita non occasionalmente, ma nel quotidiano, anche e, possibilmente, soprattutto di fronte agli imprevisti negativi.
Per quanto riguarda il secondo punto, la presenza degli altri è sostegno e speranza: S.Agostino non è solo nella sua vita, ma, per lui, Dio è pronto ad ascoltarlo, ad accompagnarlo; Heidegger ritiene che nel nulla che circonda l’uomo, una via d’uscita al sentimento di angoscia è l’essere con gli altri, la Cura per i propri simili che rende ragione dell’esistere; Husserl non immagina la coscienza intenzionale se non diretta a qualche cosa, perché per costituirsi ha bisogno di un altro da sé.
Sono terreno di speranza la propria personalità, le proprie capacità e potenzialità, ma anche gli altri, fra cui l’educatore, che possono costituire un aiuto. I messaggi filosofici che provengono dal passato ci trasmettono l’idea che gli altri sono speranza, appiglio, sono qualcuno con cui condividere l’esistenza e con cui farci forza a vicenda per andare avanti. L’uomo senza altri rischia di non vedere il futuro, perché sarebbe un futuro vuoto di senso, senza nessuno che arricchisce la nostra esistenza.
Riflettendo sulla speranza Alberoni ha, in un certo senso, ampliato gli orizzonti kantiani. Kant ritiene che dobbiamo compiere azioni morali spinti dal dovere. Eppure questo messaggio snatura l’uomo, riducendolo a essere intellettuale, razionale, che agisce spinto dalla necessità. Un’altra è la facoltà della persona, più umana, caratterizzata dal sentimento: l’educatore stesso è spinto verso l’altro non per rispondere a un dovere esclusivamente professionale, perché possiede delle tecniche e metodologie acquisite, ma per vocazione, motivazione, desiderio di incontro con l’Altro e anche per affetto.
La relazione d’aiuto deve poter fondare il proprio intervento sulla fiducia nell’individuo e negli altri che sono attorno a lui, con i quali instaurare rapporti affettivi ed educativi, e grazie a questi terreni di speranza aprirsi al futuro.
2.2.2 L’autobiografia: autoriflessione e retrospezione
L’autobiografia è uno degli strumenti qualitativi di cui una branca particolare dell’educazione, l’educazione degli adulti, si serve per aiutare l’uomo a pensare e a pensarsi.
E’ modello formativo per gli adulti, che generalmente più dei giovani, per natura proiettati verso il futuro, tendono a riflettere sul passato. In realtà, però, in un’ottica che supera il modello di tripartizione dell’educazione nelle tre età della vita[132], le pratiche dell’educazione degli adulti possono essere utilizzate anche con i soggetti in età di sviluppo. Una delle sfide educative di questo secolo, infatti, consiste nel valorizzare, indipendentemente dall’età anagrafica, la volontà di cambiamento e di progettazione, la motivazione e la curiosità dell’imparare.
Bruner[133], per sottolineare il rapporto stretto dell’uomo con la parola, afferma che noi tutti esseri umani siamo “narrativi”. Anche Demetrio valorizza questo naturale incessante bisogno dell’uomo di raccontare se stesso, le cose che lo circondano e lo colpiscono, attribuendo all’autobiografia la facoltà di essere “bisogno innato” degli uomini tutti, non solo ontologicamente, ma anche per la storia che fa parte di noi, per la cultura bibliografica e autobiografica della quale siamo discendenti. Le storie di sé trovano i primi autori nel mondo antico, in cui gesta di battaglie, resoconti e appunti venivano scritti per lasciare segno dei propri studi ai posteri, ma anche per lasciare segno di sé come persone. Dietro ai papiri, ai tomi nelle biblioteche, che custodivano i primi saperi umani sistematizzati per iscritto, e perfino dietro ai geroglifici, ci sono stati uomini, che, come gli uomini di oggi, stavano vivendo una loro storia e hanno dimostrato passione per il racconto, la comunicazione, la parola, il disegno, garanzie di sopravvivenza e di evoluzione, tentativi di “innalzarsi”, di esprimere le proprie peculiari capacità.
Le autobiografie, attraverso il tempo, hanno unito gli uomini. Scritte per motivi diversissimi, quali la riflessione su di sé, l’avvicinamento a Dio, il piacere di essere ascoltati e il prestigio, pur essendo nate nella mente dei loro autori in un tempo anche molto lontano dal nostro, vengono ancora lette. Nonostante le diversità, rispetto alla nostra epoca, del tempo e della società di cui scrittori, noti e meno noti, sono stati figli, essi hanno contribuito, forse anche a loro insaputa, a condurci alla scoperta dell’animo umano: è questo il motivo per cui ancora leggiamo le loro storie, con interesse, pur essendovi narrati episodi che non hanno niente a che fare con noi. La ragione per cui quegli autori hanno scritto è la stessa che motiva tutti gli uomini, la tensione anagogica[134], il desiderio di perfezionamento, di elevazione, e miglioramento, conscio o inconscio.
Non sono solo gli adulti a sentire questa spinta, questo desiderio di essere, di dimostrare di essere, ma anche i giovani e coloro che vivono il disagio: l’autobiografia, come strumento che si inserisce all’interno delle pratiche narrativo-riflessive, trae la propria specificità dal fatto di permettere anche a chi ha un vissuto difficile, diverso, problematico alle spalle di narrarsi, realizzando un percorso di “cura” [135]. Il racconto è anche un metodo ricco di valori e motivazioni che hanno dato significato al presente degli uomini, ed è proprio questo il suo ruolo più interessante per la pedagogia.
Per evitare lo smarrimento nell’esistenza, gli individui restano ancorati a quei ricordi del passato che hanno costruito la loro identità e sulla base dei quali anche nel presente, talvolta, continuano a muoversi, come fossero dei veri e propri ineliminabili punti di riferimento. Senza il nostro passato siamo persi, non potremmo mai esserne privati. La vita stessa, pur caratterizzata da continuo cambiamento, si costituisce su una base di continuità che ci permette di riconoscerci rispetto a ciò che siamo stati.
E’ necessario sottostare a una condizione per poterci accostare all’autobiografia: avere ancora la capacità e l’interesse di metterci in gioco e, come afferma Demetrio, “ancora un frammento di passione per la propria esistenza”.
Partendo da queste riflessioni desidero riflettere sia sull’autobiografia come esperienza del raccontarsi dopo aver vissuto, sia sull’autobiografia che diventa biografia quando si colloca nel contesto di una relazione d’aiuto nei confronti di chi non sa o non può raccontarsi.
L’autobiografia come aiuto
L’autobiografia è il racconto della propria vita, la cui stesura può avvenire individualmente oppure nel contesto della relazione educativa, nella quale l’educatore dispone l’educando a raccontare e interpretare alcuni fatti della sua vita e lo guida nella riflessione e coscientizzazione.
L’educatore aiuta a pensarsi, ha la grande responsabilità di far emergere le potenzialità del soggetto e, nello stesso tempo, di renderlo autonomo e padrone di sé. La persona malata, il malato terminale, viene condotto dall’educatore per compiere una riflessione serena e costruttiva sul significato della propria esistenza. Hanno bisogno di aiuto per conoscere in modo non superficiale, non sbrigativo, la propria profonda identità non solo le persone in difficoltà, ma anche coloro che desiderano migliorare, imparare dal passato per potersi proiettare verso il futuro, accostarsi alla propria esistenza guardandola in termini costruttivi e rivalutando - servendosi anche del processo di “significazione” - tutto ciò che di negativo c’è stato o che persiste ancora.
L’educatore si accosta all’educando attraverso l’ascolto, la decentrazione del proprio punto di vista, la disposizione verso l’altro, atteggiamenti che rendono l’autobiografia uno strumento umano di vicinanza fra gli uomini, prima che una tecnica educativa.
E’[136] metodo di ricerca, rientra nei metodi qualitativi con i quali condivide, secondo Benozzo[137], queste proprietà caratterizzanti:
1. Una preferenza per l’uso delle parole piuttosto che per i numeri;
2. Osservazione sul campo;
3. Lo sforzo di vedere le cose attraverso gli occhi degli attori soggetti-oggetti della ricerca, e di ascoltare con le loro orecchie;
4. Comprensione delle azioni nel loro contesto e divenire;
5. La descrizione dei dettagli della situazione, l’esplorazione delle tracce in vista della ricostruzione delle strutture di senso che orientano i comportamenti;
6. Preferenza per il disegno di ricerca non strutturato, aperto e flessibile, idoneo a cogliere l’imprevisto, la scoperta, l’inatteso;
7. L’importanza di non dare nulla per scontato;
8. La rinuncia a utilizzare concetti teorici o ipotesi aprioristiche nelle fasi iniziali; preferenza per i processi di tipo induttivo.
I metodi qualitativi e così la narrazione autobiografica richiedono il coinvolgimento del ricercatore-educatore, la valorizzazione della sua esperienza e del suo punto di vista, preziosi, da una parte, per la comprensione e, dall’altra, per la relativizzazione delle visioni del mondo che l’educando ha sviluppato.
L’autobiografia ha anche una funzione formativa e autoformativa. Formenti sottolinea gli importanti risultati che si possono ottenere attraverso il metodo autobiografico nelle tecniche di formazione:
- metacognitivo: consiste nell’acquisizione da parte del soggetto della capacità di imparare a prendere coscienza delle proprie modalità di pensiero e dei contenuti stessi del pensiero;
- formativo: consiste nella riconnessione al nostro presente della vita già vissuta, conferendoci una “forma”;
- motivazionale: consiste nel rimotivare le scelte che ci hanno condotto a un determinato percorso di vita;
- euristico esplicativo: consiste nel trovare le spiegazioni ai vissuti;
- trasformativo: consiste nel “trasformare” la nostra vita ricorrendo alle motivazioni che ci siamo già dati in passato, ma arricchendole di un diverso e rinnovato punto di vista maturato nel presente.
Prima di essere un testo scritto è esperienza vissuta in prima persona, patrimonio di conoscenze e sentimenti, di saggezza, cammino che ha condotto all’arricchimento personale, ma anche alla stanchezza, all’aver “troppo vissuto”. E’ costruita sulla base del proprio sé, delle proprie riflessioni, degli incontri con le presone significative ma anche casuali. Per Demetrio[138] è insieme di ricordi della propria vita trascorsa, di ciò che si è stati e si è fatto, occasione per riscoprirsi, per sentire che si ha vissuto e che si sta ancora vivendo; per riconoscere i molteplici “io” di cui è costituita la nostra personalità, senza sentirsi frantumati; per contemplarci; per riprendere la vita tra le mani, assumendosi, come segno di maturità, la responsabilità di tutto ciò che si è stati, che si è e che si sarà.
Questo viaggio formativo ha ragion d’essere in quanto arricchimento e coscienza più profonda del presente: è occasione di raccontarsi, essendo ancora curiosi della vita, di esplorarla e di trarne bilanci; per i giovani è tentativo di conoscersi meglio, esplorare il proprio futuro, il proprio progetto di vita, le aspirazioni.
E’ tempo di raccoglimento, di riflessione e solitudine, tempo per sé. E’ anche tempo di cambiamento sia perché, scoprendo alcuni errori del passato, si può desiderare di impegnarsi a non compierli più, sia perché è anche scoperta dei nostri aspetti positivi, emersi nei ricordi di qualche avvenimento dell’esistenza. E’ anche sofferenza e coraggio, perché incontro con un passato lontano, che non torna più; ma una volta accettato il gioco che ci propone la vita, tra continue conquiste e perdite, usciremo da questa esperienza più consapevoli e forti del fatto di avere il potere di allontanare l’oblio attraverso la scrittura.
Demetrio[139] vede l’educazione più che come occasione di cambiamento, come “lampo di autoriconoscimento”, in cui pensarsi e raccontarsi, in un lavoro narrativo: attraverso il racconto di noi stessi agli altri, ci ”possediamo”un po’ di più.
Da una parte viene avviato un processo intersoggettivo e interpretativo, che consiste nel pensare a sé, al proprio modo di essere e ragionare, ricostruendo il nostro passato e riordinandolo, interpretandolo; dall’altra parte, qualora volessimo raccontare la nostra storia, o parte della nostra storia, avvieremmo un secondo processo caratterizzante l’autobiografia, il quale si fonda sulla condivisione. Il fatto di raccontare presuppone la presenza di un interlocutore, che è inevitabilmente portato a dare una sua personale interpretazione dei fatti, ma che soprattutto deve essere disposto all’ascolto e alla comprensione dei significati che noi attribuiamo ad essi. Nell’incontro e nel lavoro di gruppo, per esempio nei laboratori autobiografici, il racconto manifesta la sua duplice valenza, come “prodotto” e come “strumento”[140]. E’ prodotto perché risultato di una riflessione personale che viene offerta agli altri, ed è processo perché attiva un coinvolgimento attivo degli uditori, attraverso il quale si manifesta il carattere “molteplice” dell’autobiografia: scopriamo che l’interpretazione di un’esperienza non è mai unica, ma lascia sempre spazio ad altre. Infatti il nostro scopo non è cercare una lettura a senso unico dei fatti, che sia veritiera, ma quello che importa, nel lavoro interpretativo, è la coerenza con quanto è stato raccontato.
Nelle conversazioni, mettendo a confronto diverse autobiografie e nei lavori di gruppo, si manifesta la dimensione collaborativa dell’autobiografia stessa, il suo versante interattivo che la rende pratica formativa e costruttiva. In alcuni lavori, organizzati dal GRAPA[141], i partecipanti, dopo aver lavorato nel piccolo gruppo e aver condiviso le proprie esperienze bibliografiche, sono invitati a “studiare” il testo di un collega e a presentarlo, arricchendolo del proprio contributo organizzativo-interpretativo. Guardando la propria vita da una prospettiva diversa, il soggetto si “oggettiva” a se stesso, riscopre alcuni aspetti sui quali non ha mai riflettuto prima. L’autobiografia, in questo modo, non diventa solo riflessione sul passato, col rischio di alimentare un sentimento malinconico, di rimpianto, ma diventa apertura verso il proprio presente e verso l’Altro. E’ grazie a un contributo esterno, oltre che ad una personale riflessione interiore, che il soggetto riscopre le proprie qualità, si stupisce del modo in cui è riuscito ad affrontare avvenimenti critici nel passato, e quindi acquisisce nuova speranza nel futuro e in se stesso.
L’educatore stesso non deve lasciarsi troppo guidare dalla speranza, dall’utopia, perché infatti non sempre gli sarà possibile aiutare l’educando ad attribuire un significato positivo agli eventi; in casi più problematici dovrà aiutare a “far fronte al negativo”, puntando ancora sulle potenzialità del soggetto. L’autobiografia diventa, in questo modo, “luogo di incontro”, di “amicizia”, di sostegno, fra educatore ed educando, in cui non viene mai meno la responsabilità grande dell’educatore, consistente nell’ “ampliare” la fiducia del soggetto perché non avvenga semplicemente un incontro a due, ma un incontro produttivo per la personalità dell’educando nel disporlo al rapporto con gli altri in senso lato.
Si apre un canale di lettura più vasto sulle possibilità dell’autobiografia che, infatti, oltre ad avere come fulcro di attenzione il soggetto che si riconosce autore-attore della propria esistenza, è “elemento di educazione alla solidarietà”. Demetrio, nel convegno presso la Facoltà di Scienze della Formazione[142], dopo aver sottolineato l’innegabile valore costruttivo dell’autobiografia come occasione di riscoperta degli elementi cruciali della propria esistenza e come “lavoro su di sé”, ha sottolineato il ruolo dell’autobiografia come solidarietà nei confronti degli altri e la possibilità/necessità di impiegarla anche nel campo del volontariato.
Tre sono le interpretazioni che, in quel contesto, sono state date del concetto di solidarietà:
- la sua derivazione da “solido”, a testimonianza del fatto che è una pratica rassicurante, che aiuta a ricondurre i fili della propria vita;
- da “sole”, nel senso di rischiaramento, sottrazione all’ombra, perché l’autobiografia non dev’essere “pratica aristocratica”, strumento privilegiato di chi sa scrivere o di chi ha la forza umana di raccontare ancora il proprio vissuto: è necessario aiutare a consolidare il percorso esistenziale anche di chi non sa scrivere. L’autobiografia è lungi da qualunque forma di discriminazione;
- da “solitudine”, perché permette di imparare o esercitare la capacità di essere soli.
Sulla base di questo contributo, si scoprono molteplici “direzioni di senso dell’autobiografia”, molteplici obiettivi da realizzare, nell’incontro. La relazione d’aiuto diventa un campo di intervento nel quale poter applicare questa pratica, per aiutare il soggetto che vive nel disagio a guardarsi comunque o, in generale, per arricchire la vita dell’educando – chiunque sia - di speranza, perché possa realizzarsi totalmente in quanto uomo, con la sua eticità, con il suo diritto a fare esperienze e a scoprire l’esistenza sotto un’altra luce, magari più positiva di quella da lui personalmente elaborata.
Un esempio significativo di applicazione di tale pratica - riguardante un campo dell’educazione già in precedenza trattato - riguarda l’anziano, al quale può realmente garantire pieno rispetto della sua dignità umana: l’autobiografia permette all’anziano di ri-esprimersi, di lasciare un segno anche agli altri di tutto quello che ha visto e imparato nel corso dell’esistenza. Viene avvalorata, in questo modo, la dimensione più comunicativa dell’autobiografia stessa che recupera la visione antica sia della persona anziana come portatrice della saggezza della vita - non da allontanare negli istituti di ricovero -, che della trasmissione del “sapere” non didattico, ma relativo all’esistenza, attraverso le parole, il dialogo.
Un altro campo di applicazione del metodo autobiografico è rappresentato dal lavoro con i soggetti disabili[143].
Giusti afferma che in questo caso - come in generale in tutti riguardanti persone a contatto con le difficoltà della vita - la scrittura ha una responsabilità pedagogica. Tre sono i motivi che spiegano quest’affermazione: aiuta il soggetto a comprendere (-comprendersi); attiva il cambiamento; è mezzo di comunicazione. L’autobiografia, dando voce al pensiero, diventa mezzo per intervenire sulla realtà, che non può essere cambiata, ma interpretata a seconda del significato che le si attribuisce. Ancora una volta dimostrando l’errore dell’affermazione che vede questa pratica come un percorso di ripiegamento su se stessi, facendo riferimento come esempio al caso dei soggetti handicappati si può dimostrare, al contrario, il suo valore sociale e di apertura al mondo. Attraverso l’autobiografia il soggetto conosce sé e, nel contempo, il mondo degli altri:
“ Per chi è handicappato l’apprendimento incomincia a partire dal deficit, e così la conoscenza del mondo sembra avere inizio da dietro le quinte dell’esistenza, come da un luogo dove gli atti del vivere sono come invisibili alla maggioranza delle persone” [144].
Attraverso la scrittura l’educando impara a uscire allo scoperto, a vedere l’esistenza non più da dietro le quinte, ma come protagonista che dimostra il diritto di essere regista e autore della vita stessa, anche se di una vita che per gli occhi della gente “manca di normalità”. L’autobiografia può diventare mezzo sociale attraverso il suo passaggio a biografia, ma anche nel momento in cui viene semplicemente letta dall’altro. Giusti parla di “ricerca della scrittura da condividere con gli altri”, perché proprio nella condivisione si scoprono ”orizzonti comuni”, la possibilità di essere assieme e, dall’altra parte, di disporsi a ricevere il mondo in se stessi. Non è un lavoro assistenziale, unicamente di “cura”, ma un lavoro pedagogico che intende modificare l’esistente. La scrittura si dimostra mezzo “proteso da se stessi verso gli altri”.
C’è un presupposto che rende possibile al soggetto handicappato la fruizione del potenziale arricchente e positivo dell’autobiografia: la volontà-capacità-disponibilità ad attraversare una storia, la propria, anche nei suoi momenti più delicati,difficili da mettere a fuoco e allo scoperto. Superato questo ostacolo sarà possibile capire che si può evolvere, si può migliorare: “è dunque possibile arrivare a comprendere che è presente, anche nelle situazioni più difficili, il desiderio di esistere, più forte della volontà di cancellarsi, di scomparire nel nulla”.
Duplice è il risultato cui perviene il soggetto nella stesura autobiografica o biografica, perché non solo riesce a documentare e testimoniare la condizione di isolamento e di solitudine in cui si trova, ma si situa anche contro tale condizione:
“ La parola scritta diventa spazio possibile di frontiera fra il dentro e il fuori, striscia estrema del movimento di uscita e di entrata fra la nostra interiorità più nascosta e l’estraneità che comprende l’Altro e dunque anche noi stessi” [145].
L’educatore deve aiutare il soggetto handicappato, ma anche il soggetto in generale, a impossessarsi degli strumenti di significazione del mondo, a partire dai quali leggere, nella prospettiva della possibilità del superamento, la propria difficoltà. L’autobiografia si propone in questo senso come pratica della pedagogia della speranza, che aiuta nella strutturazione dell’identità, stimola la riflessione e aiuta ad affrontare il ricordo dei momenti negativi.
Il testo che Giusti scrive non è solo un contributo teorico, ma nasce e si sviluppa dalla pratica, dalla ricerca. Per capire la problematica dell’handicap e studiare come questa venga, per quanto possibile, positivamente affrontata studia sei testi[146] di riferimento, scritti da persone personalmente colpite dall’handicap, dei quali ripropone stralci e principali tematiche. Le più frequenti sembrano essere la forza, “la tenacia dei protagonisti nell’affrontare e nel superare le difficoltà”; le reti di collaborazione e di solidarietà attorno al protagonista disabile, che incidono positivamente sulla sua formazione; l’indiretto contributo nel favorire un mutamento della mentalità comune, tendente a vedere i “diversi” come portatori di silenzio più che di “senso”.
L’autobiografia facilita l’ “auto-apprendimento continuo, doloroso, forzato”, che è però anche occasione di ri-formazione, per ritrovarsi, riconoscersi e soprattutto ricostruirsi, anche dopo le sconfitte. Giusti definisce il processo di apprendimento come processo indispensabile per “giungere a considerare i propri deficit come momenti ineludibili della costruzione di sé: allo stesso tempo limiti apparentemente invalicabili e punti di partenza per superarli”. L’autobiografia assume il significato di stimolazione alla responsabilità: il soggetto handicappato, in quanto soggetto umano che vive e che può “sentire di vivere” assumendosi la responsabilità di conoscersi, di “mettersi a fuoco”, si riserva anche la responsabilità di raccontarsi.
La lettura dell’autobiografia, così come viene proposta da Giusti, è una grande lezione pedagogica, perché dimostra la possibilità di apprendimento in un “duplice” caso estremo, nel deficit e nella solitudine, partendo da quest’ultima:
“…lo spettatore “dislocato” a cui non è stata prestata la giusta attenzione, che non è stato tenuto nella dovuta considerazione, prova a mettersi in gioco, prova a dire la sua, non si limita ad accogliere lo spettacolo ma intende lavorare all’interno di esso. Dobbiamo vederlo come un funambolo spericolato? Forse. Come un dilettante che non è consapevole di darsi in pasto a un pubblico impietoso? E’ probabile. Ma nonostante ciò sceglie di essere presente anche lui sulla scena, come gli altri, con gli stesi rischi, ma anche con le stesse possibilità di applauso “ [147].
Questa decisione che trova origine nella solitudine, vede anche in essa il senso per percorrere tutte le tappe dell’esistenza. La solitudine, luogo e tempo della non-vita, dell’esclusione, del silenzio diventa possibilità di incontro con l’altro. Nella scrittura non viene espressa per essere sfogo, denuncia, lo può anche essere, ma è soprattutto “lavoro ragionato”, di comprensione e celebrazione del proprio essere al mondo.
“ Il messaggio pedagogico contenuto in questi libri, dunque, pare essere il seguente: bisogna attraversare la propria storia, rivivere la durata interminabile dei suoi momenti più difficili, partire dalla percezione della propria condizione di solitudine, servirsi del linguaggio, che va ad incastonarsi in quella percezione, per arrivare a capire che è possibile procedere, evolvere, migliorare, rappresentare la voce e la solitudine stessa, anche quella di altri che voce hanno “ [148].
2.3 CRESCITA RECIPROCA
2.3.1 Il lavoro dell’educatore
Prima di addentrarci nella riflessione specifica sul coinvolgimento nella relazione d’aiuto, è necessario cercare di capire un po’ più da vicino il “mandato” dell’educatore - per riflettere successivamente sul dibattito circa l’opportunità o meno del “partecipare educativo” -, ripercorrendo alcune serie di immagini ricavate dalla letteratura pedagogica.
La prima riguarda la definizione stessa di educazione:
Nella seconda serie di immagini, vengono esplicitate delle metafore, che servono, da una parte, per rimandare all’educatore un’idea di come egli venga generalmente visto dalla società, dall’ altra, nello stesso tempo, rappresentano un ammonimento contro i rischi dell’educare. L’educatore è:
De Natale[150] sottolinea quanto siano stati importanti i provvedimenti che nel corso degli anni ’70 hanno responsabilizzato la società tutta in merito alla formazione del bambino: dallo Stato le competenze sono passate progressivamente agli enti locali, più vicini ai bisogni specifici del territorio e dei soggetti che lo abitano. Nello stesso tempo afferma che i bisogni dell’individuo non si esauriscono in quelli soddisfatti dalle istituzioni sociali (campo d’intervento dell’educatore), ma anche in quelli realizzati dall’insieme delle reti cui appartiene l’individuo;
E’importante che il fondamento del lavoro educativo, invece, sia prima di tutto l’impegno, la forza di reagire alle
situazioni di rischio e consista nel contare su fondamenti solidi che lo sollevino dall’incertezza;
Santerini richiama alcune metafore utilizzate dalla maggior parte degli educatori per descrivere il proprio lavoro:
In conclusione un’ultima immagine riguarda il concetto di holding (Winnicott). L’attività di holding richiama l’atteggiamento della madre che regge il bambino, come modello primario di qualunque intervento d’aiuto. Comporta due implicazioni: in primo luogo la presenza e vicinanza fisica, e, oltre a ciò, non da meno, il sostegno psicologico.
Anche l’educatore si comporta allo stesso modo nei confronti dell’educando, perché gli è costantemente vicino, sia in senso fisico, sia come supporto, guida, sostegno. Questa disposizione è premessa alla realizzazione di una serie di obiettivi chiave della relazione educativa: permette di aiutare ad affrontare più realisticamente i problemi, rappresenta un supporto all’autostima, è garanzia e dimostrazione di disponibilità e continuità dell’incontro.
Avendo in mente queste immagini che riflettono speranze, rischi, ma anche la realtà dell’educazione, possiamo addentrarci a comprendere con spirito più critico-valutativo il lavoro dell’educatore, chiedendoci se sia possibile parlare di “educazione distanziata”, o se, al contrario, non sia auspicabile un’ “educazione partecipante”.
Ci tengo ad anticipare come forse le riflessioni appena accennate portino più verso la seconda strada. Prima di dichiarare se sia quella giusta, è necessario, però, nel corso dei prossimi paragrafi, valutare anche pro e conto del coinvolgimento.
2.3.2 Il coinvolgimento dell’educatore
Il coinvolgimento rappresenta il lato positivo e negativo assieme dell’agire educativo. In primo luogo, è la condizione alla quale si realizza il dialogo nell’incontro: la dimostrazione di interesse, la disponibilità nei confronti dell’Altro, di quello che è e di quello che dice, allontanano il rischio che la parola diventi narcisistica affermazione di sé. Il presupposto per l’esistenza di una relazione, infatti, è la partecipazione, l’ascolto autentico. In secondo luogo, però, richiede impegno e partecipazioni tali da rischiare, all’estremo, di far perfino perdere i confini fra l’io e il tu.
E’ possibile e necessario spezzare una lancia a favore di entrambi i versanti, coinvolgimento e distacco.
L’educatore è realmente coinvolto nella relazione d’aiuto, perché questa porta delle implicazioni concrete nella sua stessa vita, la vive con empatia non solamente perché è un atteggiamento auspicabile per il buon esito dell’intervento e perché l’educando possa fidarsi e sapere di poter contare su un punto di riferimento stabile. Se questo fosse l’unico motivo, calcolato, razionale, che spiega l’atteggiamento dell’educatore come “cortesia” o “dovere”, non si potrebbe parlare di “autenticità” nei termini buberiani, ma di obbligo, di posa, fino a rischiare l’opportunismo. Invece l’educatore stesso, nella relazione d’aiuto, cresce.
Considerare che nel processo di arricchimento, maturazione, cambiamento siano coinvolti entrambi gli attori della relazione d’aiuto non è un fattore di marginale importanza, anzi, risulta fondamentale per ristabilire equilibrio nel rapporto educativo. Generalmente, infatti, si tende a vedere solo il contributo che il soggetto più preparato dà all’altro; è necessario riflettere sul potenziale positivo di crescita che, invece, entrambi ugualmente portano con sé.
Anche all’educando, ragionando in questi termini, si attribuisce un grande potenziale educativo e dignità: l’aiuto è il momento in cui chiede qualcosa, sicurezza, protezione, sostegno, occasioni di crescita, ma anche dona qualcosa di sé, si dona. Ogni persona che incontriamo, nel corso dell’esistenza, infatti, ci arricchisce, qualunque sia il suo ruolo e la sua posizione sociale. E’interessante precisare fin da subito che la Santerini ritiene eccessiva la preoccupazione manifestata in campo pedagogico relativamente al coinvolgimento dell’educatore:
“L’insistenza sulla sindrome da burn-out, cioè sul rischio da parte dell’educatore di “bruciarsi” nella relazione investendo troppo tempo ed energie senza un adeguato calcolo delle risorse, i frequenti richiami alla necessità di una distanza nei confronti delle persone da educare, la minuziosa prescrizione delle regole della negoziazione, mostrano cautela e diffidenza con cui spesso si guarda alla relazione educativa, intesa come sintesi di libertà e responsabilità.
(...) quasi ad esorcizzare l’imprevedibilità di una relazione che cambia non solo chi è educato, ma anche chi educa” [151].
E’ anche vero, però, che essere troppo coinvolto vuol dire perdere di riferimento la separazione fra sé e l’altro, vuol dire dimenticare il proprio ruolo, punto di riferimento inevitabile per continuare il proprio compito di educatore.
Anche nella relazione d’aiuto è bene saper trovare il giusto mezzo, la via che, senza eccessi, conduca alla meta che ci si propone. Nessuno ci potrà dire a priori quale sia la scelta giusta da fare, ma l’esperienza, la competenza e la capacità riflessiva maturate potranno essere i migliori consiglieri dell’agire educativo.
Gli autori del testo che ho scelto come riferimento per la lettura del coinvolgimento nella sua dimensione negativa affermano che
“Normalmente, ci si chiederà, in alcune professioni è necessario mantenere un interesse distaccato (medici), ma il distacco e l’interesse non si miscelano molto facilmente, non hanno confini ben definiti e l’individuo continua a tendere ora verso l’uno ora verso l’altro” [152].
2.3.3 Burnout
La sindrome da burnout o dell’ ”essere bruciati” è una patologia occupazionale, conseguente a una situazione di stress prolungato e intenso, tipica delle helping professions, ossia delle professioni dedite all’aiuto.
Quando l’individuo non riesce più ad affrontare in modo costruttivo le situazioni di stress che l’ambiente gli propone, scivola a poco a poco in una forma di adattamento patologico di tipo difensivo, che a lui sembra essere la migliore strategia di difesa. In realtà questa rappresenta soltanto una “fuga patologica”, non reale.
Secondo quanto afferma Pines[153], “la condizione umana è di per sé stressante e lo stress non può essere evitato”. Indubbiamente anche se l’uomo è portato per natura a far fronte agli eventi disadattanti, tuttavia non può essere questa la condizione abituale nella quale si deve muovere: alla lunga, la tensione causa l’alterazione dell’omeostasi e diventa intollerabile.
La parola stress deriva dal latino strictus, cioè stretto, serrato, compresso. E’ stato a lungo utilizzato nel linguaggio della metallurgia: in questo campo si era soliti mettere sotto tensione le travi metalliche per provarne l’effettiva resistenza. Anche l’uomo vive tale condizione quando un sovraccarico di stimoli comportano il suo scompenso psico-fisico. Lo stimolo genera le reazioni di adattamento dell’organismo, le quali possono determinare un esito positivo, consistente nel superamento della nuova condizione, oppure un esito negativo che determina lo sfociare del burnout.
Il burnout non è sinonimo di stress, ma rappresenta la risposta dell’individuo alle situazioni di stress negativo. E’ implicito il fatto che esista, quindi, uno stress positivo, che invece di inibire le risposte dell’individuo, gli dà spinta e motivazione per andare avanti: a volte di fronte agli insuccessi o al pericolo si tirano fuori tutte le energie e le capacità che altrimenti in condizioni normali resterebbero nascoste. Lo stress negativo, al contrario, non comporta nessun vantaggio all’organismo, ma lo mette in agitazione, creando una condizione assolutamente priva di valenze riattivanti. La situazione critica non è stimolo, ma fattore opprimente.
Selye individua tre stadi nella risposta dell’individuo alle situazioni critiche: la reazione di allarme, in cui da subito compaiono i fenomeni di difesa; l’adattamento, che è una capacità che l’individuo può sviluppare solo a breve termine; l’esaurimento, in cui si hanno alterazioni permanenti. Ha dimostrato scientificamente che lo stress determina un’alterazione nell’organismo che non è solamente psichica, ma è anche fisica e prende il nome di “cicatrice chimica”: aumenta l’adrenalina, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca. Il sistema di reazione fisiologica, pur essendo un segno ereditato della vita dei nostri antenati, radicato nella razza umana, sembra non essere adatto alla vita che conduciamo noi uomini dell’età contemporanea, perché oggi l’impegno di vita richiesto non è più di natura fisica[154], bensì di tipo relazionale-psicosociale.
Fridman e Rosenman, due cardiologi americani, dimostrano addirittura, in seguito a diverse ricerche, che lo stress ha una qualche incidenza sull’infarto. In realtà non è un’equazione valida per tutte le persone, ma sembra almeno per coloro che manifestano un comportamento caratterizzato da competizione, intraprendenza, aggressività, rapidità nel lavoro, impazienza, irrequietezza.
Pare abbia ragione, in questo senso, Selye il quale definisce lo stress non come aggressione esterna subita dall’organismo, ma come “effetto di un’interazione necessaria fra individuo e ambiente”. E’ l’ipotesi più rispettosa del presupposto pedagogico - di cui ho scelto come rappresentante Bertolini, citandolo precedentemente -, che ritiene si debba riflettere sull’uomo, valorizzando la sua capacità di “significazione”, non considerando agisca semplicemente in risposta agli stimoli ambientali. Anche il pensiero di Lazarus, nella riflessone sullo stress, si pone in linea con questo pensiero: il rischio, così come viene percepito dal soggetto, è il risultato della valutazione del danno potenziale - che l’individuo ritiene possa derivare dalla situazione di minaccia - in rapporto alle proprie capacità.
Si deduce che lo stress, che è risultato del rischio percepito, non è un fattore oggettivo, ma può addirittura esistere o meno, a seconda del soggetto, del suo modo di leggere la situazione, dell’umore in quel momento, delle energie disponibili. Più volte si è riflettuto sull’estrema varietà che caratterizza gli uomini e in ogni argomento pedagogico è necessario ribadirne il concetto, che è chiave per una lettura corretta e completa della realtà. Non solo persone diverse leggono la realtà in modi svariati tra loro, ma anche la stessa persona può manifestare reazioni completamente diverse da un momento all’altro, o da un periodo all’altro, di fronte ai fattori stressanti.
Il burnout si verifica quando la persona si sente esaurita, sente di non poter alleviare la situazione e si radica nello stress, determinando squilibrio nel rapporto richieste-risorse. I mezzi che vengono attuati per difendersi dall’esterno sono inadeguati: il ritiro, il distanziamento che, utilizzati per riprendere le energie, favoriscono l’insorgenza del senso di colpa, di inadeguatezza a far fronte alle situazioni, quindi scoraggiamento, ritiro definitivi, fino all’indifferenza e al disinteresse.
Il soggetto perde le qualità essenziali per il successo, quali l’entusiasmo, l’ottimismo, il coinvolgimento personale.
Le tre dimensioni che caratterizzano il burnout sono state individuate da Maslach e da Edelwich - Brodsky. Secondo il primo sono:
Per Edelwich e Brodsky il sé professionale attraversa quattro stadi di evoluzione:
E’auspicabile, secondo questi ultimi autori, intervenire almeno a partire dal secondo stadio, ma possibilmente attuare un lavoro di prevenzione.
Fra le interpretazioni - cui Magro e Rossati fanno appello per spiegare che cosa provochi il burnout - rappresentate dalla psicologia dell’apprendimento, dall’approccio clinico-psicoanalitico, sociologico e psicosociale, ritengo sia rilevante, nel nostro contesto, riflettere sulle prime due, che rivolgono uno sguardo particolare al modo di sentire del soggetto, tuttavia senza dimenticare la rilevanza dell’ambiente e della società.
Secondo l’interpretazione della psicologia dell’apprendimento, l’uomo, trovandosi ripetutamente nella condizione di impotenza, rischia di sviluppare la così chiamata “impotenza appresa”: “gli esseri umani, nella costruzione delle proprie aspettative, si basano spesso sull’intuizione, utilizzando per lo più regole approssimative o, anche, si lasciano sviare da opinioni e convinzioni preesistenti, invece di compiere una precisa valutazione della situazione attuale”. In questo senso è necessario che l’educazione sviluppi a maggior ragione il proprio compito, che consiste nel rendere il soggetto conscio delle proprie possibilità di incidere sulla realtà, valorizzando il protagonismo di ognuno nella propria vita.
Nella seconda prospettiva clinico-psicoanalitica, in una linea di riflessione già intuita da Freud, si sottolinea la capacità umana di rifiutare ciò che è percepito come “cattivo”: l’uomo si “automutila” per evitare di vivere l’esperienza dolorosa. La funzione che esercita la madre per il bambino è di offrire, a lui che ancora non le ha, le proprie capacità di costruzione del pensiero e di trasmissione di significato, cercando di insegnare il senso delle difficoltà e di farle superare. Anche l’educatore lo deve fare con l’educando, che viene aiutato e viene istruito nell’attuazione “accompagata” di queste capacità, fino alla loro acquisizione autonoma. Imbasciati chiama proprio “autonomia” la capacità di allontanare le esperienze troppo frustranti e dolorose.
Oltre a quelle tecniche, come l’automutilazione appena citata, che naturalmente l’uomo utilizza come “mezzi di riparo”, “di salvezza”, ne esistono anche alcune, individuate nel testo “Stress e burnout”, che possono essere apprese per evitare, a livello non più inconscio ma conscio, di ricadere nella sindrome: vengono distinte in individuali, organizzative e istituzionali.
L’ideale sarebbe un’interazione fra queste, per garantire un ambiente di lavoro che preservi dal “bruciamento”. Secondo alcuni autori, è difficile promuovere nell’individuo un cambiamento del modo di affrontare la realtà e di problematizzare, perché in lui sono già radicati dei precisi atteggiamenti. La soluzione consisterebbe nel favorire, invece, un cambiamento dell’ambiente di lavoro e del modo di lavorare, favorendo occasioni di confronto e di apertura con i colleghi, facendo forza sulle reti di cui fa parte l‘individuo, valorizzando la loro funzione di sostegno.
Ritengo che il punto di vista inequivocabile dal quale trattare la questione sia quello dell’educatore e che sia egli “risorsa per se stesso” per prevenire il burnout: nell’attesa che si mobiliti verso il cambiamento tutto l’apparato che sta attorno all’individuo, è l’individuo stesso che deve trovare le prime urgenti soluzioni. Nella speranza che effettivamente la società si adoperi per garantire la tutela della nostra professione, attribuisco valore primario alla prima tipologia di tecniche citate, quelle individuali, chiamate anche “strategie di coping”:
- il rilassamento,
- la “decomprensione”,
- gli impegni esterni,
- la dimensione spirituale,
- l’equilibrio.
Rendendo noto il rischio, che le helping professions corrono, e anche le tecniche, che possono essere attuate personalmente per prevenirlo, viene già realizzato un importante lavoro di prevenzione. L’obiettivo più importante che conduce a parlare di burnout, infatti, non è assolutamente rappresentato dallo spaventare gli educatori che si dispongono a intraprendere la relazione d’aiuto, ma dall’esplicitazione di tale problematica. Rischiare il burnout non è sinonimo di “essere destinati al burnout”; riflettere su di esso è cercare di esserne consapevoli e fare in modo di evitarlo.
Ancora una volta la riflessione si dimostra importante strumento umano e professionale.
3 L’AGIRE EDUCATIVO.
Dalla teoria all’intervento dell’educatore
In una prima parte del capitolo vengono definite le questioni più tecniche del fare educativo, che per la loro diversità vengono distinte dalle qualità umane richiese all’educatore: tutte rientrano nel quadro delle competenze, ma ho deciso di connotare in modo chiaro le seconde, che rappresentano l’argomento di maggior interesse, denominandole diversamente: sono i “valori” di riferimento dell’educatore. Tale termine fa trasparire l’implicazione della pedagogia non solo con una professionalità di tipo tecnico-metodologico, ma anche con una professionalità che richiede competenze relazionali, comunicative insite nella natura umana e orientate nel campo dell’aiuto in modo consapevole e intenzionale.
3.1 LE COMPETENZE
3.1.1 La progettazione
Progettare è un’azione razionale, decisa, stabilita; improvvisare è l’azione apposta, dettata dall’istinto, dall’ispirazione momentanea, spontanea.
Nel capitolo seguente si chiarirà che la pedagogia si colloca a metà strada fra teoria e prassi e questa affermazione può essere la chiave di lettura per capire in che misura progettazione e spontaneità assieme costituiscono l’atto educativo: la progettazione è il piano predisposto per essere calato nella pratica, ma è, al contempo, passibile di miglioramento, nel momento in cui coglie spunti e modifiche dalla pratica stessa.
E’ necessario, infatti, che la progettazione non sia applicazione meccanica e indifferenziata uguale a se stessa nel corso di qualsiasi iter pedagogico, ma sia flessibile e permetta di leggere, nella situazione sulla quale si deve intervenire, quelle caratteristiche distintive, originali, uniche. Progettazione non vuol dire definire tutte le coordinate di intervento, ma fare in modo che le azioni siano mirate ad uno scopo da perseguire nel corso della relazione, ma anche da modificare e riorientare.
L’ambito dell’educazione definito per eccellenza “scienza progettuale” è la didattica. Da una parte insegna a dare uno sguardo al dettaglio, al caso specifico; contemporaneamente, quello stesso episodio guardato da vicino dev’essere inserito nell’ampiezza dell’orizzonte entro cui acquisisce significato, nel contesto.
Rogers sottolinea che l’agire dell’uomo è caratterizzato da un continuo passaggio dall’esperienza singola all’intero nostro percorso vitale. Questo processo non solo ci permette di connettere il fatto alla totalità della vita soggettiva, ma anche di reinserirlo in un contesto di significato globale, che fa da sfondo alla nostra storia e che abbiamo scelto di seguire.
Il progetto è intenzionale, nel senso che l’ obiettivo cui è finalizzato e verso cui esprime tensione è scelto consapevolmente. Il compito dell’educatore, però, non si sofferma a definire la direzione della relazione d’aiuto, ma consiste anche nella sua realizzazione. Ogni ambito educativo esprime un orientamento preciso verso il futuro e implica un forte senso di responsabilità in ordine all’attuazione dei propositi progettuali.
Riflettendo sul progetto si possono definire quattro componenti[156]:
- pedagogico-valoriale, esplicitata nella dimensione finalistica: il progetto implica delle prese di posizione, delle scelte;
- contenutistica, in quanto il progetto si fa in ordine a “qualcosa”, non si muove nel generico;
- organizzativa, perché richiede l’esplicitazione e definizione di tempi, spazi, risorse, ruoli;
- metodologica, richiede di identificare le operazioni concrete da svolgere sul campo.
Il progetto non fa parte solo della fase iniziale dell’intervento, in cui è formulato a partire dall’analisi dei bisogni/situazione, dalla definizione degli obiettivi, dall’individuazione di mezzi-risorse-tempi-spazi, ma viene modificato, arricchito, valutato, ri-orientato e richiede una verifica costante, dal momento in cui tutti gli aspetti precedentemente elencati possono variare.
Per costruire un progetto è necessario rispettare dei criteri base o principi
- di realtà: cogliere la concretezza delle situazioni, non credere di poter avvicinare la situazione concreta a quella ideale;
- di razionalità: nel progettare essere sempre consapevoli di quello che si sta facendo, avere la capacità di prendere decisioni, riflettere, rendersi conto della personale responsabilità;
- di intenzionalità: il termine intenzionalità implica la presa di coscienza che l’intervento è orientato al futuro e al cambiamento;
- di intersoggettività: è richiesta una “pluralità” di competenze, di punti di vista, quindi anche una mentalità flessibile.
L’educatore stesso per compilare un progetto deve possedere dei requisiti precisi:
- capacità progettuali, in ordine al fare e prima ancora al pensare orientato, critico, riflessivo per coniugare il presente e il futuro e per “giocare” nel campo del possibile;
- atteggiamento di ricerca, apertura al nuovo, al cambiamento, alla verifica, al superamento della routine;
- impegno collaborativo, sforzandosi di condividere, di discutere assieme all’equipe, presentando il proprio punto di vista non come il solo possibile, ma trovando uno sbocco comunemente accettato, arricchito di tutti i diversi contributi;
- capacità decisionale, implica avere capacità valutativa e riflessiva per compiere delle scelte, fondandosi su criteri di riferimento solidi, ma flessibili;
- capacità tecnologica, conoscenze tecniche, professionali.
3.1.2 Interdisciplinarieta’ e approccio olistico
L’educazione garantisce un intervento necessariamente ricco di proposte e strumenti, per comprendere nel migliore dei modi possibili la complessità della natura umana. L’educatore deve disporre di un requisito indispensabile rappresentato dall’interdisciplinarietà, per leggere l’uomo da diverse angolature. Nella relazione d’aiuto deve far tesoro del contributo dei saperi provenienti dalle diverse discipline, che costituiscono le competenze professionali. Miodini e Zini[157] danno una loro interpretazione, indicando quelle:
· Pedagogiche: la considerazione che sta alla base di queste competenze riguarda la certezza che l’individuo possa e debba cambiare. L’educazione, infatti, si propone di accompagnare e aiutare la persona lungo il suo processo evolutivo. Da una parte è l’esperienza stessa che spontaneamente fa cambiare l’individuo, e questo è un processo insito nell’esistenza umana; dall’altra, esiste un’educazione programmata, in cui l’educatore professionale riveste il ruolo di guida con il compito di far affiorare le potenzialità individuali;
· Psicologiche: questo genere di competenze risulta indispensabile per leggere dentro l’educando o per esplicitare, individuare e dare un nome ai suoi disagi;
· Riabilitative: l’educatore deve saper riconoscere il bisogno di aiuto e predisporre degli interventi specifici, di tipo manuale-operativo (lavoro pratico), intellettuale (recupero delle capacità cognitive), psicologico.relazionale (che sviluppi la capacità dell’individuo di definirsi e comunicare), espressivo-creativo (che lo conduca a elaborare nuove idee);
· Animative: l’animazione consiste nell’organizzare le svariate attività di tempo libero, come drammatizzazione, feste, programmazione di gite, attività sportive, avendo in mente l’obiettivo di aiutare il soggetto a esprimersi, liberare la fantasia, avere un’immagine positiva di sé;
· Culturali: l’educatore deve padroneggiare materiale per poter progettare nuovi interventi di carattere “culturale”: letture, cineforum, spettacoli, visite a musei, iniziative naturalistiche;
· Sociologiche: dal momento in cui l’educatore agisce nella complessità, deve intervenire nei confronti dell’utente rivolgendo anche particolare attenzione al suo contesto familiare, alle relazioni che instaura con altri significativi, all’ambiente, all’intero sistema di riferimento.
La pedagogia, fra tutti questi saperi, ha un ruolo preminente, ha funzione di sintesi, di equilibrio. E’ ”terreno d’incontro” , che si propone come primo principio la salvaguardia dell’uomo.
Si può affermare che le discipline siano “occhiali”, “griglie interpretative” attraverso cui guardare la realtà, che si presenta diversa agli occhi dell’educatore a seconda egli la osservi da una o dall’altra prospettiva. Per non smarrirsi nel mare delle interpretazioni sull’essere umano, è necessario l’educatore si prospetti un punto di vista peculiare, quello pedagogico, da arricchire, a seconda delle necessità, con psicologia, sociologia o antropologia. La pedagogia, scienza dell’uomo, non può non dialogare con tutte le altre scienze che hanno il suo medesimo oggetto di attenzione, per questo motivo la posizione dell’educatore è “privilegiata”: parte da una concezione dell’uomo “ricco”. Ciascuna prospettiva disciplinare può abbracciare una parte della verità e il compito di chi opera in educazione è “mettere assieme” i frammenti per comporla nella sua totalità.
Il motivo per il quale l’educatore non perde mai la fiducia nell’utente si spiega per il fatto che ha alle spalle un’idea dell’uomo come essere potenziale visto dal diverse prospettive delle scienze umane. L’educatore deve poter far conto su un bagaglio culturale più ampio possibile, sull’esperienza, sulla professionalità, sulla sensibilità, sulla capacità di entrare nel caso. Tutte le sue capacità e le teorie sono utilizzate per meglio capire l’educando e la situazione problematica che egli gli propone di affrontare assieme.
Questo paragrafo vuole partire dal presupposto sia indispensabile un’ “alleanza” fra le varie discipline, per meglio comprendere l’uomo, ma vuole anche mettere in guardia dal rischio di perdere, nella complessità, la meta prima di ogni intervento educativo: l’interesse nei confronti dell’educando. La relazione d’aiuto si rivolge all’uomo della cognizione, delle diverse intelligenze[158], della memoria, dei ricordi, dei sentimenti, del benessere fisico e psichico, della speranza e della rassegnazione, della paura di cambiare. Tanti sono i modi di essere umani quanti sono i campi di attenzione dell’educazione, però l’uomo rimane sempre “unico”. In lui si nasconde unicità assieme a varietà e nessuna di queste dimensioni deve essere trascurata: di entrambe si dovrà tenere conto, senza scadere nella semplificazione, né, all’opposto, nella dispersione.
La relazione d’aiuto è un intervento nei confronti della globalità della persona, superando il rischio della frammentazione dell’uomo.
Rovetto[159] ritiene fondamentale richiamare l’attenzione sull’unità dell’intervento, in particolare a proposito dell’azione educativa nei confronti dei soggetti che presentano handicap, dei quali si occupano contemporaneamente diverse figure: terapeuta, educatore, medico, i genitori. Il rischio è interventire in modo scoordinato, settorializzato, dimenticando che il soggetto handicappato ha anche una vita emotiva-affettiva, e che non solo le tecniche sono responsabili del suo recupero.
Il soggetto con ritardo mentale non presenta deficit solo nell’apprendimento-comportamento, ma ha una complessa realtà psicologica, fatta di emozioni, rapporti interpersonali, pulsioni sessuali, aspettative, convinzioni, compromessa dagli effetti del deficit. E’ certamente utile garantirgli un aiuto su diversi fronti, ma bisogna anche capire che si ha a che fare con un essere umano da rispettare e aiutare, inserendo ogni lavoro su di lui nel contesto di un approccio educativo più ampio. Bisogna tener conto che un approccio inefficiente
rischia di non garantire il recupero.Il compito dell’educatore è anch’esso globale: non si può risolvere il problema di un soggetto ritardato insegnandogli a leggere o mangiare autonomamente, ma bisogna assicurarsi che vengano acquisite tecniche da generalizzare a più contesti.
Il globale viene inteso quindi in due sensi: lavoro coordinato dei diversi specialisti e prospettiva di generalizzazione nell’ insegnamento delle azioni al soggetto.
L’intervento dev’essere efficace, tecnicamente valido, tener conto delle diverse dimensioni dell’essere umano. Lazarus propone di prendere in esame il “basic id” del soggetto, del quale le dimensioni di interesse sarebbero riconducibili almeno a “Behavior, Affective processes, Sensations, Images, Cognitions, Interpresonal relations, Drugs and diet”. Anche se non è sempre necessario lavorare su tutte, è necessario verificare che tutte sino considerate e che l’intervento su una non provochi, di conseguenza, regressioni nelle altre.
E’ chiaro che per valorizzare l’educando, per conoscerlo in tutte le sue molteplici sfacettature e possibilità, non ci si può affidare alla conoscenza di un’unica disciplina. Per attuare un intervento che si proponga di far emergere le sue capacità e che sia rispettoso della multidimensionalità umana, l’educatore deve orientare l’attività di aiuto garantendo una carrellata di proposte, fra le quali l’educando possa scegliere quella che meglio lo realizza e gli si addice. Nel testo di De Natale[160], un intero capitolo è dedicato alla descrizione di un intervento sul campo realizzato nei confronti di giovani ragazzi devianti, sottoposti a provvedimenti penali. Le direzioni sulla base delle quali l’organizzazione proponente ha strutturato il programma sono: fissare gli obiettivi di riferimento; intervenire fondandosi su una metodologia di carattere ludico-creativo-sportivo; orientarsi verso una scelta che preveda una carrellata di attività comprendenti quelle sportive, di animazione teatrale, videoforum, arti figurative, giochi di cooperazione; dare la possibilità di frequentare corsi di sensibilizzazione nei confronti di problematiche attuali, nel campo dell’ecologia, del rispetto dell’altro, dell’educazione stradale, della salute.
Questo è solo uno dei tanti esempi di interventi educativi che presentano una vasta carrellata di proposte per fare in modo di favorire il più possibile all’educando una migliore conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri interessi spendibili nel futuro.
Gli aspetti appena trattati, assieme a quelli che seguono, non vogliono raggiungere l’intento di essere esaustivi, ma linee direttive sulla base delle quali l’educatore, nella relazione d’aiuto si può orientare.
3.2 I “VALORI” EDUCATIVI
All’interno di questo capitolo, che tratta le competenze dell’educatore, ho deciso di chiamare “valori” i presupposti che l’educatore possiede a livello umano e deve imparare a padroneggiare e attuare, nella relazione d’aiuto, con professionalità.
L’educazione, infatti, è strettamente implicata nella questione axiologica, il cui compito è di “sostanziare di valore la relazione”[161]. Acone[162] conferma questa affermazione a proposito di uno specifico ambito, considerando che “nel tentativo del disimpegno axiologico v’è chi vede un attentato condotto alla possibilità stessa di configurare la scuola per una peculiare funzione educativa. Tale tentazione (...) esibisce una sostanziale forma di abdicazione e di dimissione da parte degli educatori”.
Coerentemente con la precedente affermazione, Rossi denuncia il rischio che la scuola e, nel campo più vasto, l’educazione siano private della loro dimensione peculiare rappresentata dall’offerta di quadri di riferimento e direzioni di senso, nonché dall’attenzione nei confronti della scelte concernenti la persona. Se questo accadesse l’educatore si ridurrebbe ad essere un “tecnologo della trasmissione programmata e razionalizzata di nozioni” e l’educando sarebbe esclusivamente ascoltatore passivo, ridotto ad assimilare più che a partecipare. Il fondamento dell’intervento sarebbe la razionalità, l’eliminazione di qualunque tipo di “interferenze emotive”.
Proponendoci di realizzare un intervento di aiuto, in opposizione a questi disvalori, faccio ancora riferimento ad Acone[163], alle sue affermazioni in merito all’insegnante estendendole a tutti gli operatori educativi: l’educatore deve essere modello carismatico, persona validante, ispirato a valori, promotore di operazioni destinate a conferire senso allo sviluppo e alla crescita dei soggetti, deve riscuotere la stima dell’educando prima di tutto come persona.
Per fare in modo che queste immagini di educatore si realizzino concretamente nell’intervento, vengono di seguito proposti dei paragrafi riguardanti alcune indicazioni su come svolgere l’aiuto, secondo criteri coerenti con l’oggetto di attenzione primo dell’educazione: la disposizione verso l’Altro.
Diverse sono le qualità richieste all’educatore, le possiamo considerare “valori dell’agire educativo”, essenziali nella professione e assieme costitutivi dell’ontologia umana: l’educatore deve “tirarli fuori”, non reinventarli, ma scoprirli nella sua natura di essere umano.
3.2.1 L’educatore come strumento
Il primo valore, o prima direzione di senso, che deve seguire l’educatore è rappresentato dalla capacità-possibilità di puntare sulle proprie qualità. Al di là degli strumenti che può scegliere e delle risorse dell’utente cui punterà per realizzare l’aiuto, viene prima di tutto lui stesso.
Dando per scontato il possesso di tecniche e metodologie di lavoro, è essenziale soffermarsi sulla “questione umana”, vale a dire su ciò che di innato possiede l’educatore in quanto uomo, e su quelle qualità, già possedute ma anche acquisite, che devono essere potenziate e valorizzate per agire in educazione, per aiutare e insegnare all’educando ad aiutarsi.
L’educatore è strumento perché è portatore di valori, è egli stesso persona che dà significato agli eventi, ricco di potenzialità, di iniziative, capacità, creatività, desiderio migliorativo.
La filosofia del personalismo pedagogico[164] - sulla base dei suoi principi di riferimento e del compito di difendere l’uomo in quanto tale, di garantirgli un rispetto pieno, nella convinzione possa sempre “risorgere”- dimostra la necessità di conferire valore non solamente all’educando, ma anche all’educatore: in quanto persona è anch’egli portatore di valori e, perché ne sia conscio, dev’esserne messo di fronte, attraverso un’opera di educazione. L’educatore stesso deve essere educato. Il senso della formazione di base e permanente che riceve deriva proprio dalla necessità di farlo riflettere su di sé, sul proprio ruolo e soprattutto sulla portata di responsabilità che questo comporta.
Non sono solo gli strumenti terapeutici, tecnici e le metodologie a rendere possibile il miglioramento dell’utente, ma l’educatore stesso è strumento di recupero, riabilitazione, “risollevamento”. Possiede competenze, si è formato, ma prima di tutto è lo strumento più importante perché è persona di fronte ad un’altra persona, disponibile a darle aiuto, a offrire tutto il suo bagaglio culturale e umano per garantirle miglioramento. De Natale[165], nella carrellata delle competenze indicate per poter intraprendere la professionalità di educatore considera:
1. saper parlare, perché nel saper comunicare si esprime il saper essere uomini educatori;
2. impegno, continuo esercizio di autocoscienza e autocritica;
3. “forza di contagiare l’altro”, perché esprima la sua vitalità;
4. capacità di rimanere contagiato, coinvolto;
5. rispetto;
6. priorità d’importanza al rapporto interpersonale;
7. aiutare il soggetto a recuperare il senso dei suoi diritti di essere umano;
8. usare la parola non solo come veicolo di espressione-comunicazione, ma come strumento di chiarificazione e responsabilizzazione.
Ritiene, però, la professionalizzazione non sia risolvibile in competenze tecnico-operative, non si presti a “valutazioni estrinseche” o a “ricette definitorie”: essere educatore coinvolge i profondi livelli motivazionali. Non tutti sono adatti a intraprendere la professione di educatore, perché le doti non sono sostituibili esclusivamente dalla preparazione culturale.
Anche Spranger riconosce che “non può molto l’educatore sprovvisto di un interiore impulso verso l’educazione dell’uomo” e che dalla scienza dell’educazione non ci si deve aspettare che essa compia dei miracoli senza lo spirito”[166]. Tuttavia, non a torto, Rossi [167] ritiene non si possa trascurare o sottostimare la funzione della cultura pedagogica nella formazione dell’educatore. Sostiene, infatti, che luoghi di formazione permanente possano essere previsti anche per i genitori, perché siano aiutati ad autoeducarsi: associazioni familiari, scuole per genitori potrebbero contribuire a “promuovere la cultura pedagogica grazie alla quale rendersi conto non soltanto delle difficoltà dell’educare, ma saper apprezzare anche e soprattutto la gioia dell’educare”. Lo stesso autore fa alcune considerazioni ancora riferite ai genitori, ma che si possono ampliare al riguardo di tutti coloro che sono educatori[168]. Tenendo conto del fatto che, per lo sviluppo dell’individuo, è necessario l’educatore collabori con i genitori, senza sostituirsi ad essi, in questo contesto riflessivo non si vuole valutare quale dei due operati sia il più importante – trattandosi, invece, di due interventi complementari -, ma semplicemente tratteggiare le caratteristiche comuni dell’azione educativa, sia essa genitoriale, dell’insegnante, dell’educatore o di qualsiasi altro “volto dell’educazione”, traendo spunto dal contributo di Rossi, il quale pone un forte accento sulla questione di interesse di questo paragrafo: l’agire dell’educatore come strumento, in quanto portatore di valori.
Il tema di riferimento, argomento di sfondo nella riflessione di Rossi, è il disorientamento axiologico e la crisi dei rapporti che caratterizzano l’epoca contemporanea. Nel tentativo di trovare una causa a questo disagio, vengono indicati alcuni atteggiamenti che distinguono l’uomo oggi: l’individualismo, il narcisismo, l’autoripiegamento, l’autocentramento. Come afferma Tayolr[169] , l’uomo non ha speranza di superare i rischi cui va incontro finché evita di reagire e finché persevera in questi atteggiamenti poco rilevanti e costruttivi socialmente, ma può trovare una via d’uscita se fa emergere realmente il suo potenziale, la sua capacità di essere protagonista e di costruire attivamente il suo destino. La scelta che si pone davanti ad ognuno è fra adattamento-rassegnazione e la decisione, certamente più faticosa e difficile, di intraprendere la strada dell’azione.
L’azione alla quale è chiamato l’uomo consiste nel recupero dei rapporti attraverso il dialogo. In particolar modo, gli educatori sono coinvolti in quest’auspicata “azione reattiva”, perché proprio sul dialogo si fonda la relazione d’aiuto.
Come Rossi afferma che la famiglia possiede virtualità umanizzanti, così lo si può dire dell’educatore, senza con questo voler sostituire il ruolo dell’uno a quello dell’altra. Anche l’educatore, come il genitore e qualunque altra persona ricopra un ruolo educativo, ha il compito di raggiungere, attraverso il dialogo, le mete che hanno a che fare con l’umanizzazione, con l’arricchimento della vita spirituale, con la diffusione di umanità, amore, saggezza, civiltà, libertà, creatività culturale. Perché tutti questi propositi si realizzino, il dialogo deve essere autentico, fondarsi su fiducia, ascolto, partecipazione, collaborazione, sospensione del giudizio, comprensione, empatia, rispetto, in modo tale da attuare l’aiuto come “altrui autenticazione”, promozione della personalità dell’altro. L’educatore deve:
- essere guida,
- immedesimarsi nei problemi degli utenti e guidarli a risolverli,
- esser modello di riferimento,
- rispondere ai bisogni affettivi, che sono espressione dei bisogni spirituali, del bisogno di sentirsi esistere, di essere importante per qualcuno,
- compiere un’azione maieutica per l’affermazione e l’espressione della personalità degli educandi.
La sua responsabilità è questione professionale, ma soprattutto entra nel campo della morale. Egli lascia un segno nella via dell’educando, in qualunque modo agisca. Nell’incontro fra uomini non c’è la possibilità di cancellare quanto di negativo può accadere, però c’è sempre la possibilità di rimediare. L’azione dell’educatore non è impeccabile, perché egli, in quanto uomo, può sbagliare, l’importante è che cerchi sempre una soluzione ai suoi sbagli, e che, in primo luogo, si impegni a non sbagliare, contando su di sé: è chiamato a prendere consapevolezza
- delle sue possibilità e ricchezze interne,
- della necessità di mantenere saldo il suo ruolo, non lasciandosi guidare e trascinare dagli eventi,
- della capacità intenzionale-progettuale,
- dei suoi compiti, del suo operato, della modalità con cui lo realizza, riflettendovi costantemente.
L’ “educatore strumento” non è solo colui che dà: riceve incremento umano dall’incontro, e questa rappresenta la più grande spinta motivazionale che lo fa andare avanti e sopportare i fallimenti con coraggio e ottimismo. L’educatore è una risorsa inesauribile, finché é motivato. Continuamente arricchisce la relazione d’aiuto, continuamente riceve arricchimento dal contributo dell’educando.
L’educatore “autorità morale”, che permette o facilita l’incontro del suo educando con il valore, che garantisce e potenzia la libertà dell’individuo, che non vuol lasciar solo l’educando nel suo percorso di recupero, che costruisce il rapporto in termini autentici, sulla base del dialogo e della reciprocità: questo è l’educatore - sotto le sembianze di genitore - che tratteggia Rossi e che anche nella relazione d’aiuto deve potersi manifestare in questi termini.
Si è voluto mettere in evidenza l’educazione come luogo dell’autenticazione, del recupero dei valori, dell’arricchimento, e che la condizione perché tutto questo si attui concretamente è la presenza dell’educatore. Con un altro contributo, quello di Ceriani, per la figura del formatore, e Corsi, per la figura del consigliere[170], vengono indicati alcuni aspetti, già affrontati nelle riflessioni dei precedenti capitoli, per recuperarli, dal momento che non sono semplicemente utili, ma fondano l’incontro: all’interno di questa riflessione sui valori dell’educazione - che l’educatore deve far propri per potersi proporre come “strumento” e che deve far propri anche per essere realmente facilitatore dello sviluppo dell’educando - viene ripreso il tema relativo all’importanza del soggetto, delle risorse di cui è portatore, e il tema del soggetto attivo. Il soggetto è attivo e portatore di risorse: vale per entrambi i protagonisti della relazione, sia per l’educatore, sia per l’educando.
La relazione d’aiuto ha come compito primo la centratura sull’educando, l’interesse per il suo progetto di vita, la preoccupazione, l’impegno, il lavoro per stabilirne le determinanti. Per costruire l’ “edificio” della relazione, bisogna disporre di alcuni “mattoni”. Fuor di metafora si potrebbe affermare che i mattoni sono rappresentati dall’ “uomo”: la speranza come paradigma dell’educazione dimostra la necessità di puntare su di lui. Per questo motivo l’educatore può essere considerato strumento: lo è nella misura in cui si propone come “educatore risorsa” e “educatore attivo”. Non bisogna mai perdere di vista l’idea che l’educatore ha una doppia responsabilità: nei propri confronti, per vivere la relazione e intraprendere il percorso verso l’altro, e anche nei confronti dell’educando, per insegnargli a fare la stessa cosa.
Gli argomenti degli autori citati cui faccio riferimento indirizzano in questo senso. Questi sono alcuni spunti di riflessione:
“ Il riconoscimento dell’autogestione e autogestibilità del percorso formativo da parte dei soggetti coinvolti parte dal presupposto che gli unici titolari della formazione sono i soggetti in formazione e che l’efficacia del percorso formativo è strettamente legata alla dinamica esperenziale dei soggetti, alla loro “biografia”, più che alla chiarezza di intenzioni dei formatori e alla qualità del loro intervento. Nessuna azione o attività di formazione è automaticamente formatrice e, quindi, l’attenzione deve essere spostata sulle risorse, sulle sorgenti educative attraverso le quali gli adulti si formano continuamente, ma anche diversamente nel corso della loro vita ” [171].
“ …ogni attività educativa è, per lo meno nei suoi postulati teorici, ispirata dal desiderio di rendere il discente artefice intelligente e responsabile di cambiamento, contribuendo alla formazione della sua personalità in una direzione multidimensionale: da un lato, evitandone ogni decurtazione nel processo di sviluppo e, dall’altro, aprendola alle dimensioni collettive del vivere rifuggendo da un sé egocentrico ed esposto a massicci condizionamenti ” ( Ceriani) [172].
L’educatore è colui che deve far emergere le risorse perché possano essere formative. Ha il compito di mettersi a disposizione dell’educando e, nel contempo di dirigerlo. Assume contemporaneamente due ruoli apparentemente contradditori: saper “dosare” disponibilità e autorevolezza. Né il percorso formativo, ma nemmeno la dinamica esperenziale dei soggetti, sono “in assoluto” garanzia della riuscita dell’intervento: l’educatore deve “orientarli” perché lo diventino.
“ La consulenza è globalmente l’esercizio di quell’ “arte del consiglio”, di quel “piacere dell’aiuto”, e di quella “scoperta del confronto ”
(…)C.G. Vella scrive che il consulente non affronta problemi ma persone, con dei sentimenti, delle paure, degli ideali, delle speranza e, ancora, con dei pensieri, dei profondi e ben motivati convincimenti, delle prefetture distorte e parziali.
(…) citando Willis, prosegue che egli aiuta gli utenti per mezzo di una discussione che metta in luce i loro problemi personali e renda più facili, felici e stabili le loro relazioni con il mondo esterno…cerca di stabilire una relazione interpersonale…Esamina, studia e valuta il caso per aiutarlo…facendo crescere dentro l’utente la consapevolezza…che può arrivare per mezzo dell’autodeterminazione a valutare esattamente il suo problema ” (Corsi) [173].
L’educatore è “strumento della relazione d’aiuto”, è riposta in lui la speranza che l’intervento vada a buon termine. Non si vuole affermare sia riposta solamente in lui, perché, infatti, precedentemente si è affermato che è l’educando a dare il via all’aiuto e a permetterlo[174]. Però, una volta avviata la relazione d’aiuto, sopra di tutto, prima di tutto, condizione perché vada a buon termine è l’educatore, persona che si dedica agli altri, disposto a dedicare il proprio tempo, le proprie competenze ed esperienze, le proprie doti, la propria pazienza per chi ne avrà bisogno e glielo chiederà. Per riuscire a disporsi in tal senso, per poter usufruire della propria personalità come strumento principale della relazione d’aiuto, per proporsi come “strumento di aiuto”, è indispensabile avvii “ un lavoro continuo e costante su di sé per migliorare la presa di coscienza sia dei propri bisogni, dei propri limiti sia per perfezionare le proprie modalità di mettersi in comunicazione con gli altri”[175]. Per Groppo è indispensabile la ricerca e conoscenza di sé, la scoperta di una maturità “matura, responsabile, consapevole dei propri limiti, motivata e disponibile a stabilire una relazione d’aiuto”: per potersi identificare in tale modello auspicabile, l’educatore deve avere capacità di interrogarsi, capacità critica del proprio operato e di lettura delle problematiche che deve affrontare con l’educando. E’ importante rifletta, per individuare e far emergere i problemi e cercare di risolverli. L’educatore come risorsa umana è “educatore strumento” che come uomo si avvicina ad un altro uomo, che come uomo riesce a far fronte alle resistenze e alle paure insite nell’incontro, per gli Altri.
3.2.2 L’ascolto
“ Spesso crediamo necessario rispondere, ma rispondere significa parlare…parlare significa rischiare di impedire all’altro di esprimersi “ [176].
In queste poche parole Salomè[177] chiarisce il perché del dialogo e il suo necessario alternarsi al silenzio, nella relazione d’aiuto. Fra le modalità sulla base delle quali deve aver luogo la comunicazione, egli vede la prima nell’ascolto. L’ascolto “comporta una rinuncia a parlare, a giustificarsi, a spiegare, a convincere, a rispondere”, comporta decentramento, inteso nel senso di separazione dei propri desideri e sentimenti da quelli dell’altro, e intenzionalità, intesa nel senso di mettersi a disposizione. Il ruolo dell’educatore, infatti, si gioca fra il dire e il non dire, il consigliare e sollecitare la responsabilità dell’educando: l’ascolto, infatti, non consiste nel lasciare l’educando a se stesso, ma tutto quello che egli dice viene assimilato e discusso successivamente assieme.
Quando Salomè racconta delle difficoltà riscontrate dai partecipanti ai suoi corsi di formazione, rileva un atteggiamento diffuso anche nei contesti della vita quotidiana: “riempire i silenzi, reggere la conversazione, rispondere, interrogare, sembrano all’inizio essere le preoccupazioni di alcuni, quando privilegiano un discorso fatto di parole e non la ricerca di un senso, di una parola che sia personalizzata (p.48)”. Il significato dell’ascolto e del silenzio si spiegano nella profondità - richiesta e ricercata nella relazione d’aiuto -, condizione perché la relazione stessa si qualifichi come formativa e si distingua dai discorsi non necessariamente portatori di contenuti significativi, tipici della vita quotidiana.
Salomè illustra il grado di lucidità delle relazioni interpersonali, attraverso il grafico di Ingrham e Luft, chiamato “finestra Johari”[178]:
Conosciuto all’individuo Sconosciuto all’individuo
I
AREA DI ATTIVITA’ LIBERA
IIAREA CIECA
III
AREA EVITATA O SEGRETA
IVAREA DI ATTIVITA’ SCONOSCIUTA
Conosciuto all’altro
Sconosciuto all’altro
Il grafico serve a comprendere in modo chiaro le dinamiche che si producono in una relazione. Si compone di quattro quadranti, con questi significati:
I. l’area di attività libera: riguarda comportamenti e motivazioni conosciuti sia da se stessi che dagli altri. Rappresenta quanto, in un certo momento di una relazione, circola liberamente tra due persone;
II. l’area cieca: rappresenta ciò che gli altri possono vedere di noi e che noi stessi ignoriamo;
III. l’area evitata o segreta: rappresenta quello che noi sappiamo bene di noi stessi, ma che non riveliamo agli altri. E’ lo spazio segreto che in determinati momenti della relazione non desideriamo condividere con nessuno;
IV. l’area di attività sconosciuta: rappresenta quei comportamenti o motivazioni di cui né noi, né altri siamo consapevoli e di cui possiamo solo immaginare l’esistenza.
Salomè sottolinea, inoltre, che i livelli del colloquio sono tre: fatti, vissuto e ripercussione. Nel caso della relazione d’aiuto tutti tre i livelli del colloquio dovrebbero essere toccati, così come tutte quattro le dimensioni che sottostanno ai quadranti della finestra Johari: questo renderebbe profondo il rapporto, lo costruirebbe su questioni personali relative ai sentimenti oltre che agli accadimenti. Il silenzio e l’ascolto si rendono fondamentali proprio perché l’educatore si dia il tempo di capire le parole dell’altro, per entrare nel suo punto di vista, per immedesimarsi in lui, per scoprire alcuni aspetti della sua personalità che l’educando vuole mantenere segreti e altri che egli stesso non sa di tenere segreti a se stesso.
L’ascolto comprensivo, per Salomè, è la chiave di volta del colloquio di aiuto: comporta un seguito, non deve denunciare soltanto una pausa concessa a sé per lasciar sfogare l’educando, ma dev’essere un momento di lettura delle sue parole per poterle poi discutere assieme, per “essere capaci di riprendere e riassumere ciò che l’altro dice”. Non si traduce tanto nell’espressione “Ecco quello che hai detto”, ma “Di quello che hai detto, ecco ciò che ho capito”.
Non sono solo le parole l’oggetto di attenzione dell’ascolto, ma il significato che ad esse viene attribuito e i sentimenti che vengono rivelati attraverso le parole e, a volte, dalle parole nascosti. L’educatore nell’ascolto evita di dare spazio ai propri desideri, di proiettare le proprie paure, ma cerca di capire i vissuti dell’altro. Salomè riassume in questo modo che cosa voglia dire ascoltare:
- accettare di lasciar parlare (dunque saper tacere);
- stimolare se necessario: “Puoi dire qualcosa di più”;
- abbandonare il livello della generalizzazione per quello della personalizzazione della testimonianza vissuta ( dove, quando, come, con chi?);
- amplificare (ridondanza, riformulazione) e collegare (avvicinamento dei differenti elementi discontinui);
- essere sensibili ai sentimenti e alle emozioni riattivate in sé da questo ascolto;
- chiarire e rianalizzare (a che punto sono con il mio interlocutore).
Ogni buon ascoltatore dovrebbe attuare in questi termini l’ascolto:
Fig. 3.
a) Favorire al massimo l’esprimersi di A ( può dire ancora qualcosa?).
b) Recepire. “Di quello che hai detto, ecco cosa ho capito”. Rimandare, restituire all’altro ciò che ha appena detto.
c) Comprensione o chiarificazione. “Di quello che ho ascoltato, ecco cosa ho compreso”. Do all’altro, al di là del mio ascolto, la mia comprensione.
Fra le dinamiche di scambio analizzate da Salomè[179], le più comunicative sono queste:
1)
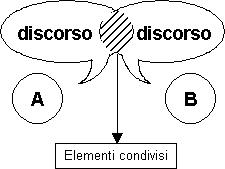
Fig. 4
E’ rappresentato il caso in cui A e B, in uno scambio, pongono il loro punto di vista l’uno a fianco dell’altro. La parte tratteggiata costituisce ciò che viene messo in comune. Ognuno da questo scambio ripartirà con qualcosa di più, che non aveva all’inizio.
In tal modo dovrebbe svolgersi la relazione d’aiuto. Un aspetto che dovrebbe maggiormente esservi realizzato riguarda il sostegno e lo stimolo a parlare di A (educando), da parte di B (educatore). Il discorso di B deve poter condurre A alla verbalizzazione; in seguito B, dopo aver ascoltato A, restituisce quello che ha capito. Assieme si cercheranno le possibili soluzioni ai problemi fra le quali si sceglierà quella ritenuta migliore. Lo scambio si realizza nei termini ascolto – comprensione – chiarificazione.
2)
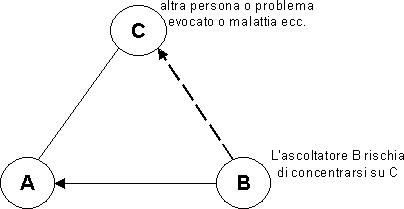
Fig. 5.
E’ necessario interessarsi a chi vive il problema, più che al problema stesso. C’è il rischio si svii dall’oggetto di attenzione principale, che è la persona.
3)
Fig. 6.
In quest’ultima figura sono esplicitati gli argomenti di riflessione di B che ascolta A. L’ascolto, si può sviluppare in tre direzioni:
a) Focalizzazione sulla situazione: Di che cosa parla? Che cosa mi dice? Che cosa comprendo di quello di cui parla?
b) Focalizzazione sulla persona: Che cosa vive? Che cosa è importante per lui? Qual è il suo vissuto? A che cosa lo rimanda della sua storia, dei suoi progetti?
c) Focalizzazione su di sé: Che cosa provoca in me? Che cosa provo? Quali sono i miei sentimenti nei suoi riguardi? Che cosa sto vivendo in questo momento?
E’ già chiaro che l’ascolto è un processo di alta rilevanza, tanto importante quanto difficile da essere attuato nel rispetto dell’altro, dei suoi diritti e della sua umanità. La difficoltà sta nel fatto che nessuno ci insegna ad attuare specifiche modalità di ascolto autentico dell’Altro: è un’attività che si dà per scontata o che a volte può sembrare addirittura scomoda, troppo impegnativa. Si impara, invece, a parlare, fin dai primi anni: il bambino viene invitato a dire chi è, a raccontare di sé, e per lui l’ascolto è associato alle regole che gli vengono impartite, o alle fiabe. L’ascolto è sempre qualcosa che ha a che fare con lui stesso. In età adulta l’ascolto, invece, ha a che fare con l’Altro.
Nel nostro discorso sulla relazione d’aiuto, in ambito pedagogico, si può tener conto solamente di un unico tipo di ascolto: l’ascolto autentico. Non semplicemente consiste nel disporsi di fronte ad un’altra persona dimostrando interesse per quello che dice, dimenticandone subito dopo il contenuto. Rossi recupera questa citazione:
“ …il concetto di incontro-relazione al quale facciamo riferimento non richiama un semplicistico ed improduttivo stare insieme ma rimanda a un itinerario costruttivo percorrendo il quale le soggettività si incrementano e a ciascuno è data la possibilità di essere partecipe e di rendere partecipi gli altri dell’intersoggettivamente valido così da poter costruire una comunità della comunicazione ” [180].
Come in tutti gli altri passi costitutivi della relazione educativa, anche quest’altro si caratterizza per la necessità etica di non trascurare le parole dell’Altro, che sono specchio e frammento della sua storia e di quello che egli è. L’appello dell’Altro mi impone di rispondere anche alla sua esigenza di essere ascoltato.
Dal punto di vista dell’educando, sentirsi ascoltato vuol dire sentirsi accettato e, prima ancora, avere la percezione di essere: è un bisogno innegabile, in cui lo si deve soddisfare perché egli possa sentirsi vivo, perché prenda posto nel mondo, perché si fidi a lasciare una parte di sé nelle mani di altre persone, si fidi a chiedere consiglio, perché non si senta solo.
Due persone sono implicate nel dialogo, ma perché sia autentico e non legittimi un sopruso, entrambe devono assumere alternativamente il ruolo di ascoltatore e ascoltato. L’educatore ascolta l’educando, ma immediatamente prende il suo posto: il messaggio dell’educando sarà la richiesta d’aiuto, il messaggio dell’educatore sarà costituito da parole di conforto, di sostegno, di aiuto. L’educatore deve dimostrare di aver compreso l’educando, con le sue esigenze e le sue difficoltà, a parole, prima che attraverso i fatti concreti.
Nella civiltà postmoderna, tra le tante interpretazioni che ne vengono date, due sono individuate da Rossi[181] per spiegare la caduta dei significati e lo smarrimento di senso che la caratterizzano. La prima è individuata nell’ideologia tecnocratica di secondo illuminismo, che determina una riduzione dei problemi umani a parametri funzionali e una riduzione dei bisogni al loro aspetto economico-materiale; la seconda nella cultura del narcisismo individualistico. Quest’analisi - assieme a tutte quelle altre che vedono nella modernità il trionfo dell’isolamento dell’uomo di fronte al suo simile - mette in luce un problema di fondo nei rapporti umani: l’assenza di ascolto autentico, di dialogo autentico, la tendenza di pensare a sé, non tanto prima di andare all’altro e per andare all’altro, ma come atteggiamento esclusivo. Pensare esclusivamente a sé è “moda” della contemporaneità. L’ascolto, al contrario, si basa sul coinvolgimento, non è azione neutra, ed è anche vero che dal momento in cui richiede di perdere una parte di sé per andare all’altro, può fare paura. Non è la “paura”, però, che legittima la dimenticanza e l’abbandono dell’altro.
Il concetto di salute, intesa come benessere dell’individuo tenute conto tutte le sue dimensioni, esprime anche la necessità di soddisfare il bisogno relazionale, che, secondo De Natale, rientra a pieno titolo fra i bisogni primari[182]. Paradossalmente è la chiusura in sé, al contrario, ad essere l’atteggiamento più ricercato, più attuato, che porta l’uomo ad autoescludersi la possibilità di essere “in salute”, di “stare bene”. E’ necessario capire i perché dell’individualismo, il motivo per il quale l’uomo - che sempre ricerca soprattutto il proprio bene - lo metta in atto, nonostante rischi di non alimentare il proprio bisogno innato e vitale di socialità. La spiegazione consiste nel fatto che l’individualismo è strumento usato dagli uomini per seguire la propria strada, senza sentirsi messi in discussione.
Ascoltare implica fare entrare dentro di sé pensieri, esperienze, interpretazioni, idee che non ci appartengono, implica confrontare questi pensieri estranei con i nostri, rischiare di dimostrare a noi stessi che abbiamo sbagliato, che avremmo potuto ragionare e fare meglio, implica essere “turbati” da ciò che non ci appartiene. Confrontarsi implica “confondersi”. Bauman afferma:
“ L’ambiguità esperenziale della città postmoderna si riflette nell’ambivalenza postmoderna dello straniero. Uno straniero che ha due facce: una è seducente perché misteriosa e attraente (...). Anche l’altra faccia è misteriosa, ma è portatrice di un mistero sinistro, minaccioso, intimidatorio ” [183].
Bauman per conoscere la società postmoderna ne analizza le “paure” [184] e fra queste una riguarda la relazione con l’altro, in particolare con straniero.
Nella modernità era straniero colui che non si adeguava all’ordine, che non si uniformava. Le strategie adottate nei suoi confronti consistevano nell’esclusione o nell’imposizione dell’obbligo di adeguarsi, di assimilare per forza le regole impartite. Lo straniero era alienato, scompariva agli occhi della società, sia se se ne fosse andato, sia se fosse rimasto: non gli era possibile vivere così come aveva deciso, ma il suo stesso “essere” era imposto dall’esterno.
Dall’altro canto, la società postmoderna è lei stessa produttrice di stranieri: tutti siamo stranieri gli uni nei confronti degli altri, tutti siamo caratterizzati da diversità agli occhi degli altri. E’ il frutto della libertà, della conseguente perdita di certezza e di una via stabile da seguire dall’inizio alla fine dei nostri giorni. Da quest’analisi deriva la convinzione si nasconda, in questa nostra contemporaneità, un grande potenziale pedagogico - il quale può concretizzarsi a patto che superiamo la paura dello straniero ed evitiamo di escluderlo, allontanarlo – rappresentato dalla possibilità di arricchimento attraverso l’incontro con l’altro. Per Bauman la società ha bisogno di stranieri, di differenze che possono arricchire.
Per arricchirci come persone di fronte ad altre persone e grazie a queste, dobbiamo sottostare a una condizione: lasciarci “coinvolgere” nel rapporto con il diverso, dimenticando le paure nei suoi confronti. Ancora Bauman, rifacendosi a un’interpretazione di Sartre si serve di una metafora per rappresentare l’immagine dello straniero così come appare ai nostri occhi: ha un carattere di vischiosità, ci ripugna perché, a differenza dello stato solido o liquido, il contatto con essa ci mette in gioco, ci fa perdere la percezione chiara dei confini del nostro corpo, della nostra identità.
Nell’ascolto, straniero è l’altro di fronte a me. Ascoltandolo, rischio di perdere una parte di me stesso, ma vado anche incontro ad un processo di arricchimento nella diversità.
Non si dà relazione d’aiuto senza ascolto, quindi senza incontro autentico dell’altro come diverso da me, senza arricchimento. Per Salomè[185], “formarsi al colloquio significa soprattutto formarsi all’ascolto attivo, cioè possedere un ascolto che permette all’altro di parlare di sé e di capirsi”. Né l’educatore deve aver paura di cambiare conoscendo ancora di più l’Uomo, le diversità di esperienze che la vita gli riserva e le diversità di pensiero; né l’educando deve aver paura di venire a contatto con chi lo dirigerà verso la diversità di se stesso con se stesso, del sé passato con il sé agente nella relazione d’aiuto.
Chieregatti[186] sottolinea il bisogno di diversità per “comunicare in virtù delle differenze”. Lo stile di ascolto che propone è un “ascolto partecipante”, che permette di accostarsi all’altro, comprendendo le sue rappresentazioni e impegnandoci a costruire assieme a lui un progetto. Cita Schwartz (1995) per paragonare due modalità di accostamento all’altro nel corso del processo comunicativo:
“ Ci sono due modi di ascoltare. Il primo consiste nell’impossessarsi dei discorsi dell’altro per metterli a servizio della propria tesi e dei propri interessi, il secondo consiste nel sentire l’altro, nel capire “da dove“ parla, nell’andare verso di lui. Il primo modo, sfortunatamente, è di gran lunga il più diffuso. Si ascolta senza veramente sentire e si utilizza l’ascolto come alibi per mantenere la situazione immutata e consolidare i malintesi, “si frusta colui che è stato ascoltato”, che ha perciò l’impressione di aver parlato ad un muro ”[187].
Messe a confronto le due modalità di ascolto, si dimostra che non possono esserci vie di mezzo, per lo meno dal punto di vista etico, nel momento in cui ci si accosta all’ascolto simulato, ma non effettivo, non si ha rispetto dell’altro. Le scelte sono semplicemente due e a seconda che si prediliga l’una o l’altra si dà o si esclude la possibilità o meno di comprensione, che è poi la possibilità o meno di realizzare una relazione d’aiuto.
La spiegazione che chiarisce, ma, come affermato, non giustifica perché si verifichi il non-ascolto, può essere trovata proprio nella diversità, precisamente nella paura del diverso. L’ascolto ci chiama in causa e ci confonde con l’altro, ci fa mettere sullo stesso piano le nostre e le sue idee, per cui la manipolazione diventa un modo per difendere la propria integrità, la propria identità. Per Chieregatti, però,
“Né l’assimilazione né la gerarchizzazione né l’imposizione della propria verità possono essere assunte come strade da percorrere per risolvere il problema dell’identità di fronte alla diversità. E’ possibile percorrerle, ma in genere non permettono di realizzare una convivenza in cui le persone vengono rispettate. Siamo quindi obbligati a seguire altre strade. La direzione da prendere può essere indicata da uno slogan: uguaglianza nella diversità, diversità nell’uguaglianza. Ciò significa poter rimanere se stessi pur facendosi ricchi dell’alterità con cui si è in contatto” [188].
Non dimenticando che l’uomo è libero anche di scegliere la strada che richiede meno fatica, attraverso l’ascolto si profila una possibilità di contatto, non solo per i singoli, ma anche, nella prospettiva macrodimensionale, per i diversi popoli. La vicinanza, l’ascolto comprensivo che permette di camminare verso il diverso, permette, in definitiva, di camminare verso noi stessi, verso la costruzione del “Noi” buberiano. Pur facendo paura, l’incontro con il diverso è l’unica possibilità di mettere in atto un autentico ascolto partecipante, un’autentica relazione d’aiuto. Per agire verso questa direzione, Chieregatti ritiene che non basti solo la disposizione interiore, in un certo senso teorica, ma il concreto impegno “di fronte” all’altro.
Il dialogo autentico, se da una parte richiede lo sforzo dell’ascolto e il coraggio di mettersi in discussione, dall’altra ci consente di capire in che cosa il nostro pensiero si distingua da quello dell’altro, ci consente di dimostrare il motivo per il quale pensiamo di avere ragione, usando la parola, la tecnica del confronto, con tutte le regole umane di rispetto dell’altro che esso implica. E’ occasione per entrare “in profondità”.
L’ascolto è testimonianza del fatto che entrambi gli attori della relazione d’aiuto cambiano: cambiano, infatti, perché si confrontano, perché parlano, perché si ascoltano. In questo modo con l’altro, in educazione, attraversiamo un percorso che non ci fa più essere stranieri. Se l’educatore lo è, inizialmente, per l’educando e viceversa, l’ascolto fa oltrepassare le barriere e permette di vedere anche in sé un segno della traccia dell’Altro. Il sé è anche frammento dell’altro.
In questo senso si può capire la portata elevatissima della presenza dell’Altro nella personale vita soggettiva; la portata delle sue parole come dono; la ricchezza dell’incontro. Nella relazione d’aiuto ognuno si dona all’altro e questo dono può essere recepito se viene ascoltato.
3.2.3 Il comprendere: entropatia
Strettamente legata alla questione relativa all’ascolto è la comprensione. Nella misura in cui si attua un vero e proprio ascolto, si comprende l’altro. La comprensione parte proprio dall’ascolto “partecipato”, dall’atteggiamento che consiste nel mettersi nei panni dell’altro. E’ dimostrazione che si sta ascoltando in modo autentico, cercando di capire, lasciando all’altro il suo spazio, non facendo prevalere l’io, non ritenendo le sue parole una parentesi per riflettere su quello che si avrà da dire successivamente di sé: la comprensione empatica è “la prova del nove” dell’ incontro autentico. Seguendo l’iter di riflessione che presento in questo paragrafo, si vedrà, però, che la comprensione non è solo prova dell’ascolto, ma ne è anche la condizione.
Comprendere è una prerogativa dell’uomo e delle scienze umane in quanto studi sull’uomo. La pedagogia, che è una di queste, non è caratterizzata dal conoscere scientifico, obiettivo, ma dal “comprendere empatico”.
Chi testimonia la peculiarità della pedagogia, è Dilthey [189]. Nell’ “Introduzione alle scienze dello spirito”, opera una distinzione fra le scienze della natura e le scienze dello spirito, in nome dell’autonomia delle seconde, che ritiene caratterizzate da peculiarità proprie: mentre per le prime la realtà è esterna, anche nel corso del processo conoscitivo, e viene compresa nella spiegazione, per le scienze umane o dello spirito la conoscenza avviene attraverso un “processo di comprensione”. La comprensione riguarda la storia, la vita vissuta, il modo con cui si vive un’esperienza. Anche Max Weber[190] si accorge della peculiarità delle scienze umane e ne tiene conto nel campo sociologico, facendo attenzione a non cadere nell’individualismo soggettivista.
All’opposto, Durkheim riteneva che il mondo sociale e quello della natura fossero entrambi regolati da leggi studiabili, oggettivabili e che l’uomo attraverso la ricerca scientifica le potesse scoprire.
Fra le due, la posizione di riferimento per la presente riflessione è quella di Dilthey-Weber, i quali mettono in evidenza la peculiarità dell’uomo, argomento privilegiato delle scienze dello spirito: la diversità da un individuo all’altro, l’unicità. Non è possibile studiare scientificamente il pensiero, il sentimento, l’esperienza vissuti dall’educando, al contrario è la comprensione a farci accostare, come educatori, al suo modo di vedere e di vivere. Ognuno sente le esperienze vitali in modo diverso dai suoi simili, ed è questo il motivo che porta a ritenere il sentire non oggettivabile: non è, infatti, argomento delle scienze della natura.
Secondo la corrente del costruttivismo[191] il mondo conoscibile è quello costruito sul significato che gli individui vi attribuiscono: “la conoscenza non consiste in una rappresentazione – più o meno adeguata - della realtà esterna, obiettiva, separata e indipendente dal conoscente”.
A questo punto della questione, si è trovato una causa che spiega l’individualismo: gli uomini sembra restino soli a causa di un loro inevitabile destino, scritto nella loro natura[192]. Ogni uomo è ontologicamente diverso da tutti gli altri uomini, ha la caratteristica innata di interpretare in modo personale, unico, il mondo reale. Unici sono gli eventi che ha vissuto, anche perché unico è il modo di vedere dei suoi occhi. Eppure si è più volte affermato, in sede di apertura del testo, che due sono le dimensioni umane: l’essere soggettivo e l’essere sociale. Privilegiando solo la prima si snatura l’uomo. La socialità non è solo e semplicemente dimensione umana, ma soprattutto necessità umana, importante condizione garante del suo benessere.
Quella condizione che fa in modo la socialità possa caratterizzare la vita dell’uomo è la comprensione: apre ognuno alla personale interpretazione della vita data dall’altro, dispone ognuno all’ascolto dell’altro. L’educatore, grazie alla personale competenza di comprensione, si dispone all’ascolto: per comprendere l’altro lo deve ascoltare, deve leggere la realtà con i suoi occhi. Questo è desiderio e compito che, nella relazione d’aiuto, conduce all’ascolto autentico.
Una delle soluzioni che portano ad evitare che l’uomo rimanga isolato nel proprio “mondo”, è proprio il necessario sforzo di comprensione, garanzia di socialità. Anche la comprensione è sforzo, dispendio di energie, sospensione del giudizio, superamento del proprio io; ma se questo è il prezzo da pagare, il risultato non lo rende vano: la realizzazione di entrambe le dimensioni dell’uomo, il rispetto di quelle proprie e di quelle di cui è portatore l’altro sono la ricompensa e lo stimolo della relazione educativa.
“La socialità – afferma Rossi - non può ridursi a un semplice incontro di individui. Essa rinviene le proprie basi nell’umanità”. Proprio nella socialità l’individuo conosce meglio se stesso, impara a sentirsi distinto rispetto agli altri, unico. Riconoscendo la propria unicità, nel confronto e nella conseguente riflessione, egli impara a cogliere la socialità come occasione per imparare a trasmettere le proprie esperienze e fare in modo siano utili agli altri, impara ad arricchirsi, conoscendo nuovi modi di pensare. A partire dal sé, l’uomo può disporsi verso l’altro. Comprendendo se stessi, educando ed educatore compiono il primo passo per imparare a comprendere anche gli altri. All’educando questo passaggio permette di aprirsi al futuro in modo propositivo, superando i disagi, attraverso il percorso della relazione d’aiuto; all’educatore consente di realizzare l’obiettivo della relazione educativa, nel rispetto del primato della persona, consente di “cogliere e leggere i significati che si trovano nell’universo interiore dell’altro, aiutandolo così a mettere a fuoco la propria tematica esistenziale e a definire i traguardi a lui congeniali e verso i quali dirigersi”[193]. Questo è possibile in educazione grazie alla comprensione.
Canevaro[194] denuncia il rischio, riscontrato nell’impostazione proposta da Guerra, di conoscere l’altro come oggetto e in modo neutrale:
“ L’altro non è un oggetto: tanto più lo si conosce, tanto più aumenta la sensazione di sentirsi ignoranti; tanto più si conosce, tanto più diminuisce la possibilità di sentirsi neutrali in rapporto alla conoscenza”.
Ritiene opportuno fissare in questi punti i cardine della conoscenza dell’altro:
1. conosciamo nel contesto di una relazione. Vuole intendere che non si dà conoscenza, se non nel contesto relazionale dell’incontro. Se non viviamo “a contatto” con l’altro non possiamo ammettere di conoscerlo in profondità;
2. conoscendo, dimostriamo continuamente a noi stessi la necessità di conoscere ancora, la nostra ignoranza di fronte alla ricchezza umana di cui è portatore l’altro. Non ci possiamo mai illudere di conoscerlo nella sua completezza;
3. Il processo di conoscenza si avvia nel contesto di una “relazione interessata”, mai neutra.
Queste considerazioni possono condurre a due modi alternativi di intendere la conoscenza.
La prima interpretazione la vede come trampolino di lancio per disporci all’aiuto: la conoscenza sarebbe il mezzo a partire dal quale potersi avvicinare all’altro, sapendo quali sono i suoi interessi, le sue difficoltà, le sue capacità. Si nasconde un aspetto negativo, insito nel processo di conoscenza unilaterale, rappresentato dal rischio di concepirsi “padroni“ dell’altro: la conoscenza rischia di essere un’ “arma”, che se non maneggiata bene, con criterio, può provocare delle ferite. Se l’altro si affida, dimostrando fiducia, ne deriva il compito di custodire la sua storia, della quale ci rende partecipi, per riflettervi assieme e rendergli più facile la scoperta di una via di scampo, della possibilità di miglioramento, della valorizzazione di sé. La conoscenza dell’altro deve essere funzionale solo a fare il bene dell’altro. Non saremmo degni dell’appellativo di “esseri etici”, qualora ascoltassimo le sue parole senza assumerci la responsabilità della quale veniamo investiti, per il solo fatto di essere di fronte a lui, di essere ascoltatore; qualora, una volta ascoltate le sue esigenze, non ci adoperassimo per fare in modo di soddisfarle; qualora sfruttassimo la nostra posizione per il controllo dell’altro, per dirigerlo, per indicargli una strada da noi stessi stabilita, senza coinvolgerlo, senza dargli la possibilità di dimostrarsi autonomo. L’educatore lavora, nella relazione d’aiuto, per l’altro, non per aver potere, per sentirsi utile - atteggiamenti che vanificherebbero la portata educativa, caratteristica peculiare della relazione, rappresentata dal momento comunicativo, non espressivo-: nella relazione d’aiuto non deve prevalere l’individualismo e la sensazione di potere potrebbe avviare proprio verso questa strada.
Il secondo modo di intendere la conoscenza da parte di Canevaro consiste nel considerarla come un processo mai compiuto. Questa considerazione nasconde un importante potenziale relazionale: abbiamo bisogno dell’altro per approfondire la conoscenza che abbiamo di lui. L’altro è la “chiave” che conduce ad avviare con lui una relazione dialogica, improntata sull’aiuto.
Le due implicazioni sono strettamente collegate fra di loro. Entrambe valorizzano tutti due gli attori della relazione d’aiuto, i quali hanno responsabilità, che se non rispettate determinano la rottura del rapporto educativo; e, nel contempo, entrambi sono attivi, apportano un contributo ineliminabile per la creazione del legame e per il suo buon esito.
L’educatore è responsabile dell’educando, il quale raccontandosi dimostra di affidarsi a lui. Tuttavia deve dare delle direttive, stabilire delle regole chiare nel rapporto, perché la relazione d’aiuto resta pur sempre asimmetrica, anche se mai deve scadere in un “atteggiamento militaresco”, di dominio da parte dell’educatore, che non deve proporsi come “salvatore”, non deve creare un rapporto tanto stretto da diventare prigionia, soprattutto nel caso in cui incontra l’educando nelle condizioni non idonee per esprimere le proprie energie. Il lavoro, anche in quest’ultimo caso estremo, non è mai tutto sulle spalle dell’educatore, ma vive anche di piccoli contributi dell’educando. L’educazione si muove tra l’illusione di una totale comprensione - con la collaborazione di chi gli sta di fronte - e la rinuncia a comprendere in toto, cercando e garantendo equilibrio tra le due posizioni.
Canevaro[195] risale all’etimologia dei termini comprensione e comunicazione, chiarendone le differenze. Conoscere è un concetto che si avvicina a “conquistare”: entrambi i termini sono composti dalla particella cum, che indica lo strumento; la prima deriva da gnoscere, acquisire, la seconda da quaerere, andare in cerca, far proprio, sottomettere. Con la conoscenza si “conquista” con l’intelletto.
Comprendere è abbracciare, prendere assieme, cum-prendere: richiama un’immagine che già sembra avvicinarsi di più al significato che la relazione d’aiuto porta in sé. La comprensione si fa tanto più difficile, ma anche apportatrice di rischio, quanto più pretendiamo di conoscere l’altro totalmente. La pretesa di comprendere l’altro in tutto e per tutto è pericolosa: l’altro non si conquista, non si deve arrivare a sottometterlo, a farlo proprio.
“ Nell’educazione, si tratta di attingere il nucleo essenziale di un’altra persona, che si pone in tal modo come un centro di attività indipendente dai nostri propri progetti. Questo incontro mediato dalla partecipazione ad un progetto di vita ed alla realizzazione del mondo proprio ad una persona umana, costituisce la vera comprensione ”[196].
La comprensione nella relazione educativa si chiama anche empatia. Alleanza, condivisione, intesa, sintonizzazione, aiuto, valorizzazione di virtualità e forze umanizzanti, apertura, rispetto, dono di sé sono termini raccolti nel concetto di empatia e da questa portati alla massima espressione pedagogica.
“ Le grandi coscienze sono quelle che, accogliendo in se stesse il massimo di umanità e costruendosi esse stesse su questa ricca esperienza, fanno sì che noi siamo letteralmente in esse, che esse ci conoscano meglio di quanto noi stessi ci conosciamo, che esse ci esprimano meglio di quanto noi stessi sapremmo esprimerci ” [197].
L’educatore è chiamato a essere “Grande coscienza” – secondo Buber - nei confronti dell’educando, a sforzarsi di penetrare nella sua soggettività, di prendere in sé l’altro. Non lo vuole analizzare, non vuole fare terapia, egli, infatti, non è terapeuta, non ha il compito di lavorare sul passato. Blezza [198] afferma che semmai l’azione educativa può accostarsi alla clinica “per le evidenti ricorrenze nel dialogo educativo di elementi di educazione presenti proprio nel campo clinico: ad esempio il realismo, l’attenzione per il destinatario, la problematicità, la relazionalità diretta, la professionalità, la presenza della dottrina, la possibilità di considerare ogni forma di variabilità individuale, e la reciproca esclusione delle tipizzazioni “medie” che intervengono in procedimenti, anche pedagogici, di tipo statistico”. Ritiene, inoltre, che mentre la psicologia possa essere considerata come “cura del vissuto” e superamento della nevrosi, il campo della pedagogia abbraccia, invece, il “lavoro sul futuro”, la “riformulazione del progetto di vita”, l’attenzione al contesto. Il dialogo educativo non è fare psicologia o psicoanalisi, perché non si accede allo stato psicologico-cognitivo del soggetto per conoscerlo e studiarlo, ma la finalità è modificarlo in senso funzionale, “modificare evolutivamente”. La modalità d’intervento del pedagogista professionale - afferma Blezza – è caratterizzata dall’ interlocuzione.
“ Il pedagogista professionale dialoga: non esprime diagnosi, prognosi e terapie come il medico, né offre soluzioni come l’avvocato o il commercialista o l’ingegnere, né le fa emergere come lo psicanalista od altri. Piuttosto ha delle indicazioni da offrire, e tutte da discutersi, date proprio perché se ne discuta. A chi gli chieda, esplicitamente o meno, dei consigli, egli cerca il modo più produttivo e meno brusco e ruvido per dire che può piuttosto dare delle opinioni, dei pareri, i propri, i quali come tali non pretendono di vantare alcuna trasferibilità ” [199] .
La comprensione pedagogica è diversa dalla comprensione psicologica: mentre la prima indaga le cause del comportamento ed è volta a individuarne gli elementi oggettivi, in educazione, il comprendere, ” determinante per un’autentica professionalità educativa, ha come scopo, anziché di evidenziare solo gli elementi oggettivi (le “cause”) che compaiono nella storia individuale dell’educando e che ne determinerebbero i comportamenti, di cogliere e così di aver presenti, per poter iniziare e perseguire con lui un dialogo produttivo, i suoi più profondi e perciò “sensati” orientamenti esistenziali” [200].
L’educazione non si accontenta della comprensione, ma necessita anche dell’interpretazione: tutto quello che dice l’educando è “collocato” in situazione, acquisisce un significato particolare a seconda del contesto.
“ Affinché questa comprensione e questo incontro abbiano luogo, occorre portarsi fuori dal tempo. Uscire dal “nostro” tempo. Del resto, noi non siamo mai “là”, siamo sempre altrove. Nel passato, con i nostri ricordi. Nel futuro, con i nostri progetti. Siamo sempre in un “prima” e in un “dopo”. E mai in un “adesso”. Perché vi sia questo incontro, occorre uscire dal nostro tempo, che corre all’impazzata. In qual modo “uscire dal tempo”, da questo furioso fluire? Semplicissimo. Occorre ESSERE LA’. Essere là come se non ci fosse più futuro, come se non ci fosse più un “dopo”. ESSERE LA’. Come se fossimo alla fine dei tempi. Poiché questo ne è l’inizio. Ancora una volta, è tutto semplicissimo. E apparentemente impossibile.Come conciliare l’inconciliabile. Con un’attenzione appassionata “.
Frèderic Leboyer[201]
Parole e gesti sono interpretati a seconda dell’ hic et nunc, e con la collaborazione attiva dell’educando, il quale consapevolmente, intenzionalmente può fornire importanti spunti di conoscenza. Ancora una volta è testimoniato che l’educatore si può accostare all’educando contando sulla sua collaborazione, sulla sua partecipazione attiva e soprattutto sulla sua conoscenza di sé: la comprensione dell’educando è possibile “grazie all’esperienza interiore del singolo – alla vita intima – che consente ad ogni soggetto di riconoscersi, di auto-ordinarsi, di educarsi, di acquisire il senso dell’altro” [202].
Relativamente al rapporto con l’altro si può affermare possieda caratteristiche ben distinte dal rapporto con sé: non è così facile per l’educatore comprendere l’altro, interpretando i fatti al suo stesso modo. A questo proposito, due sono le tesi relative alla possibilità entropatica: la tesi della soggettività sostiene nessuno sarà mai capace di aiutare l’altro, perché da lui resteremo sempre distinti; la tesi dell’intersoggettività che parte dal presupposto sia possibile conoscere l’altro, perché il soggetto non conosce bene nemmeno se stesso e, come prova a conoscere sé, così può provare a entrare anche nell’emotività dell’altro. La relazione d’aiuto gioca sicuramente a favore dell’intersoggettività e si fonda sulla considerazione che se l’altro si rivela tanto inaccessibile, sarà pur sempre possibile ottenere la sua collaborazione per capirlo di più e, in definitiva, per aiutarlo. L’intervento dell’educatore non è infallibile, non si incontra con un campo noto, né conoscibile oggettivamente. Quello che conta, però, è certamente la sua volontà di capire.
3.2.4 La comunicazione
Crepet ritiene, a proposito di un particolare rapporto di aiuto, quello fra genitori e figli, che “…comunicare con i figli non significa solo parlare e ascoltare, ma anche accarezzare ( p. 29)”.
E’ significativo sottolineare come il dialogo non richieda solamente una consuetudine di procedure, di meccanismi automatici, in base ai quali si sa perfettamente che di fronte alla parola dell’altro si ascolta e, possibilmente, si risponde. La comunicazione di cui si tratta nel contesto educativo, cerca di andare al di là, di proporsi come dimostrazione di una vera disposizione all’altro. Questo è il motivo per il quale Crepet comprende, nella comunicazione - che si instaura in primo luogo con i genitori, ma che potrebbe anche essere trasposta ai rapporti educatore-educando – anche l’aspetto affettivo, la dimostrazione di una reale vicinanza umana.
La comunicazione è un’altra condizione chiave del colloquio d’aiuto tra educando ed educatore, ma anche del lavoro d’equipe fra educatori. Per l’educatore, protagonista della comunicazione, è strumento che usa per natura, come tutti gli uomini, ma anche per professione. Per lui, in particolare, diventa indispensabile acquisire la capacità di comunicare in modo autentico e la capacità di fare metacomunicazione, di riflettere, cioè, su come si comunica, per esserne consapevole. Salomè, infatti, ritiene che ci sia una concreta necessità di apprendere come svolgere le relazioni, contrariamente alle credenze diffuse:
“ Nella nostra civiltà si crede nella spontaneità relazionale. “Io capisco subito con chi posso o non posso parlare”.
La capacità di stabilire una relazione sembra un fatto innato (facile o difficile) che obbedisce solo all’improvvisazione o alla disponibilità del momento. C’è una manifesta reticenza all’ “apprendimento” delle relazioni…
Le resistenze del gruppo riflettono anche, in un certo qual modo, ciò che avviene in molte relazioni. Si deciderà, per esempio, di non andare oltre per rispetto dell’altro. ( Non si vuole essere indiscreti, creargli sofferenza, “non avrebbe capito” ) “[203].
Oltre alla partecipazione degli assistenti sociali, ai suoi seminari, riscontra un progressivo interesse anche da parte di “partecipanti motivati da un desiderio di migliorare le loro relazioni quotidiane, personali e familiari”.
Imparare a comunicare è un modo per rendersi coscienti dei propri blocchi, delle proprie resistenze nell’incontro con l’altro e, dall’altra parte, anche delle proprie personali intuizioni ammirevoli. “La formazione assomiglia spesso al giardinaggio, nel senso che bisogna sfrondare, dissodare, lavorare in profondità sulle convinzioni, sulle abitudini, sui comportamenti codificati”, afferma Salomè. E’ facile che si sia abituati a comunicare in un certo modo, nella vita quotidiana, e che questo, invece, non sia auspicabile nell’incontro autentico, perché porta fuori strada, nega la comprensione, provoca facilmente resistenze: se il danno, nella quotidianità, può essere elevato e portare alla rottura, nella relazione d’aiuto il prezzo da pagare è l’allontanamento dell’utente, che non trova comprensione nel momento del bisogno, che percepisce la solitudine, l’impossibilità di essere aiutato. La comunicazione è tanto importante in educazione, pena l’impossibilità di aiutare o, ancor peggio, il rischio di danneggiare ancor più la situazione in cui si trova l’educando.
Gli obiettivi che Salomè nei corsi di formazione al colloquio si propone di perseguire sono principalmente tre: far riflettere sul proprio potenziale relazionale; sviluppare l’ascolto attivo, che permette all’altro di parlare di sé e capirsi; fare in modo di non fornire risposte circa la migliore modalità di accostarsi all’altro, ma disporre il partecipante a una ricerca personale. In linea con questi intenti è il pensiero di Rogers, esplicitamente citato da Salomè: “Sono arrivato a credere che le uniche conoscenze che possono influenzare il comportamento di un individuo siano quelle che egli scopre da solo e di cui si appropria”. Vengono ancora una volta valorizzate le capacità del soggetto di elaborare le conoscenze e di attribuirvi un significato, la necessità di non muoversi sulla base di copioni rigidi, ma di cercare in situazione le risposte.
Salomè stesso, nell’introduzione al testo, dimostra il primo irrinunciabile obiettivo che la formazione al colloquio raggiunge, disponendo gli educatori a occupare il proprio ruolo in modo responsabile:
“ Mi sono infatti reso conto che proprio sviluppando la mia capacità di ascoltare me stesso – ed invitando gli altri a fare altrettanto - ho potuto aiutarli a migliorare le risorse professionali e personali”[204]
Il tempo per sé diventa anche tempo per l’altro e, viceversa, il percorso che porta all’altro richiede l’irrinunciabile conoscenza di sé. L’io e il tu continuano a richiamarsi a vicenda, a presupporre l’uno la presenza dell’altro.
L’intersoggettività è l’elemento base della comunicazione nel dialogo. La comunicazione può essere anche con se stessi, fra sé e sé, e l’incontro non la elimina, ma la presuppone.
Il sé però non si deve affermare, non deve dimostrare la sua grandezza nel momento di incontro con l’altro, prevaricandolo, annullandolo: la comunicazione presuppone il rispetto dell’ascolto, in caso contrario, non è di comunicazione che si sta parlando, ma di monologo. E’ richiesto alle due soggettività che si incontrano di disporsi verso il processo di decentramento, inteso come distacco dal proprio mondo, per disporsi verso quello dell’altro. C’è un’ulteriore logica che fa da sfondo al
decentramento, consistente nel saper leggere i propri pensieri: il dialogo, infatti, è svelamento di contenuti mentali, che dobbiamo essere capaci di esplicitare agli altri dimostrandone tutta la valenza che per noi hanno, pur essendo costantemente consapevoli che gli altri possono averne di diversi, il cui valore è tale quale a quello attribuito ai nostri. E’ un mettersi in gioco reciproco: solo così ci si può incontrare a “metà strada”.
Come non ci deve essere prevaricazione, ma ascolto dell’altro, reciproco fra educatore ed educando, così anche nella formulazione di proposte dev’essere garantita la stessa reciprocità. In linea con quanto affermato, per esempio, l’educando non interviene nella relazione d’aiuto come colui che si deve sfogare e che poi aspetta le soluzioni dall’educatore. Chieregatti afferma che la fine del dialogo è rappresentata da quell’atteggiamento che consiste nell’attendere tutto dall’altro. La relazione d’aiuto è relazione dialogica che si fonda sul processo comunicativo e questo sta a significare che l’educando deve parlare, ma anche farsi condurre per mano, ascoltare la strada che l’educatore indica, per poi cercare di percorrerla assieme e, obiettivo ultimo, da solo.
C’è una caratteristica interna ad ogni individuo che garantisce l’incontro: è l’intenzionalità. E’ essenziale che si costruisca una relazione d’aiuto attraverso la comunicazione solo se gli interlocutori hanno intenzione di comunicare, ma non di un comunicare generico, quanto invece di ricercare profondità. Non ha valore l’intenzionalità dell’educatore che legge le parole dell’altro sulla base della propria significazione: egli deve entrare nella visione del mondo dell’educando. Salomè[205] parla di “pseudo-rispetto”, antagonista del rispetto vero e proprio: è dialogo interno, che consiste nel pensare al posto dell’altro. Per esempio, attribuire all’altro un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell’intervento è pericoloso perché, così facendo, l’educatore non si proporrebbe di lavorare fondandosi sulle proprie competenze e professionalità, ma sul sospetto, sulla preoccupazione che qualcosa non vada bene per l’educando. Questa disposizione è pericolosa anche perché si fonda su una presunta convinzione di leggere il pensiero dell’altro, di capirlo, senza chiamarlo in causa, senza esplicitare assieme a lui la progettazione educativa che va fatta assieme, sia nel momento in cui si costituisce la relazione, sia nel corso della stessa.
Un altro termine usato per descrivere lo stesso comportamento, è “comunicazione egocentrica”, che Rossi ritiene frutto di “rigidità, impenetrabilità, chiusura, narcisismo, monadismo, solipsismo”. Mizzau lo descrive in questi termini: l’individuo non si sforza di “assumere il punto di vista dell’altro, decifrare il suo codice e il contesto nel quale sono collocate le sue affermazioni. Automaticamente l’interlocutore egocentrico proietta nell’altro il proprio schema cognitivo-emotivo, deformando l’informazione, fraintendendo il messaggio”[206].
Il primo obiettivo da raggiungere, nella comunicazione, è la chiarezza. Comunicare incide sul clima collaborativo, richiede condivisione di obiettivi, quindi la loro esplicitazione, il confronto di opinioni, la mediazione delle opinioni differenti. Si può studiare la comunicazione dalla “prospettiva contrattuale” [207]: prima di comunicare, dobbiamo definire un contratto con il nostro interlocutore, consistente nella riflessione sui soggetti che vi prendono parte, sui loro ruoli e competenze; nella definizione dell’oggetto di comunicazione; nella definizione della situazione in cui ha luogo la comunicazione. E’ proprio il contratto ad aiutare a dirigere la comunicazione, nella relazione d’aiuto, verso gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione e ad aiutare i soggetti a esporsi di fronte all’altro, a mettere in campo dubbi, difficoltà, preoccupazioni, ma anche proposte.
Tre sono i modelli di analisi dei contenuti della comunicazione tra individui:
- modello lineare. Tradizionale, tipico dell’insegnamento universitario, consiste nell’emissione del messaggio da parte dell’emittente e nella sua codifica da parte del ricevente;
EMITTENTE
RICEVENTE
- modello interattivo. Considera i ruoli di emittente e ricevente interscambiabili fra gli interlocutori che partecipano alla comunicazione, nel rispetto di turni precisi e definiti;
EMITTENTE
RICEVENTE
RICEVENTE
EMITTENTE
- modello dialogico. Rappresenta la fase più evoluta di comunicazione, in cui gli interlocutori sono contemporaneamente emittente e ricevente, senza debbano sottostare a turni alternati. Entrambi sono contemporaneamente co-costruttori del discorso, procedimento che consente all’emittente di modificare il proprio messaggio a seconda del feedback dell’altro.
EMITTENTE
RICEVENTE
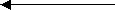
E’ quest’ultimo il modello che la relazione d’aiuto si propone di attuare. Educatore ed educando devono poter comunicare fra di loro nel modo più libero possibile e più rispettoso delle loro idee e sensazioni, che emergono nel corso del confronto. Entrambi devono poter mettere in campo quello che pensano e che provano, in qualunque istante ritengano opportuno: l’educando facendo questo può sentirsi protetto, ascoltato, aiutato realmente, l’educatore può regolare il suo intervento in base alle esigenze della situazione e in base alla sua “creatività”, alla capacità di leggere i bisogni e di rispondervi.
Facendo riferimento a Ghiglione, i principi che definiscono l’oggetto di scambio, perché la comunicazione riesca, sono:
1. il principio di pertinenza: bisogna che ci si riconosca reciprocamente interlocutori;
2. il principio di coerenza: i soggetti devono condividere conoscenze. Automaticamente, infatti, si attribuiscono un modo di pensare simile;
3. il principio di reciprocità: è necessario il rispetto dell’alternanza dei turni;
4. il principio di contrattualizzazione: rispettare gli accordi presi prima di intraprendere la comunicazione;
5. il principio di influenza: ognuno inevitabilmente cerca di influenzare l’altro con le proprie opinioni.
Chieregatti afferma che il dialogo è “mettersi in discussione come entità assoluta”, per questo richiede il rispetto di principi.
Immaginando la situazione irreale in cui un individuo si trovasse a vivere da solo e potesse farlo, è chiaro egli non sentirebbe il bisogno di stabilire alcuna regola: farebbe quello che desidera, senza il rischio, né la preoccupazione, di violare la libertà altrui. I principi, nella vita sociale, sono invece indispensabili perché ritenuti, di comune accordo fra gli individui, garanti dei loro diritti, della loro convivenza pacifica, del bene comune. Le regole esistono per orientare la vita di più individui che si trovano assieme; la società si costituisce su di esse per metterli d’accordo e disporli al rispetto di diritti, doveri, libertà.
Anche l’educando e l’educatore rispettano la loro reciproca libertà attraverso il rispetto dei principi, in cui sono sanciti diritti e doveri. Se il soggetto vivesse bastando a se stesso, non avrebbe bisogno di sottostare a regole, stabilite in accordo con chi è altro da sé. Farebbe tutto ciò che lo fa stare bene, tutto ciò che la sua volontà gli indicherebbe come auspicabile. Inevitabilmente due soggettività che si incontrano devono trovare un punto di incontro, devono mediare i loro desideri, trovando quelli che più si addicono ad entrambi e non più all’uno o all’altro. Questa è un’esigenza dettata dalla diversità della natura umana, dal fatto non sia detto che il desiderio di un individuo corrisponda al desiderio di un altro.
Oltre ai principi, nella comunicazione, è necessario rispettare altre regole determinanti, secondo il filosofo del linguaggio Grice, per fare in modo l’altro capisca bene il messaggio:
- rispettare la quantità: dare le informazioni esaurienti, che non siano né superflue, né ridondanti perché altrimenti farebbero perdere di vista il nucleo del discorso;
- rispettare la qualità: le informazioni devono essere vere o almeno dobbiamo essere convinti che lo siano e, inoltre, devono essere sostenute da prove adeguate;
- rispetto della relazione: le parti del discorso devono essere pertinenti;
- rispetto della modalità dell’esporre: il modo di esposizione deve essere chiaro, ben organizzato, senza intercalari.
Se il messaggio non viene capito, i fraintendimenti possono minare il rapporto. “Il linguaggio non è solo il principale modo di comunicazione, è anche il modo più efficace per falsare ogni possibilità di comunicazione autentica e quindi non comunicare”[208]: non è detto che solo per il fatto di proferire parola si verifichino i presupposti per la comprensione reciproca.
In pedagogia – afferma Laeng di comune accordo con Rossi – il “farsi capire” è il problema tout court. Si può parlare di relazione d’aiuto solo quando l’educatore esprime il proprio pensiero con attenzione, sia partendo dal presupposto che l’altro ne abbia uno differente, sia lasciandogli la possibilità di esprimersi e di spiegare il proprio: le parole hanno un significato unitario, ma sono anche ricche di sfumature legate al vissuto personale, si pensi soprattutto al caso in cui l’educatore debba fare i conti con il transfert.
Ci sono difficoltà quando gli interlocutori devono trovare una strada di avvicinamento fra due prospettive differenti ed è bene che non si creino “screzi” nel momento della comprensione, perché si comprometterebbe il desiderio di condivisione. Per evitare di aggiungere ulteriori difficoltà all’incontro, gli strumenti cui fare riferimento sono la chiarezza e il desiderio di capire.
Mentre la comunicazione va quasi matematicamente a buon termine, qualora si rispettino le generali direttive appena elencate, è più difficile gestire la dimensione del non verbale. La parola è strumento primario della comunicazione fra gli uomini, dell’interazione, dell’intersoggettività, ma, seppur sia grande la sua forza nella vita umana, non si può però ridurre l’autentica comunicazione a mero scambio di parole.
Gusdorf afferma che “la perfetta comunicazione sprigiona dalla possibilità d’espressione che sonnecchiano in noi”[209]. Nella relazione d’aiuto, infatti, altri elementi entrano in gioco e sono determinanti come indicatori per leggere l’interiorità dell’altro e per creare intesa.
Visto che la comunicazione non va sempre a buon termine, ma può fallire, Ader propone degli argomenti su cui riflettere:
1. distinguere i fatti dalle inferenze. L’atteggiamento corretto non consiste nel prendere in considerazione il fatto e giudicarlo prima che l’altro abbia la possibilità di spiegarsi. E’, infatti, essenziale non fare inferenze prima che l’altro abbia concluso il proprio ragionamento, perché queste possono mettere a disagio e stroncare il desiderio di condividere, di comunicare;
2. evitare un linguaggio equivoco, per non essere “capiti male”;
3. diffidare dalle valutazioni statistiche, le quali definiscono gli altri con caratteristiche stabili:
· per i situazionalisti una persona che attua un determinato comportamento, lo attua non perché necessariamente egli sia così, ma perché la situazione lo ha condotto a reagire così;
· per i disposizionisti, invece, una persona reagisce i un determinato modo, nel contesto di una determinata situazione, perché è normalmente così.
La comunicazione può fallire, a volte, anche intenzionalmente, come nel caso si dicano bugie per ingannare. Le bugie hanno anche una valenza positiva – in questo caso sono chiamate “white lies”-, possono essere “utili” quando vengono dette per evitare tensioni; oppure hanno valenza negativa, sono inganni studiati.
Nella relazione d’aiuto, si crea un rapporto affettivo fra educatore ed educando. A partire dalla riflessione di Sternberg sulle componenti emotive della comunicazione, quali rabbia, gioia, tristezza, paura, si attribuisce al comunicare educativo la capacità di focalizzare e di controllare sia le proprie emozioni, che quelle dell’educando. Per Garder le “arti sociali” sono composte da quattro fattori, consistenti nel saper gestire le emozioni proprie e quelle altrui, nell’autocontrollo ed empatia, nella capacità di esprimere i sentimenti. L’autocoscienza, la coscientizzazione, l’esplicitazione, la riflessione sono strumenti indispensabili per l’educatore, che deve sviluppare la capacità di non lasciarsi travolgere dalle emozioni, di saper analizzare le situazioni sociali nelle quali si trova coinvolto, di negoziare soluzioni con gli altri, di stabilire duraturi e costruttivi legami interpersonali.
Rossi parla di “forza della comunicazione”:
“ …anche laddove c’è conflitto, esistono ampie possibilità di convergenza e di collaborazione, fino a riconoscere al conflitto stesso una forza maturazionale in termini personali e comunitari. Se è vero che esso, quando si dà in forme competitive genera distruttività impedendo l’intesa ed esasperando le differenze, è altrettanto vero che esso, allorquando si attua secondo intenzioni e modalità cooperative, è fonte di costruttività e di reciprocità ” [210] .
A determinare una rottura nell’incontro non è il conflitto, ma l’incomunicabilità. Anche nel conflitto, a patto che si realizzi una disposizione comunicativa, c’è sempre occasione di arricchimento. Finché la parola è duplice strumento sia per il disvelamento di sé, sia per l’incontro con l’altro mantiene sempre il suo valore formativo, la sua portata pedagogica.
Il dialogo ha la capacità di avvicinare due posizioni divergenti, così come due culture diverse. La paura dell’altro è la stessa che proviamo verso lo straniero che è in noi, come afferma anche Chieregatti, e il modo per superarla è comunicare, “nel convincimento che essa è capace di esprimere energia autoincrementativa allorquando non naufraga nell’isolamento o non si svilisce nell’autocontemplazione ma si ritrae via preziosa di consapavolizzazione della propria peculiarità e densità ontologica e axiologica”[211].
Comunicare è destino della persona, la sua vocazione che riempie di senso l’esistenza.
La Scuola di Palo Alto
Gli studiosi della Scuola di Palo Alto definiscono i principi della comunicazione:
¨ Non si può non comunicare.
Con quest’affermazione si vuole intendere che qualunque gesto, qualunque parola umana ha un significato. L’uomo agisce perché pensa, risponde dopo aver riflettuto ad una domanda, ad una sollecitazione. In ogni suo atto c’è un senso, più o meno facile da essere interpretato, che può essere nascosto agli occhi degli altri, volontariamente oppure involontariamente.
Watzlawick, Beavin, Jackson ritengono che
“ la verifica sperimentale di questa ipotesi intuitiva ci viene sempre più fornita dalle ricerche sulla deprivazione sensoriale che mostrano come l’uomo non riesca a mantenere la propria stabilità emotiva per periodi prolungati comunicando solo con se stesso. Riteniamo che qui possano trovare la loro giusta collocazione situazioni come quella dell’incontro ( secondo la terminologia esistenzialista) e in genere ogni altra forma di rapporto con gli altri che consenta di accrescere la consapevolezza di sé”[212].
L’uomo è fatto di vita interiore. La sua esistenza non si esaurisce in questa, ma ne richiede l’esplicitazione, la condivisione con gli altri. Comunicando i suoi pensieri esprime se stesso, ma anche il suo bisogno di socialità.
Anche il silenzio comunica e a seconda delle situazioni può essere caricato di svariati significati: è paura di sbagliare, di essere contraddetti, di manifestare i propri sentimenti, è occasione per ricercare il senso del discorso, per riflettervi e restituire una personale opinione, incapacità di trovare le parole adatte, è segno di disinteresse, di lontananza, di rifiuto dell’altro, di distacco. Il silenzio, per Rossi[213], può essere inteso in due modi: come assenza di parola o come ricerca di profondità. Si può leggere e interpretare solamente nel secondo caso, altrimenti non ha alcuna energia comunicativa.
“Il silenzio dunque non possiede nessuna energia intrinseca: è uno spazio bianco nel dialogo in cui le armoniche dell’accordo o del disaccordo esistente possono manifestarsi. Il silenzio dà la parola alle profondità quando esse sono in gioco, e alle lontananze se ce ne sono”[214].
Per Jaspers[215] “a vincolare è l’origine del silenzio”.
Rossi propone il concetto di “solitudine creativa”, per intendere un silenzio non dell’assenza di pensiero, ma finalizzato alla socialità, alla restituzione agli altri delle riflessioni: un silenzio “contro una solitudine frustrante e disgregante fatta di abbandono a se stesso, di fuga, di senso di vuoto, di assenza di solidarietà, di mancanza di amore, di autocontemplazione”.
Il colloquio non è fatto solo di parole, ha anche bisogno di alternarsi alla loro assenza, per “dare tempo”. L’educando, raccontando il proprio vissuto all’educatore, probabilmente ne avrà bisogno, e così l’educatore, quando deve elaborare le parole dell’educando e riproporgli una strada da percorrere assieme.
Qualche volta sono necessari silenzio e solitudine per recuperare il coraggio di esistere. Ci proviene dall’antichità, dagli echi della religione, un messaggio che ci invita a ritagliarci un po’ di tempo anche per la vita contemplativa. Il tempo per sé, della conoscenza di sé, funzionale all’incontro con l’altro è proprio anche tempo di silenzio. Orlando Cian afferma che
“ …vi è anche il silenzio che va incoraggiato, favorito in educazione, cioè quello della riverenza di fronte a ciò che è grande, ineffabile, quello che permette di sentire le voci della natura, di ascoltare le altre persone e se stessi ”[216].
E’ la modalità più rilevante per imparare a conoscersi, per scoprire il proprio mondo interiore e, in educazione, costituisce il primo passo per disporci, con curiosità, nei confronti degli altri. L’educatore sempre deve interpretare il silenzio e insegnare a interpretarlo, avendo in mente la sua ricchezza comunicativa.
¨ Ogni atto comunicativo trasmette informazioni e, contemporaneamente, impone comportamenti.
Quando comunica, il soggetto dice e questo dire è comunicativo, ha valenza sociale. C’è una finalità nelle parole: attirare l’attenzione, raccontare per condividere un’esperienza, stimolare l’altro a parlare per poterlo conoscere e così via. Fra tutte le finalità del linguaggio, quella prima che presuppone tutte le altre è la trasmissione delle informazioni. Si è appena affermato che l’uomo non può non comunicare e che qualunque suo atto ha una precisa valenza comunicativa. La comunicazione consiste nel dire qualcosa all’interlocutore, nel dare o cercare informazioni che possono riguardare sé, terzi, l’ambiente, l’interlocutore stesso.
Spesso ci aspettiamo che le nostre parole non solo siano ascoltate, ma anche necessariamente condivise; addirittura ci aspettiamo di portare l’altro a pensare come noi. Un obiettivo nascosto nel linguaggio è la ricerca del consenso, il tentativo di modificare, trasmettendo informazioni, il comportamento del nostro interlocutore.
A questo punto può essere interessante analizzare il contributo di due studiosi che, seppur non facenti parte della Scuola di Palo Alto, aiutano a chiarire l’aspetto verbale e non, caratterizzanti il linguaggio. I due studiosi di cui esamino il pensiero sono Skinner – che si occupa del linguaggio come mezzo di trasmissione delle informazioni - e Catania[217] - che si occupa del linguaggio come mezzo per modificare il comportamento dell’altro -.
Skinner ritiene che nell’ evento verbale si possono evidenziare due aspetti complementari: il comportamento di chi parla e di chi ascolta. Analizzando le reazioni che l’operante verbale produce in chi ascolta, sia a livello verbale che non verbale, egli giunge alla definizione di alcune unità significative per lo studio del comportamento dei soggetti coinvolti nella comunicazione: gli operanti verbali.
L’operante verbale è l’unità di analisi nello studio del comportamento verbale, è “classe di risposte” che indica l’esistenza di una relazione tra eventi; Skinner estende la sua valenza anche alla lettura del comportamento verbale. Due esempi di operanti verbali sono l’operante “tact” e l’operante “mand”:
- tact è l’emissione verbale che segue ad uno stimolo di natura non verbale ( per esempio, il bambino, alla vista della madre, proferisce la parola “mamma”);
- mand è l’operante verbale che attiva il comportamento nell’ascoltatore ( per esempio, la mobilitazione della madre alla richiesta di acqua del bambino).
E’ chiaro che la nostra comunicazione è caratterizzata da un intreccio di eventi verbali e non verbali, i quali sono domande e risposte fra interlocutori: ad un evento verbale si può rispondere con un altro evento verbale o con uno non verbale e viceversa. Entrambi trasmettono informazioni, sono segno della relazione fra individui e richiedono risposte.
L’altro aspetto importante caratteristico della comunicazione, evidenziato dalla Scuola di Palo Alto, è il condizionamento. Nell’analisi delle caratteristiche del comportamento verbale, Catania distingue tre aspetti: il controllo istruzionale, che consiste nella possibilità che una persona ha di istruirne un’altra; le classi di equivalenza, processo di costruzione del linguaggio nell’associazione di aspetti verbali e non, diversi, e che assumono significato equivalente; i processi autoclitici. Questi ultimi sono, in particolare, oggetto di attenzione della Scuola di Palo Alto: riguardano il comportamento del parlante, la sua capacità, caratteristica e possibilità di “gestire” l’effetto di una frase sull’ascoltatore, per produrre in lui una determinata risposta.
Per l’educatore ha una rilevanza fondamentale conoscere queste caratteristiche della comunicazione, per disporsi a conoscere meglio sia l’educando, che i canali comunicativi di cui in prima persona si serve.
L’educatore legge le informazioni trasmesse dall’educando, ma, a sua volta, è necessario sia consapevole che lui, a sua volta, anche involontariamente, trasmette segnali informativi all’educando, che li interpreta: l’educatore non è solo ricevente, ma anche emittente del messaggio comunicativo.
Come emittente deve fare attenzione a non esercitare in modo inappropriato la facoltà di condizionare l’altro, approfittando del suo ruolo di “potere”; più che condizionare, lo deve “guidare”, esplicitando gli obiettivi della relazione educativa, dimostrandone il valore all’educando. Come ricevente del messaggio, è necessario sappia che gli atti verbali e non verbali hanno entrambi intento comunicativo; deve cercare le informazioni trasmesse direttamente o indirettamente dall’educando e interpretarle.
Salomè[218] partendo dalla prima affermazione secondo la quale non si può non comunicare, afferma che “come le parole, così i comportamenti sono dei messaggi: non si possono avere dei non comportamenti”. La comunicazione, infatti, non è fatta solo di scambio intenzionale, cosciente, riuscito. Fra i due elementi che compongono ogni comunicazione, vale a dire il contenuto e l’aspetto relazionale, il secondo è quello che ci permette di leggere e comprendere il significato del primo.
Mentre la parola è strumento della comunicazione verbale, i gesti, in tutta la loro varietà, sono strumenti della comunicazione non verbale. Entrambe sono comunicazioni nel senso pieno della parola: trasmettono significato da un soggetto all’altro. E’ possibile un messaggio sia mandato senza intenzione, ma sia ricevuto dall’interlocutore con un significato anche completamente diverso. Mentre è più difficile accadano questi fraintendimenti per l’interpretazione sbagliata di una parola, è più facile ciò accada nella lettura dei gesti.
L’ambiguità può essere considerata una caratteristica del non verbale, la sua “complicazione”, l’aspetto rischioso e inevitabile. Oltre a possedere un risvolto negativo, il linguaggio verbale ha delle precise funzioni:
- esprimere emozioni, quando per esempio la voce è tremante o quando si arrossisce;
- presentare se stessi, per esempio nel modo di vestire;
- comunicare atteggiamenti interpersonali, come un certo modo di camminare o sedersi;
- sostenere il discorso o ironizzare su di esso.
Per Salomè devono essere rispettate delle condizioni che, pur facendo da sfondo all’incontro, tuttavia sono importanti perché contribuiscono a condizionare le modalità con cui si avvia la relazione. Si possono raggruppare in due ordini di “condizioni” materiali e psicologiche.
Fanno parte delle materiali:
- il luogo: è importante fare attenzione sia al locale, ma anche alla posizione di sedie e scrivania. Il luogo deve essere possibilmente tranquillo, caratterizzato da intimità; le sedie devono essere disposte in modo tale da permettere alle persone di guardarsi, ma anche di stare abbastanza vicine per favorire un’associazione fra vicinanza fisica e psicologica; la scrivania, di conseguenza, non deve avere funzione di separazione, perché potrebbe rinforzare l’atteggiamento di difesa.
- il tempo e la durata: anche nella disponibilità di tempo si dimostra la disponibilità di ascolto-aiuto. L’incontro, tuttavia, si gioca fra due estremi, costituiti dall’aiuto “a tempo” e dalla “saturazione”.
- Il modo di presentarsi, il sesso, l’età, lo status professionale, le immagini e le percezioni precedenti non sono elementi neutri: i pregiudizi e la percezione che l’altro ha di noi - in particolare nel primo incontro - condizionano l’intero lo sviluppo del colloquio.
Fanno parte delle condizioni psicologiche:
- la posizione relazionale: alta o di apertura, caratterizzata dal domandare, dall’attendere, oppure bassa o di influenza, di imposizione. Presentarsi permette di familiarizzare, di vincere la titubanza dell’altro, il disagio e il rischio di distorsioni;
- il linguaggio: è caratterizzato da soggettività. Non è detto l’altro capisca quello che vogliamo dire solo perché conosce le parole usate;
- altri linguaggi che sono quelli detti propriamente “non verbali”, vale a dire la mimica, gli sguardi, gli atteggiamenti del corpo, la respirazione, ma anche le differenze di colorazione della pelle, le somatizzazioni elementari come quelle di dolore, fatica.
La presente elencazione dimostra quanto sia importante il “non verbale”, la cui rilevanza anche nella relazione d’aiuto non può essere trascurata.
Il compito dell’educatore è cercare di codificare tutti questi segnali, “ascoltandoli”. Parole e gesti si completano, si arricchiscono vicendevolmente ed entrambi costituiscono argomento di attenzione dell’educatore, che si appresta alla comprensione del soggetto di fronte a sé.
Anche Chieregatti[219] afferma che a costituire la relazione non può essere solo la parola, vale a dire la razionalità, il concetto, perché “la ragione non comprende tutta la realtà”, perché “ciò che si esprime nel ragionamento non è la totalità della persona umana”. E’ necessario comprendere, fra i modi di esprimersi dell’individuo, anche il silenzio, l’amore, l’emozione, lo sguardo, anche l’istintività e la passionalità. “La realtà – secondo lui - è anche mistero”, che si nasconde alle parole, difficile da svelare e che a volte non è necessario, né possibile svelare nella sua totalità.
Un aspetto che è in stretto contatto con la questione relativa al non verbale, ma da questa non è esaurito, è la consapevolezza da parte della Scuola di Palo Alto che mentre il contenuto rappresenta ciò che il messaggio trasmette, e viene codificato attraverso un codice di possesso comune fra i protagonisti dello scambio, l’aspetto relazionale si colloca ad un livello inconscio. Nelle parole si può nascondere un messaggio implicito di accettazione o di rifiuto della persona cui ci si rivolge.
Nel recepire il messaggio, generalmente si è molto attenti a capire che cosa realmente ci vuol dire l’altro: cerchiamo la nostra conferma o il disinteresse nei sentito nei nostri confronti. Anche l’utente è molto attento a cercare di cogliere il vero valore del messaggio che l’educatore trasmette, anche e soprattutto al di là del contenuto. L’educatore, per questo, deve avere la consapevolezza della portata dell’elemento relazionale, difficilissimo da controllare, che fa inevitabilmente parte del messaggio anche non volendolo. La consapevolezza è la chiave per controllarsi e giudicarsi criticamente, guardandosi dal punto di vista dell’educando, chiedendosi che cosa ha recepito, che cosa dovrebbe aver recepito e come trasmettergli messaggi positivi di incoraggiamento.
Si realizzano i presupposti di simmetria nella relazione, qualora la differenza sia minimizzata. Salomè[220] la interpreta in questi termini: “Dici di sì ed io penso che tu sia d’accordo con me. Do al tuo sì lo stesso significato che do al mio”. Egli non si esime dal sottolineare il rischio - quando si tratta di progetti, decisioni - che questo ragionamento comporta, perché può dare luogo a malintesi. L’interazione complementare, al contrario, si basa sull’amplificazione della differenza. Salomè propone questo esempio: “Non capisco come mai apprezzi quella persona, gli dai troppa fiducia. Io non potrei mai fidarmi di lei”.
C’è un altro modo di intendere il concetto simmetria, nella relazione educativa, nel senso di “stare sul uno stesso piano”. Il rapporto educatore-educando presuppone sempre l’asimmetria, non da intendersi come superiorità dell’educatore nei confronti dell’educando, ma segno di autorevolezza: l’educatore ha il compito di essere "guida” , è colui che per primo deve prendere l’iniziativa, che “si occupa” dell’altro. Qualche volta deve sapersi imporre sull’educando, per spronarlo, senza aggredirlo, ma dimostrandogli anche in questo modo l’interessamento nei suoi confronti. L’atto di sollecitazione è segnale che ci si sta occupando dell’altro, ci si sta preoccupando per il suo benessere, il suo recupero, la sua valorizzazione.
La “comunicazione autentica” di Rogers
“ La considerazione e l’amore degli altri ci fondano nella nostra identità: sono la condizione primaria del nostro esserci come persone. A questo punto essere bravi, buoni, intelligenti, forti, ricchi, ecc. (a seconda dei valori che il nostro sistema socio-culturale coltiva) vuol dire esserci, esistere. Capita molto spesso di non sentirsi né bravi, né forti, né intelligenti…Allora l’unica scappatoia è cercare in qualche modo di adeguarsi, assumendo atteggiamenti come se ” [221].
Rogers, una volta abbandonato l’insegnamento universitario, si dedica alle sperimentazioni sui gruppi, osservando da vicino il comportamento individuale nel contesto sociale. Ritiene che il gruppo costituisce un’occasione per essere se stessi, anche se in realtà l’individuo tende a non cogliere questa possibilità, tradendo la sua natura e la sua unicità e adottando, all’opposto, un atteggiamento di chiusura o di “simulazione”. La condizione nella quale spesso si trova l’uomo è di non mostrarsi agli altri per com’è veramente, ma di mostrare, invece, gli atteggiamenti che più potrebbero risultare di gradimento alla società, al gruppo, alla cerchia di individui che fanno parte della sua quotidianità: secondo lui, altrimenti, non potrebbe essere amato. Essendo il consenso il suo desiderio vitale, fa di tutto per ottenerlo, anche dovendo rinunciare a sé.
La conseguenza di questa ricerca del consenso conduce a una distorsione della comunicazione, che risulta essere non autentica. L’individualismo, l’alienazione, l’incomunicabilità trovano nel fallimento della comunicazione la loro radice. Se l’ “incontro” non è più occasione per essere se stessi, per trovare la propria identità, viene snaturato, assume le sembianze di un non-incontro.
La relazione d’aiuto, se fosse relazione fra persone che cercano di essere quello che non sono, che non conoscono i loro veri bisogni, non avrebbe senso di esistere. In realtà non ci sarebbe nemmeno la possibilità di dare e, soprattutto, chiedere aiuto: ognuno dimostrerebbe di bastare a se stesso, di essere una persona “forte”, perché quello che vuole la società è competizione, coraggio, capacità di fronteggiare le situazioni anche difficili, senza mai ammettere difficoltà, senza l’individuo si possa concedere una pausa per fermarsi e riflettere. Il mercato, l’economia vanno avanti e l’individuo, inteso esclusivamente come “uomo economico”, deve stare al passo.
In realtà, la relazione d’aiuto non può essere ridotta a “recita”, perché cerca autenticità, cerca di valorizzare l’educando, di fargli esprimere la sua umanità, liberandolo dal bisogno-necessità di omologarsi, non facendogli perdere se stesso. Se l’uomo perdesse se stesso, sarebbe smarrito nell’esistenza, non troverebbe altro motivo per vivere se non la superficie della cose, senza possederne l’essenza. Anche avesse un gruppo di cui circondarsi, sarebbe un gruppo fittizio, in cui la relazione sarebbe improntata sulla ricerca di piacere immediato o sulla difesa: apparirebbe, senza chiedersi se questo apparire possa essere in linea con la sua essenza e fuggirebbe di fronte alla richiesta di relazione autentica.
Sarebbe un atteggiamento dettato dall’individualismo, privato dall’apertura nei confronti degli altri, anzi, gli altri apparirebbero non come “persone”, ma come esseri esteriori, sarebbero “strumenti”, non soggetti della relazione, dell’incontro, dell’aiuto, della comprensione, dell’empatia, dell’arricchimento reciproco.
Ciò che invece favorisce la comunicazione autentica è l’atmosfera di libertà e accettazione, basi della relazione d’aiuto. L’educatore le deve garantire, proponendosi lui stesso, per primo, come “essere relazionale”, non puramente “esteriore”, costruendo una relazione in profondità, che richiami la natura più interiore dell’educando. Deve garantire, in primo luogo, la sospensione del giudizio, cercare la fiducia dell’educando, proprio per fare in modo che lui, a sua volta, comunichi veramente, perché conosca la sua energia vitale, le sue reali capacità, per fargli sentire che ha il potere di crescere intellettualmente e interiormente.
Rogers afferma anche che nell’uomo c’è un’ energia vitale, chiamata anche “tendenza attualizzante”, che lo dirige verso lo sviluppo e l’autorealizzazione. Nella relazione d’aiuto si dovrebbero creare le condizioni per fare in modo questa forza emerga e operi. Rinnegandola, l’educando rinuncerebbe alla sua parte più intima, che lo orienta nell’esistere, perderebbe il senso dell’esistere, dimenticherebbe di essere se stesso, i propri bisogni, desideri, capacità, che lo distinguono fra tutti gli altri esseri umani. L’educatore deve far suscitare stupore nell’educando per quello che egli è, per le sue possibilità di potenziamento, di miglioramento.
Dall’espressione alla comunicazione
Considerare l’espressione e la comunicazione[222] come i due poli opposti all’interno di un continuum, vuol dire rappresentare visivamente il percorso che da un soggetto porta all’altro.
Originariamente il primato spetta all’espressione, che testimonia la prevalenza, nella nostra cultura, attribuita all’individualismo.
Per dimostrare le origini di questa tendenza, si attinge alla tradizione filosofica e alla tradizione fisognomica. La filosofia, accanto alla religione, guarda all’uomo come essere volto alla ricerca, atteggiamento emblematizzato in Diogene, o in Socrate, che ricerca la verità e vede in lei il primo tassello della conoscenza inconfutabile, come fa Cartesio costruendo l’edificio della scienza o Husserl ricercando le essenze delle cose. La fisiognomica è, invece, l’arte che attraverso i lineamenti e la gestualità coglie l’interiorità che si esprime. Oltre a queste discipline, anche la retorica, a partire dallo pseudo Aristotele o dalle “Institutio oratoria” di Quintiliano, attribuisce alla mimica, oltre la capacità di essere pervasiva, anche la grande facoltà di contribuire a esprimere il pensiero.
Mentre di espressione si è sempre parlato, non è facile ammettere la comunicazione, nemmeno dal punto di vista teorico: comunicare comporta ammettere la presenza di un interlocutore, di un “tu”. Se non si riesce a fare a meno di vedere l’altro di fronte a sé come proprio alter ego, come immagine del soggetto riflessa nello specchio, non lo si rispetta nella sua essenza originale. Se così fosse non ci sarebbe spazio per la comunicazione, perché il “tu” verrebbe manipolato, mentre i protagonisti della comunicazione devono essere tutti sullo stesso piano, il “tu” deve essere visto come portatore di valori, della sua autonomia. Una delle prime condizioni perché si dia comunicazione autentica, è considerare, in linea con il principio kantiano dell’imperativo categorico, l’uomo come fine, mai come mezzo.
La ratio occidentale ha sempre avuto fondamento alla luce della ragione, tutto ciò che non rispondeva a questo requisito veniva messo da parte: l’istinto, la passione dovevano essere ingabbiate oppure l’intera sfera razionale deve essere “padroneggiata”. Tutto ciò che non era atto della ragione era configurato come diverso, di cui aver paura.
La comunicazione autentica ha luogo quando l’altro, il diverso, assume un ruolo autonomo e si ammettere che l’emozione e il sentimento fondano la relazione io-tu.
Per passare dalla teoria dell’espressione alla teoria della comunicazione è necessario ammettere l’ “Auslösung” o “esplosione del significato”, che consiste nel ritenere che l’altro è in grado di costruirsi da sé il significato. Questa disposizione suscita in chi ascolta la possibilità di rispondere, realizzando l’appello come impegno morale.
Nella nostra civiltà occidentale, il momento comunicativo ha fatto difficoltà ad affermarsi perché comportava l’intervento di un altro, un interlocutore visto come portatore di qualcosa di autonomo: è più facile vedere l’altro nella sua valenza strumentale, quando “serve a”. Nella relazione d’aiuto c’è il rischio di vedere l’altro come strumento per estrinsecare la personalità dell’educatore, per permettergli di sentirsi utile, “buono” e di dimostrarlo alla società. Altra cosa è, invece, l’impegno caratterizzato dalla fatica, nella relazione d’aiuto, che richiede di dimenticare se stesso e le proprie esigenze per l’altro, per ascoltare quello che egli vuole comunicare.
La nostra tradizione filosofica dice che la sostanza per eccellenza è l’uomo. Espressione è la sostanza che “si esprime”; passare alla comunicazione vuol dire abbandonare la priorità della sostanza per un’altra categoria: quella della relazione. De Saussure e Peirce cancellano la sostanzialità, per privilegiare la relazione, coinvolgendo di diritto la figura dell’altro.
La rivoluzione copernicana di de Saussure consiste nell’affermare che per definire qualcosa bisogna ricorrere all’altro. Definire vuol dire cercare le relazioni che la parola ha con l’altro, non vuol dire – com’è stato da Socrate in poi – “scavare” nella natura il concetto, l’essenza. La verità così come si presenta per Platone, infatti, non si presenta nella parola, ma questa è semplicemente segno, che, come dicevano gli scolastici, stat aliquid pro aliquo: sta per altro, perché l’essere non si rivela direttamente nelle parole. Ne deriva l’idea dell’Altro fondante per il sé.
Con S.Agostino si attua l’affermazione filosofica del primato dell’espressione. In “De Trinitate” afferma:
“ Nell’intelligere vediamo Uno che dice e il suo Verbo, cioè il Padre e il Figlio e procedente dall’uno e dall’altro la Carità che è loro comune, cioè lo Spirito Santo ”.
Il cristiano pone l’esistenza: è il dire di Dio, che è un dire esaustivo, esplicita tutto l’essere. Dio, soggettività assoluta dice se stesso, il Verbo è il Suo verbo, espressione della Sua interiorità. Dio esprime il proprio Sé: all’espressione, e all’Espressione per eccellenza o espressione di Dio, spetta il primato.
Anche se secondario, in S. Agostino, non è escluso il momento comunicativo: l’interiorità assoluta si è oggettivata, si è calata nella materia diventando Uomo. Il messaggio pedagogico trae spunto proprio dal paragone cristiano che vede l’uomo imago Dei: anche il verbum mentis, la soggettività, al pari del verbum trinitario, deve oggettivarsi, diventando parola esteriore. Non possiamo dire Dio si sia dovuto fare uomo, il Suo è stato un atto di generosità, di Carità divina; così nemmeno si può dire l’uomo debba passare al momento comunicativo, è una scelta difficile e impegnativa che, però, comporta un innalzamento della sua natura umana.
Anche Husserl, almeno in una prima fase del suo pensiero, privilegia il momento espressivo: è in questo momento che il soggetto pensante estrinseca a sé i propri contenuti in parole, in enunciati. Nella prima parte de “Le ricerche logiche”, si propone di scoprire quale sia il punto in cui sorge il significato. Secondo Husserl ciò avviene quando il pensiero esprime i suoi contenuti, vale a dire nell’espressione della soggettività, nell’ “Ausdruch”. Husserl, infatti, ricerca le essenze, l’interiorità delle cose e l’interiorità della persona si esprime quando si fa pensiero, espressione di sé.
E’ Bühler a elaborare il concetto di “Auslösung”, assieme a Marty. Il linguaggio dev’essere tale da suscitare qualche reazione in chi l’ascolta, e questo si rende possibile quando chi parla mette l’interlocutore in grado di costruirsi il significato da sé: è il momento in cui l’altro assume valore autonomo. Scrive “Teoria dell’espressione”, ma è altrettanto vero che quest’autore valorizza, come momento dialettico, anche il momento comunicativo. Dimostra, infatti, come i due momenti vivono in contemporanea, perché l’espressione, presa da sola, è manchevole.
In educazione, come si è più volte affermato, è necessario il soggetto conosca, con l’aiuto dell’educatore, la propria interiorità per poterla, in seguito, mettere in campo, per condividerla e comunicarla. I passaggi sono due: uno - che affonda le origini nelle tradizioni filosofiche occidentali - caratterizzato dall’attenzione a sé, l’altro - che rende ragione della natura sociale dell’uomo e del suo innato bisogno dell’altro - caratterizzato dall’ attenzione alla soggettività che si pone di fronte alla propria.
L’educando, nel passaggio dal momento espressivo al momento comunicativo, si rende conto di poter-dover chiedere aiuto; l’educatore si rende conto di poter-dover educare.
Rossi insegna a non dimenticare che argomento dell’incontro con l’altro è l’esperienza interiore del singolo: questo significa considerare l’espressione come punto di partenza della comunicazione. Per compiere il passo successivo, cioè perché, in seguito, si attui vera comunicazione, bisogna abbandonare la propria espressione, per giungere anche a prendere in considerazione quella dell’altro.
“ …espressione e comunicazione vengono a costituire le funzioni linguistiche fondamentali (…) le due funzioni nell’atto linguistico si implicano reciprocamente e si integrano in una complementarietà di significati e di valori “ [223].
Così citando anche anche Gusdorf :
“ La comunione di amore, che rappresenta uno dei modi di intendersi più completi, non avviene senza una ricomposizione della personalità, ciascuno scoprendosi al contatto con l’altro.
(…) la perfetta comunicazione sprigiona dalle possibilità di espressione che sonnecchiano in noi ” [224].
La parola ha la forza grande di poter svelare se stessi, nell’incontro con gli altri. Qualora non ci fosse dono di sé agli altri – che sia un dono, citando Chieregatti, leggero, che non si impone, “invisibile” – svanirebbe la comunicazione, non sarebbe più autentica e si ridurrebbe a mero scambio di parole. Inolte, qualora non ci fosse il proposito di innestare una comunicazione - nel senso di comunicazione autentica -, l’incontro si risolverebbe in un parlare di sé vano, arido, che non troverebbe ascolto.
La parola è “consolidamento dell’ontologicità personale”, per Rossi. Attraverso la comunicazione, nel riconoscimento dell’altro, l’uomo si costruisce e lo può fare finché ci sarà incontro, senza limiti: questa è la valenza pedagogica-formativa di cui dispone, in quanto detentore della parola e della socialità.
Afferma Ong[225]: “la presenza dell’uomo è presenza della parola”, che è peccato ridurre semplicisticamente a scambio di notizie o tramite di contenuti qualsiasi da essa veicolati, perché, se sostanziata di significato, traguardi, valori, apre alla relazione profonda.
4 LAVORO SUL CAMPO
4.1 AGGANCIO FRA TEORIA E PRASSI
La dimensione teorica e quella pratica costituiscono i due lati della medaglia dell’agire educativo, verso cui, dal momento che ci si sta occupando di studio delle azioni umane, è bene volgervi un’attenzione particolare: l’essere dell’uomo, infatti, non può venire ingabbiato in nessuna di queste né in altre dimensioni, ma va studiato dal punto di vista di una prospettiva che le inglobi. Solo se ci apprestiamo a comprenderlo in termini olistici lo potremo conoscere nel modo più completo possibile. In questo senso e con questa prospettiva, pratica e teoria si compensano l’una con l’altra e, nello stesso tempo, fornendo singolarmente un contributo specifico, arricchiscono l’intervento: da una parte la teoria può fornire le chiavi di lettura della situazione problematica oggetto della nostra attenzione e dall’altra la pratica ci cala nella situazione specifica. L’educatore, nel momento in cui si trova ad operare, dovrà saper trovare un giusto equilibrio.
Delors, delinea quali siano i saperi dell’educatore: sapere, saper fare, saper essere. Non esclude nessuna delle dimensioni fino ad ora esplicitate, ribadendo il carattere peculiare della pedagogia, come scienza che si colloca a metà strada fra teoria e pratica, fondandosi sul versante del sapere, ovvero della teoria, e del saper fare, ovvero della pratica. Il saper essere le ingloba, cioè è l’argomento cardine dell’educazione, il suo tema peculiare che fa da sfondo a tutte le azioni umane: nei termini husserliani si chiama essere-nel-mondo, in virtù di questa collocazione l’uomo è pensatore, teorico e attore.
Nell’educatore, che si appresta a costruire un rapporto con l’utente, nasce l’idea teorica dell’altro - prima di averlo di fronte a sé e di intraprendere un percorso assieme - e questo avviene se egli è disposto a volgersi a ciò che non è il proprio “io”. Lo dovrà fare in modo professionale, avendo quindi alle spalle un bagaglio teorico, il che vuol dire essere entrato a contatto con ciò che della relazione e dell’Altro è stato detto dagli autori e aver riflettuto su tali argomenti anche in modo critico e costruttivo. L’atteggiamento di ricerca, di problematizzazione, di curiosità rappresentano le frecce che lo potranno portare all’agire dinamico, ricco di diverse sfaccettature provenienti dagli svariati campi del sapere.
Tradizionalmente la teoria ha sempre occupato un posto preminente, motivato dalla certezza che l’azione educativa non si potesse fondare esclusivamente sull’istinto, sul buon senso, ma che fosse necessario crearsi, prima di entrare nella pratica, una conoscenza maturata in senso “critico-riflessivo”.
E’ necessario indicare quali siano gli screzi, e non solo gli aspetti positivi, del percorso che ha voluto la teoria al primo posto considerandola “il fare ricerca scientifico”[226] per eccellenza.
Il modello tradizionale può trovare una descrizione esemplificativa nel modello della razionalità tecnica - segnato dall’eredità positivistica - di Schoen, secondo il quale l’attività professionale consisteva nella risoluzione di problemi “resa rigorosa dall’applicazione di teorie e tecniche a base scientifica”. La conoscenza era specialistica, definita, scientifica, standardizzata, la teoria era considerata presupposto della pratica e la “dirigeva”. Il rapporto fra teoria e pratica era lineare, consequenziale, seguiva una logica applicazionista.
La realtà, però, è molto più complessa di quella afferrabile esclusivamente attraverso la teoria.
Oltre a una conoscenza pre-intervento si rende ugualmente indispensabile una conoscenza di tipo pratico, relativa a “quella” specifica situazione, perché l’educatore produce e sviluppa gran parte del proprio sapere anche “in azione” e non si limita a compiere un lavoro applicativo.
La riflessione filosofica di Lévinas, Singer, fino a S.Agostino, Heidegger e Husserl e di coloro che hanno fatto dell’altro e della relazione con l’altro il nodo centrale del proprio sistema di riflessione, costituisce la base a partire dalla quale potersi calare nella pratica in modo più consapevole e preparato, ma nel contempo, per comprendere la realtà - se non nella sua totalità, almeno attraverso un’ottica il più possibile multidimensionale –, è necessaria anche la collaborazione della pratica, con cui la teoria possa innestare un rapporto interattivo, circolare, superando la visione “antagonista” dei due piani.
E’ necessario scoprire il valore euristico della pratica, che arricchisce le prospettive d’intervento attraverso tutto un bagaglio di altri saperi inafferrabili, “taciti”, che l’educatore matura agendo e sposando la teoria con l’azione. Essenziale, soprattutto oggi che si richiede in tutti i campi disciplinari un progressivo arricchimento e aggiornamento, apprendere anche nella professione.
Il sapere teorico non risponde a tutti gli interrogativi che l’educatore si pone sull’altro, né a tutte le perplessità: permette certamente di gestire l’imprevisto, di non trovarsi spaesato di fronte alla complessità, di capire i processi relazionali, di conoscere svariate tecniche comunicative e i modi migliori per aiutare, di proporsi degli obiettivi coerenti, rilevanti, necessari sulla base dei quali orientare l’intervento, ma non gli permette di rispondere automaticamente e in modo completo alle situazioni problematiche cui si trova di fronte. La scelta degli strumenti, delle tecniche di intervento, degli obiettivi non si fondano su un modello standard, predeterminato per ogni intervento, ma la scelta viene regolata in base all’utente, alle risorse umane, economiche, al tempo, di spazio, alle capacità collaborative del gruppo e a tutta una serie di incognite anche non facilmente prevedibili. Qualora conoscessimo una svariata carrellata di strumenti, ma non li sapessimo né applicare, né scegliere, non saremmo in grado di organizzare un intervento sul campo.
Dewey sottolinea quali sono i motivi per i quali l’azione pratica è ritenuta rilevante. In primo luogo “apre la mente”: sviluppa la facoltà di osservare la realtà con atteggiamento critico, rilevando i molteplici versanti di uno stesso oggetto d’attenzione e di ammettere l’errore, distanziandoci dalle considerazioni personali. In secondo luogo fa riflettere in modo consapevole sulla “responsabilità”: permette di sviluppare l’attitudine a considerare attentamente le conseguenze cui l’azione porta, andando anche oltre quelle immediate, per considerarle invece nella loro globalità. In terzo luogo favorisce “partecipazione e personale coinvolgimento” dell’educatore, che rappresentano anche la modalità con cui si compie l’attività di riflessione.
L’educatore, grazie al sapere pratico, è messo nelle condizioni di guardare da vicino i problemi e di cogliere la rilevanza di “quel” preciso contesto d’intervento; padroneggiando il sapere teorico, sviluppa un bagaglio di conoscenze tecniche e, prima ancora, la facoltà di pensare. L’un sapere non esclude l’altro, anzi lo presuppone: i fronti teorico e pratico costituiscono assieme la competenza dell’educatore. Imparare vuol dire imparare dalla formazione, continuare ad imparare e, nello stesso tempo, anche far tesoro della pratica professionale. Nel rapporto educativo ci si dispone a progettare l’aiuto e, nello stesso tempo, a dimostrare la disponibilità di aiutare, nel concreto, l’educando.
Il lavoro che viene presentato in questo capitolo è dimostrazione concreta del fatto che teoria e pratica si arricchiscono reciprocamente, che sono entrambe fondamentali per garantire l’aiuto.
4.2 CONFRONTO SUL CAMPO: CONTRIBUTI E RIFLESSIONI
Nell’incontro con i volontari ho potuto riscontrare che il loro intervento arricchisce la visione delineata nel corso dei precedenti capitoli sulla relazione d’aiuto. Quello che i volontari sono stati disposti a raccontare rappresenta un terreno prezioso e impagabile per l’intervento pedagogico, in quanto nasce dal contatto diretto, spontaneo che vede concretizzarsi la creazione di un rapporto di aiuto vissuto, partecipato. Oltre a non potersi trovare sui manuali, l’umanità di questi volontari rende merito alla relazione d’aiuto e le conferisce speranza, dimostrando la capacità dell’uomo di stare accanto ad un altro uomo e di aiutarlo, non solo a parole, ma nella piena ricchezza che l’ “aiuto” porta con sé.
Crepet[227], nel suo testo di riflessione sull’infanzia e sull’adolescenza, si pone un interrogativo:
“ Come si fa ad educare senza relazione, come si può stabilire un rapporto con un bimbo, dove non si prevista una comunicazione emotiva, quindi una carezza o un bacio? ”[228]
Risponde egli stesso proponendo di non dimenticare l’ “educazione sentimentale”, di rivalutare la capacità di “dire” e “sentire “. Intraprendere questa strada, in via di abbandono, permetterebbe di superare l’indifferenza fra gli uomini, che egli chiama “autismo reciproco”. Crepet dimostra preoccupazione per la nostra società in cui si creano situazioni caratterizzate dalla presenza di “genitori e figli ignari gli uni degli altri, coabitanti con superficialità e convenzioni”. Denuncia il fatto che, pur possedendo mezzi di comunicazione, fino a pochi decenni fa impensabili, sembriamo paradossalmente aver smarrito l’essenziale, come se il senso della nostra comunicazione fosse perduto per sempre.
Alla domanda:
“…come possiamo reinventarci una pedagogia in grado di indurre la capacità di sentire le emozioni, di farsi coinvolgere dalle passioni senza temerle come fossero un terreno infido e pericoloso?” [229],
mi sembra di poter trovare una possibile risposta proprio nel terreno del volontariato in cui, anche da parte degli operatori che ho incontrato, è dimostrata la capacità reale di aiutare senza limiti, a tutto campo, e senza la paura di lasciarsi coinvolgere affettivamente. Questa disponibilità, che dapprima nasce dal desiderio di entrare nel mondo dell’ “aiuto”, facendo qualcosa per gli altri, si fa concreta nell’incontro.
“ In questa rinnovata sensibilità per l’agire pratico si tende a metter in luce anche quanto non è possibile racchiudere in leggi e principi di natura scientifico-tecnologica, perché legato a una costruzione personale di conoscenza, competenza e senso, che deriva da una riflessione sull’esperienza ”[230]
Pellerey esprime in questo modo la necessità di valorizzare la pratica che costruisce, a sua volta come la teoria, ma in modo originale, un sapere solido sulla base degli interventi, di cui ciascun operatore ha fatto tesoro costruendosi un bagaglio anche difficilmente verbalizzabile, facente parte del sottinteso, dell’azione non cosciente, ma valida, costruita sull’esperienza.
Pellerey parla di “apprendistato etico”, termine indicante l’esistenza di una circolarità fra azione e interiorizzazione dei valori: sul campo, si ha a che fare con la dimensione axiologica e la si deve gestire nel migliore dei modi, perché è determinante per l’educando con cui si ha a che fare. L’educatore-volontario è portatore di valori, che trasmette nella relazione, è guida etica ed impara ad esserlo, essendolo.
4.2.1 Riflessione sul volontariato
Nel presente paragrafo si approfondisce il tema del volontariato, della sua importanza, con l’obiettivo di spiegare perché è stato scelto per arricchire di un’altra prospettiva, quella pratica, la presente riflessione sulla relazione d’aiuto.
Le caratteristiche del volontariato sono analizzate attentamente da Bocca[231] che le definisce in questi termini:
“ …azioni e responsabilità assunte liberamente per atto di volontà, senza l’intermediazione di un profitto, nel perseguimento di fini di solidarietà. Spontaneità, gratuità, disinteresse e continuità d’impegno nel servizio ne sembrano i caratteri costitutivi cui si unisce la maturazione di una competenza adeguata ai compiti che si intendono svolgere “[232].
Il volontario non è colui che gestisce gli interventi sulla base della spontaneità e che si dedica a questi sulla base della sporadicità, ma per Bocca il volontariato diventa vero e proprio stile di vita, non semplice occupazione del tempo libero. Segno di intervento consapevole e impegnato sono le caratteristiche portanti fondate su “gratuità, disinteresse, condivisione, continuità di impegno, socialità, attenzione privilegiata agli ultimi, globalità di approccio ai problemi, rapidità di intervento”, ma anche sulla progressiva qualificazione, l’autovalorizzazione, l’attenzione al “saper fare”, non dimenticando di riferirsi continuamente ai cambiamenti e alle esigenze della società.
Il volontario deve dedicarsi agli altri utilizzando il “dialogo come strumento di scambio”; non da ultimo, inoltre, deve dedicarsi a sé, nella “ricerca costante del proprio coinvolgimento personale”, e al sé professionale, nella consapevolezza di aver assunto un ruolo come “scelta di vita”. L’obiettivo che il volontario realizza nella relazione d’aiuto è garantire intenzionalmente una piena umanizzazione delle persone, aiutandole nella lettura dei problemi, facendo anche appello alla propria sensibilità educativa, che è risorsa.
Per arricchire ulteriormente la riflessione di Bocca sulla figura del volontario, faccio riferimento al convegno che si è tenuto nel novembre 2000, presso l’Università degli Studi di Trieste, con la collaborazione dell’ “Associazione La Ricerca“ di Trieste, cui ha partecipato, oltre a Demetrio[233], Desinan, il quale ha chiarito la portata e la ricchezza del volontariato.
Il volontariato non nasce solo dall’esperienza di aiuto, ma da un necessario, continuato, organizzato e sistematico intervento, e da scambi e confronti reciproci di esperienza: questo è stato chiamato, da Desinan, “volontariato consapevole”.
E’ necessario sottolineare l’importanza di superare l’ “ottica del laboratorio”, per ampliare lo sguardo all’ambito del vivere. Pur essendo necessaria, la metodologia non è sufficiente: il volontariato, infatti, si propone come concreto strumento di aiuto che, da una parte, nasce dall’esperienza dell’aiuto in sé, e, dall’altra, fa riferimento alle filosofie, che rappresentano la base di riferimento dell’intervento educativo.
Due le dimensioni del volontariato, quindi: consapevolezza e concretezza, lavoro non occasionale e intervento nel “mondo della vita”. Anche Desinan ritiene che il volontariato non è semplicemente un impegno temporaneo, ma diventa vero e proprio modo di essere dell’operatore: una semplice dimostrazione può essere dettata dal fatto che negli incontri la gente parla e il racconto sta alla base dell’aiuto. L’operatore impara a fare proprio un ascolto autentico, non come tecnica, ma modo di relazionarsi, che diventa acquisito, proprio della personalità stessa. Si garantisce la solidarietà, creando un clima di accoglienza, rispettando i diritti dell’uomo con la dimostrazione di ascolto, esprimendo la volontà di capire.
Viene delineata la figura del volontario come strumento-risorsa, che interviene nell’aiuto, garantendo la sua presenza costante, rassicurante, come offerta di disponibilità piena, come garanzia dei diritti dell’uomo.
4.2.2 Presentazione del centro di aiuto alla vita
L’Associazione alla quale mi sono rivolta per effettuare un approfondimento sul campo è il CAV, Centro di Aiuto alla Vita. E’ collocata in tutto il territorio nazionale e raggiunge le 250 unità, di cui la maggioranza si trova al Nord. Nella regione Friuli Venezia Giulia i Centri CAV sono situati nelle quattro province, più uno a Monfalcone.
Mi sono personalmente rivolta al Centro situato a Trieste, con sede in via Marenzi, presso il quale ho svolto il mio lavoro e al quale tutte le informazioni seguenti si riferiscono. Sempre nella stessa città, esiste una seconda sede, in via Stock, messa a disposizione dal Distretto n° 1 dell’Azienda per i Servizi sanitari triestina. Le informazioni che ho potuto raccogliere mi sono state fornite dal presidente del centro, dott. Henke, con cui ho avuto un colloquio durante il quale mi è stato presentato il Centro, e altre vengono ricavate dalla relazione del presidente stesso sull’attività svolta nel corso del 2001, pronunciata in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci CAV.
La finalità che si propone il CAV è la prevenzione dell’aborto spontaneo. La fondazione risale al 1978, anno in cui è stata approvata la legge che legittima l’aborto medico. Il Centro è aperto tutto l’anno, due ore la mattina ( 10 – 12 ) e due il pomeriggio ( 16 – 18 ), anche durante il periodo estivo, eccetto i giorni festivi. Grazie all’attivazione del servizio di trasferimento di chiamata sui telefonini di alcune volontarie si garantisce reperibilità 24 ore su 24, anche quando il Centro è chiuso.
Lavorano 40 operatori, di cui la maggioranza sono donne. Sono tutti volontari, non hanno qualificazione professionale, ma entrano a far parte attiva del volontariato frequentando alcuni incontri con esperti nel settore che forniscono le nozioni base dell’operare. Inoltre, settimanalmente si incontrano per organizzare eventuali programmi per i casi d’emergenza e per condividere le esperienze vissute personalmente, per darsi consigli a vicenda e costituire un gruppo coeso.
Il presidente ha sottolineato due aspetti chiave che costituiscono fattore di sostegno del Centro: la collaborazione e la motivazione degli educatori. La motivazione è garantita dall’adesione spontanea al Centro: in seguito ad annunci sui giornali o ad avvisi stradali, le persone si autopropongono, offrendo spontaneamente il proprio contributo; la collaborazione è presupposto di lavoro su cui si fonda il Centro ed è confermata dagli incontri fra i volontari. Al momento di formazione iniziale seguono, inoltre, altri incontri, in questo caso organizzati e di aggiornamento, con la collaborazioni di psicologi, medici o sociologi che trattano il tema dell’aiuto, delle tecniche di colloquio o delle esigenze territoriali. Si cerca sempre di partecipare, ogni qual volta sia possibile, anche ad altre occasioni, corsi, seminari e convegni organizzati da altre realtà sia dello stesso settore che da diversi campi del volontariato o istituzioni.
Il presidente mi ha presentato il CAV non tanto come organizzazione che fornisce un aiuto diretto, ma come associazione “mediatrice”: media, infatti, fra i privati - che donano regali, offerte, abbigliamento, giochi e ogni genere di materiale di cui abbisogna una madre che aspetta un bambino – , le strutture pubbliche – che prevedono aiuti, ma presso le quali le madri hanno difficoltà a rivolgersi personalmente, per timore o perché non sanno nemmeno di poter chiedere aiuto – e gli utenti.
Le donne che chiedono un aiuto al CAV si trovano in condizioni di “debolezza sociale”, dimostrano difficoltà economiche. Accanto a questo, il problema vero sembra sia quello relazionale: dimostrano bisogno di comunicare, di parlare, di condividere i loro problemi e cercare un consiglio e un aiuto. E’ generalmente la prima educatrice cui la donna si rivolge a prenderla in carico e a seguirla nel percorso di aiuto.
Le donne si recano al Centro anche per fare il test di gravidanza, non solo perché è gratuito, ma soprattutto per la necessità di sentire che qualcuno, in quel momento, è accanto a loro. Si crea uno stretto rapporto fra educatrici e utenti, in una relazione d’aiuto che va oltre il periodo di necessità primaria, nel momento in cui la donna aspetta il bambino, e oltre il tempo di apertura del Centro: le volontarie lasciano anche il loro numero di telefono di casa per farsi sentire più vicine e per dare un aiuto reale, concretizzandolo in un intervento “a tutto campo”. Durante i primi incontri, se possibile, vengono raccolti i dati anagrafici indispensabili per garantire la reperibilità dell’utente. Vengono quindi inseriti in una scheda personale, perché possano essere consultati ogni qual volta ce ne fosse bisogno, per aver sempre chiara la situazione e documentare gli interventi.
Per essere efficace, l’impegno dei volontari deve poter contare su risorse finanziarie, la maggior parte delle quali provengono dai privati e da istituzioni, come l’Azienda Sanitaria e il Comune di Trieste, con il quale, nel 2001, è stata sottoscritta una convenzione in seguito agli incontri con l’assessore comunale dei servizi sociali, dell’istruzione e con il presidente del Consiglio comunale, per definire meglio le modalità di collaborazione già in atto da anni. Inoltre, con il direttore scientifico del Burlo Garofalo è stata riconfermata la collaborazione anche con il settore sanitario-ospedaliero. Il CAV si propone per il futuro di continuare a collaborare e a potenziare i rapporti con i responsabili e gli operatori dei servizi pubblici e sanitari per garantire una sempre più approfondita conoscenza reciproca e la certezza di poter contare su svariati appoggi per sostenere le persone che richiedono aiuto.
Fra i vari progetti che il CAV realizza ( dal ’95 sono stati 29, per un importo totale di 150 milioni di lire), il progetto “Gemma” viene incontro alle donne che non sanno se tenere o no il bambino, finalizzato ad aiutarle a dire di sì. Le offerte vengono direzionate alle regioni a partire dal Centro di Milano, a cui vengono inoltrate le richieste. Si attua nei primi tre mesi di attesa, quando la donna non ha ancora deciso per la vita. Questo rappresenta un tentativo per aiutarle a cambiare idea, a concretizzare l’accettazione. Consiste in un aiuto economico di 5.400.000 lire, distribuite nel corso di diciotto mesi, di cui sei mesi prima del parto. Non viene dato l’aiuto solo alle persone che non hanno mezzi: il progetto vuole aiutare chi è nel dubbio. Si è cercato, infatti, di intervenire anche nei confronti di ragazze che avevano possibilità economiche ma che, essendo molto giovani e pesando ancora sulla famiglia di origine, si sarebbero sentite rincuorate per il fatto di poter contare su una risorsa da gestire personalmente. Una delle volontarie che si occupa della contabilità consegna l’assegno una volta al mese e tiene un rapporto scritto con i donatori, che “adottano” la madre, dando informazioni sul bambino, sulla sua nascita, spedendo le fotografie. Il rapporto tra donatore e beneficiario è anonimo. Trascorsi i diciotto mesi, si conclude il progetto.
Il CAV, inoltre, grazie ai contributi dei sostenitori del Centro, dispone di due appartamenti da mettere a disposizione delle coppie in difficoltà.
La diffusione d’informazioni conta sul passaparola delle donne, ma anche su linee informative vere e proprie: vengono diffusi a pagamento i manifesti sugli autobus e altri gratuitamente in negozi, farmacie, parrocchie e nella pubblica via. Il CAV è intervenuto anche nelle trasmissioni radiofoniche regionali della RAI e dispone di un sito internet, messo a disposizione dalla rete civica del comune di Trieste. Fra altre ricorrenze, è una tradizione l’intervento nelle S. Messe delle chiese cittadine in occasione della giornata per la Vita (4 febbraio). Il CAV è stato presente anche in alcune scuole della città di Trieste per svolgere un’opera di sensibilizzazione del problema aborto e orientare i giovani al volontariato.
Annualmente, a partire dal 1981, i rappresentanti dei Centri regionali si incontrano, organizzando convegni di confronto, di bilancio, di progettazione per il futuro.
Vengono di seguito presentati alcuni dati statistici relativi alla storia del Centro, dalla sua nascita fino all’ultimo anno di rilevazione dati, per dare idea del lavoro che è stato compiuto dalla sua istituzione e della portata dell’aiuto che si è potuto dare alla vita.
Dal 1978 si sono rivolte al Centro 1214 mamme; sono nati con l’aiuto delle volontarie del CAV 806 bambini. Si è verificato un picco attorno all’anno ’84 e una crescita significativa a partire dall’anno ’88, mantenuta nel tempo.
Non tutti i casi che sono stati seguiti hanno potuto dare esito positivo, ma è evidente il prevalere dei successi:
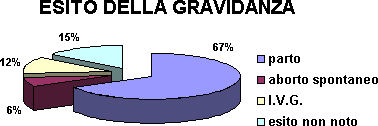
Sempre sul totale dei casi cui il Centro, dalla sua apertura, ha potuto portare aiuto, relativamente allo stato civile delle donne:
Non tutte le donne sono italiane, pur essendo la prevalenza:
Gli Stati di provenienza delle donne straniere sono significativamente svariati: Albania, Jugoslavia, Russia, inoltre si sono presentati casi singoli per la Polonia, il Portogallo, il Marocco, il Madagascar, la Mongolia.
Accanto alla carrellata storica è anche interessante rilevare alcuni dati relativi all’ultimo anno di attività appena conclusosi, il 2001.
Per la prima volta si sono avvicinate al Centro 72 mamme in attesa, 63 con bambini piccoli. Rispetto alla media annuale statistica, pari a 50,6 , si è verificato un aumento. Si tenga conto che vengono registrate solo coloro che si rivolgono per la prima volta al Centro, mentre almeno altrettante richiedono aiuto anche dopo il primo incontro.
Fra le donne che hanno chiesto di poter effettuare il test di gravidanza, 49 hanno ottenuto un esito positivo, 14 negativo.
Sono nati 43 bambini. Anche in questo caso, confrontando tale dato con la media statistica, pari a 33,6 , si è verificato un ulteriore aumento.
Sono, inoltre, continuati i rapporti con 148 altre mamme già incontrate in anni precedenti, di cui 88 erano in attesa di un figlio.
In media in ogni giornata d’apertura si registrano una telefonata e tre presenze, per un totale di circa 501 telefonate all’anno.
Relativamen te al caso delle straniere, la nazionalità delle donne che hanno contattato il centro nel 2001 è così ripartita:
Sempre nel corso dell’anno 2001, si è verificato che il problema più sentito dalla donna posta di fronte a una gravidanza inattesa è la solitudine e l’incomprensione. Si aggiungono alla solitudine e l’aggravano, le difficoltà materiali:
Su 15 donne dubbiose sul proseguimento della gravidanza o determinate ad abortire:
Tra le 15 donne, tre si erano già presentate con il certificato medico, ma nessuna di queste ha abortito.
4.2.3 Incontro con le educatrici: il colloquio d’aiuto sul campo
Nell’esperienza di lavoro sul campo effettuata al CAV, è stato posta un’attenzione particolare alla modalità di realizzazione della relazione d’aiuto attraverso il dialogo. Il tema di argomento in merito al quale sono stati intervistati i volontari-educatori è stato il colloquio con gli utenti.
Strumento di indagine
Lo strumento di lavoro scelto è stato l’intervista semistrutturata, preferito all’intervista libera o, all’opposto, a quella strutturata per due motivi.In primo luogo l’intervista libera avrebbe rischiato di farmi ottenere dati troppo generici, difficili da elaborare e che avrebbero potuto sviare dal mio argomento di interesse, vale a dire la relazione d’aiuto e la sua modalità di esecuzione nel concreto; in secondo luogo, dovendo entrare nel merito delle modalità di lavoro dei volontari, acquisite anche faticosamente attraverso esperienze personali, mi è sembrato opportuno cercare di dimostrare interesse pieno relativamente a tutto quello che volessero dirmi, lasciando più spazio all’ascolto e al colloquio, piuttosto che dare l’impressione di voler unicamente ottenere dati. La questione relativa alla modalità di attuazione della relazione d’aiuto sul campo mi pare lungi dall’essere un aspetto riassumibile in risposte sintetiche a domande prestabilite, ma, all’opposto, ricca di implicazioni con il proprio stile di vita personale, con i valori, con la propria affettività che possono emergere più facilmente in un dialogo, pur strutturato, ma libero.
Nel colloquio faccia a faccia che ho avuto modo di realizzare con i volontari ho ascoltato di persona le esperienze che hanno voluto condividere con me. E’ stata un’occasione di conoscenza reciproca, un’occasione di riflessione fatta assieme sul tema in questione, più che un incontro generico sul tema dell’aiuto o un’incontro sbrigativo inquadrato nella compilazione di questionari.
Sono stata soddisfatta di questa scelta, perché ho notato come si sia potuto dare il giusto spazio ai volontari che desideravano raccontare in modo anche dettagliato esperienze vissute sulla propria pelle. E’ stata l’occasione anche per un mio arricchimento personale.
Dall’altra parte, si è anche cercato di non interrompere il loro lavoro richiedendo troppo tempo. E’ stato utile procedere in questo modo per evitare che gli educatori avessero l’impressione di essere interrogati sulle loro personali modalità di lavoro e per orientare l’intervista verso una libera conversazione sul tema.
Prima di cominciare il colloquio, cercando di mettere a loro agio i volontari che avrebbero dovuto raccontarsi, mi presentavo a mia volta, dicendo il mio nome e spiegando brevemente il motivo per il quale mi recavo al Centro e mi rivolgevo loro. Specificavo che la mia competenza nel campo della relazione d’aiuto è soprattutto teorica, quindi, pur conoscendone nello specifico le dinamiche, avrei avuto molto di imparare da loro che, invece, vivendola di persona sul campo, acquisiscono una competenza a me sconosciuta. Mi disponevo come chi ha tutto da imparare ed è interessato a tutto ciò che si può dire sull’aiuto così come viene realizzato nel Centro.
Le interviste venivano registrate, mentre, nel contempo, annotavo a penna alcuni punti salienti del loro discorso e cui loro davano maggiore importanza. Prima di cominciare, i volontari venivano avvertiti del fatto che si sarebbe rispettato l’anonimato. Mi è sembrato, in alcuni casi, che alcune volontarie entrando nella saletta dove svolgevo le interviste e vedendo il registratore appoggiato sul tavolo, prendessero quasi paura. Le avvertivo che avrebbero potuto liberamente scegliere di non essere registrate, se questo avesse comportato a loro difficoltà nell’esprimersi o imbarazzo, e che in ogni caso le cassette registrate avrebbero solo avuto la funzione di evitare la distorsione dei loro pensieri e sarebbero state riservate ad un uso strettamente personale. Tre dei sedici volontari intervistati hanno comunque preferito io prendessi unicamente appunti: due per motivi personali, perché hanno affermato si sarebbero sentite a disagio, inoltre fra loro una volontaria doveva stare contemporaneamente attenta che non arrivassero persone a cercarla e che avessero bisogno di lei; la terza perché riteneva di essere entrata da troppo poco tempo nel Centro e di non avere molto da raccontarmi, anche se in realtà ho potuto ricavare un racconto vero e proprio pari a quello di tutti gli altri intervistati.
Stabilito il tema principale di mio interesse sul quale si sarebbero dovuti orientare e in merito al quale chiedevo loro di parlare liberamente, venivano invitati a raccontarsi. Nel corso del loro intervento facevo di tanto in tanto domande precise, cercando di non interromperli, finalizzate sia a riorientare la discussione sull’argomento fissato affinché non fosse perso di vista, sia ad approfondire alcuni aspetti di particolare interesse. Si sono scelti i sottotemi in seconda battuta, in base alla situazione, nel corso dell’intervista. Si è cercato di fare in modo che soprattutto dodici[234] fossero costanti, per poter successivamente elaborare i dati.
Con alcune volontarie, particolarmente disposte a raccontarsi, è capitato anche di sviare dall’argomento e vedere l’ “intervista” come, in un certo senso, occasione di confronto. Una volontaria in particolare mi chiedeva che cosa io ne pensassi, quali competenze, difficoltà, secondo il mio parere, costituissero la relazione d’aiuto.
Molte di loro mi hanno raccontato alcuni casi che avevano dovuto affrontare, anche perché sembrava loro più facile, attraverso esempi, mostrarmi come si interviene. Mi è parso che fosse anche un’occasione benefica per loro stesse, come momento per poter pensare - attraverso un procedimento di metacognizione - a se stesse nell’intervento, guardandosi “dal di fuori”, in un’ottica caratterizzata da una certa oggettività: è capitato che mi dicessero dei loro interventi positivi, ma anche degli sbagli. Senza paura di giudizio da parte mia, mi hanno raccontato come intervengono, dimostrandosi a volte - soprattutto coloro che da meno tempo sono parte del Centro, nel paragone con le colleghe “più anziane” di esperienza - critiche nei propri confronti.
Solo in alcuni casi è stata necessaria una più intensa partecipazione da parte mia al discorso, ma credo che questa variabile possa essere ricondotta al carattere delle persone e alla loro facilità o meno a raccontarsi di fronte a chi non conoscono.
Non ho avuto particolari difficoltà, perché oltre a cercare in prima battuta di mettere a loro agio le volontarie, la stessa casa hanno fatto loro con me. Essendo la prima volta che intervistavo delle persone anche io ho avuto dei momenti di disagio, ma le volontarie stesse mi sono venute incontro rispondendo alle domande o, per esempio, coinvolgendomi con intercalari che richiedevano un assenso o l’esplicitazione del mio parere.
Ho riportato in appendice le interviste dei volontari nella loro globalità. Per garantirne la continuità ed evitare rischi di frammentazione ho escluso le domande - cui a volte rispondevano spontaneamente senza che io le proferissi - che hanno caratterizzato il mio intervento. Il rispetto dell’anonimato è il motivo per il quale ho scelto il numero per indicare le interviste e non il nome delle persone intervistate.
Numero degli intervistati
Sono stati intervistati sedici volontari, quindici donne e un uomo.Non si è potuto stabilire fin da subito né il numero dei volontari che sarebbero stati intervistati, né i giorni in cui mi sarei dovuta recare per intervistarli, quindi nemmeno i nominativi dei volontari stessi. Questo soprattutto per cercare di conciliare, di volta in volta, gli impegni e per evitare il più possibile il disturbo, valutando sempre le possibilità/disponibilità. Concluso il lavoro di una giornata, mi facevo consigliare dai volontari relativamente a quando avrei potuto ritornare al Centro per svolgere le interviste, scegliendo anche possibilmente i giorni in cui sarebbero stati presenti in maggioranza coloro che si occupavano del colloquio - essendo i turni composti anche da coloro che si occupano di altre mansioni, come il guardaroba o la contabilità -, sia perché così in una sola occasione potevo effettuare il numero più alto possibile di interviste, sia perché loro avrebbero più facilmente potuto alternarsi nel lavoro.
Tempo e luogo delle interviste
Il luogo in cui si sono svolte tutte le interviste è stato il Centro. Il Centro dispone di due salette appartate - dove normalmente i volontari si incontrano per i colloqui assieme agli utenti -, che sono state anche il luogo dei colloqui svolti con me. In alcuni casi ci siamo seduti in uno dei salottini nell’atrio di attesa, soprattutto se i volontari dovevano stare attenti alle persone che avrebbero potuto arrivare e chiedere di loro. Le interviste, infatti, si sono svolte tutte quante durante l’orario di lavoro, essendo più agevole per me personalmente reperire i volontari, senza fissare di volta in volta degli appuntamenti personali che tenessero conto dei rispettivi impegni.Dal momento in cui i turni comprendono la partecipazione, contemporaneamente, anche di tre, quattro volontari, uno alla volta, venivano intervistati da me, mentre gli altri potevano gestire il lavoro. E’ stato necessario, in alcuni casi, sospendere per qualche minuto l’intervista, perché il volontario era richiesto da qualcuno nel Centro, ma sempre, anche nonostante il lavoro, hanno dimostrato grande disponibilità e addirittura si scusavano per il fatto di essersi dovuti allontanare. I volontari sono stati avvisati dal presidente che avrei chiesto la loro collaborazione per completare il quadro della tesi sulla relazione d’aiuto. In seguito, a partire dal primo incontro, di volta in volta, concordavo con una di loro il giorno in cui sarei tornata e questa avvisava le colleghe del turno corrispondente.
Mi sono recata al Centro sei volte, corrispondenti a tutti i giorni della settimana in cui era aperto, preferendo la mattinata. La prima volta è stato venerdì pomeriggio, giornata in cui si svolgeva la riunione di Giunta, occasione in cui ho parlato con il dott. Henke e ho conosciuto alcune volontarie.
Procedendo in questo modo ho potuto incontrarmi con quasi tutti i volontari che si occupano del colloquio. Ogni volta intervistavo in media tre volontari. La durata delle interviste è varia, vanno da una decina di minuti anche ai tre quarti d’ora, soprattutto nel caso delle volontarie che facevano parte del Centro per più tempo e, da una parte, avevano già maturato una modalità di lavoro strutturata, solida, ragionata, preparata della quale rendermi partecipe, dall’altra, avevano affrontato una svariata carrellata di casi di cui avevano fatto tesoro. Nella media, le interviste si aggirano attorno ai venti minuti.
Essendo un’intervista di tipo semistrutturato, ho cercato di adattarmi, sia alle loro esigenze, al lavoro che avrebbero dovuto fronteggiare, sia a quello che avrebbero desiderato raccontare. Quando subentravano altri impegni, poteva capitare che il colloquio venisse velocizzato, quindi, anche in questo senso, si possono giustificare le interviste più succinte. Viceversa, nel caso in cui potevano permettersi di ritagliare un po’ più di tempo per raccontarmi diversi aneddoti per arricchire l’intervista, ho cercato di raccoglierli per capire il più possibile la loro modalità d’approccio.
Argomenti di discussione
Il tema principale è: “Come si realizza il colloquio”.E’ stata fissata una scaletta di sottotemi, che venivano proposti solamente nel corso del colloquio e non venivano preannunciati. La struttura dell’intervista potrebbe essere in questo modo schematizzata:
Come avviene il primo incontro
Come rassicurare
Come far perdere la paura di chiedere
Chi parla di più
Come avviene il dialogo vero e proprio, il racconto della storia
Quando è più facile la persona si racconti
Quali sono le condizioni idonee
Come conquistare la sua fiducia
Parla liberamente l’utente o viene sollecitato
Dal punto di vista dell’educatore: impatto e coinvolgimento
Come capire l’interlocutore
Come gestire il distacco, com’è vissuta l’empatia
Come gestire la sospensione del giudizio
Il ruolo del dialogo, considerazioni e difficoltà
Quanto aiuta il dialogo
Quanto è il posto che viene dedicato al dialogo
A che modalità è affiancato
Analisi dei dati
L’analisi dei dati viene effettuata in rapporto agli argomenti che sono stati considerati dai volontari chiave nella relazione d’aiuto.A partire da questa sessione di analisi, per aiutare il lettore a focalizzare l’attenzione sugli aspetti teorici che trovano perfettamente corrispondenza nell’operare quotidiano dei volontari del Centro, visivamente ho scelto un segno di spunta particolare (>) e il corsivo.
LA MODALITA’ GENERALE DI INTERVENTO
La quasi totalità degli utenti che si rivolgono al Centro sono donne che si presentano da sole. Lo sforzo che i volontari cercano di far fare alle utenti è quello di lavorare su loro stesse, trovando la forza di andare avanti, ma anche di cercare sostegno e un possibile aiuto nel coinvolgimento del partner e della loro famiglia di origine, che capita anche siano all’oscuro della situazione di difficoltà che la donna vive. Sono rari i casi in cui la donna si presenta con il fidanzato o il marito, mentre ancora più rari sono i casi in cui la prima mano tesa alla ricerca di aiuto è quella di un uomo, anche se una volontaria mi ha raccontato di aver accolto un padre che da solo si era rivolto al Centro per trovare sostegno e evitare che la compagna rifiutasse il figlio.
I volontari ritengono che l’atteggiamento presupposto per la costruzione di una relazione consista nel mettere a proprio agio gli utenti, affinché possano esprimere liberamente le loro necessità.
L’aiuto è gratuito, incondizionato, costante nel tempo, immediato e si protrae fino al momento in cui vengono realizzati i bisogni manifestati dall’utente, intervenendo su diversi livelli e andando oltre il sostegno immediato. Parte dalla problematica specifica - l’intervento nei confronti della donna in difficoltà per la gravidanza attesa - e si svolge secondo la dinamica accoglienza / ascolto/ accompagnamento.
L’aiuto offerto dal CAV si orienta su due fronti ben precisi: il sostegno materiale e quello spirituale. Per la maggior parte dei casi inizialmente i problemi esposti da fronteggiare sono prima di tutto economici e questi – ritengono le volontarie –, pur nella loro drammaticità, sono i più facilmente risolvibili: vengono forniti vestiti e tutto ciò di cui si abbisogna per il bambino; le mamme vengono anche aiutate a trovare casa e lavoro, a compilare carte burocratiche, a orientarsi nel territorio, a prenotare le visite mediche dove, nel caso si manifestasse la necessità, vengono accompagnate di persona.
L’importante, fatti i primi passi per creare un rapporto di fiducia, è la conoscenza del caso, del problema reale per il quale le donne si sono recate al Centro: si cerca di soddisfare la prima richiesta di tipo materiale e anche il bisogno di supporto, di ascolto. Il presupposto base è rappresentato dalla convinzione che per aiutare sia importante conoscere.
Trattandosi di questioni personali, delicate, bisogna essere disposti a offrire una disponibilità e un’accettazione incondizionata in nome del rispetto della persona e fare in modo che anche gli utenti si sentano al centro dell’attenzione. Non ci si accosta a loro secondo la prassi d’ufficio, ma dal punto di vista umano-affettivo. La comprensione, la disposizione nei confronti dell’altro sono ideali teorici che, nell’incontro, si fanno reali.
Ø Realizzare sul campo la propria intenzione di accostarsi all’altro rivolgendogli piena attenzione è un concetto che risponde perfettamente alla convinzione di Desinan[235], secondo il quale si può parlare di aiuto solo nella misura in cui questo diventa “essere di fronte”, “accostarsi”, “accompagnare”. Egli afferma che non basta una pedagogia dei buoni propositi, ma si richiede una pedagogia dell’intervento, dell’azione concreta che richiede preparazione e disponibilità.
L’aiuto diventa tale quando entra nelle vita dell’educando, quando e se può effettivamente cambiare il suo disagio, predisponendolo al miglioramento [236]. Parallelamente i volontari del CAV dimostrano di essere presenti nella relazione d’aiuto, oltre le parole, oltre l’immediatezza dell’intervento, oltre l’apertura del Centro, “essendoci” realmente.
Una volontaria ha affermato che le difficoltà di coloro che si recando al Centro, fin dal primo momento in cui vi entrano, potrebbero già dirsi in parte risolte, perché trovano qualcuno su cui contare, grazie a cui superare la condizione di solitudine, non intesa tanto come isolamento rispetto ai contatti sociali, ma come assenza di persone che danno sostegno e condividono un particolare e prezioso – anche qualora le utenti stesse non se ne rendessero subito conto - momento della vita.
La chiave dell’aiuto è capire il vero problema e farlo capire alla persona stessa, farla ragionare, chiederle che cosa voglia realmente e, nel caso in cui lei stessa non lo sapesse, invitarla a guardarsi dentro. Viene invitata a chiarirsi anche attraverso il dialogo, momento estremamente delicato da gestire per il volontario che deve orientarsi fra la necessità di ottenere informazioni e la non invadenza: a volte non è necessario porre domande, perché gli utenti parlano spontaneamente, ma se questo non accade, bisogna far capire che si è disposti ad aiutare e che, per poterlo fare, non si può prescindere dalla fiducia e dalla collaborazione. L’educatore-volontario si dimostra disponibile, accogliente e riservato, non troppo curioso, in possesso competenze frutto di esperienza, pazienza, autoriflessione e formazione.
Ø Il fatto di non dimostrarsi curiosi può anche essere occasione per far capire all’utente che è rispettata la sua riservatezza, ma anche la sua autonomia. L’ideale teorico corrispondente consiste nel considerare l’educando come essere libero[237] che attraversa un itinerario che lo porta al distacco dall’educatore. Evitare che l’educando impari a dipendere e a sviluppare una personale capacità di lettura-risoluzione delle difficoltà, esprimendosi come essere responsabile – fermo restando il fatto che non è mai solo – è uno degli obiettivi cardine della relazione d’aiuto, sia nella teoria che nella modalità pratica d’azione attuata dal CAV.
Una volontaria ha sottolineato quanto sia impegnativo mobilitarsi, non considerando tanto difficile il momento dell’ascolto nel dialogo - che diventa progressivamente una personale modalità di incontrare l’altro -, quanto la “presa in carico” nella sua complessità, il rapporto anche al di là del colloquio. Disporsi di fronte a una persona che chiede aiuto è una responsabilità di cui i volontari hanno sottolineato la portata e le ripercussioni personali, dettate dal coinvolgimento. Sono un grande sostegno la collaborazione e il confronto fra i colleghi: l’aiuto può definirsi come lavoro di rete, necessario per garantire all’utente un sostegno globale e ai volontari la possibilità di completarsi reciprocamente.
Il sostegno all’utente, però, non è interamente responsabilità dell’educatore: la modalità di intervento che il CAV si propone è di puntare sulla persona. Il coinvolgimento, la riflessione sulla responsabilità personale sono messaggi volti a richiedere agli utenti la disposizione a essere attivi decisori: bisogna far capire che, al di là dell’analisi - da effettuare assieme ai volontari - sulle diverse strade da intraprendere, l’ultima scelta sarà la loro. Non vuol dire lasciarli soli di fronte alle difficoltà, ma richiamare la loro responsabilità e consapevolezza che la vita è frutto di una costruzione personale. I volontari dichiarano di non sentirsi di imporre scelte, per quanto le considerino giuste, ma di mettere in primo piano sempre la libertà di chi si trovano di fronte.
Ø I volontari del CAV nell’operatività seguono il presupposto teorico del personalismo[238] e della scommessa bertoliniana[239] sulla capacità del soggetto di attivarsi come protagonista della propria esistenza, mettendo in pratica, anche inconsciamente, la significazione. L’utente viene invitato a guardarsi dentro, a scoprirsi – passo declamato dalle diverse filosofie e, come diceva una volontaria, insegnamento utile e addirittura indispensabile per la vita – discernendo, fra tutte le influenze alle quali è sottoposto, il proprio modo di vedere il bambino e il significato che personalmente attribuisce alla sua presenza nella vita.
Nel corso degli incontri, vengono esplicitate tutte le possibili strade da intraprendere, si cerca di far capire perché si ritenga una scelta migliore di un’altra, se sia davvero la migliore, se sia davvero l’unica soluzione realizzabile. Si cerca di far pensare al fatto che il bambino c’è già. Anche se sembra un ingombro, una rinuncia alla propria vita, le volontarie invitano a guardare il lato positivo: è un accrescimento, dà tante gioie. Accogliendo il punto di vista dell’utente, gli si mostra anche l’altra angolatura della realtà, quella più positiva, che è facile venga trascurata perché le preoccupazioni prendono il sopravvento.
Bisogna, afferma una volontaria, “scavare” nelle persone per costruire e condividere un percorso di aiuto assieme, accompagnarle, cercando di comprendere cosa avvenga dentro di loro, focalizzando l’attenzione su un punto: il problema principale. Tanti problemi vengono esposti e ne sono la conseguenza: non vengono risolti fino a che “la causa” non viene trovata, esplicitata, affrontata. Il volontario deve disporsi sempre nella dimensione della possibilità, non lasciandosi mai prendere dallo sconforto, non abbandonando mai la speranza, né farla mai abbandonare.
Ø Come per Alberoni - precedentemente citato - così per i volontari prende piede e diventa modalità e possibilità d’azione affidarsi alla speranza[240], che è direttiva, motivazione, spinta per aiutare a superare assieme tutte le difficoltà nell’esistenza, senza però dimenticare il contatto con la difficoltà che la realtà nella sua concretezza porta con sé.
L’importante è che ci sia stato l’impegno, ha dichiarato più di qualche volontaria, anche se poi la situazione non va a buon termine; l’importante è essersi interessati, aver cercato di dare il meglio. Essendo l’insuccesso frequente, essendoci una scelta vita-morte incombente, il rapporto si può esaurire anche in un unico incontro. Bisogna fare i conti con l’incertezza della donna, riuscire a essere rapidi nel trovare un appiglio per creare la relazione d’aiuto. Questo campo di intervento si caratterizza per la sua delicatezza: non si accoglie solo la persona, ma una persona che, a sua volta, ha dentro sé un’altra creatura, che è “senza voce”.
Ø Per fronteggiare il burnout[241] che il lavoro sul campo comporta, un espediente dei volontari - che mi è parso fornisse anche un input in più rispetto a quelli trovati nei libri – consiste nel fare il possibile per aiutare. Il burnout dal quale cercano di tutelarsi non è tanto quello relativo alla “fatica di dare e di darsi”, ma il bruciamento conseguente alla colpevolizzazione per non essersi dati abbastanza. Esiste certamente la necessità e il tentativo di “staccare”, per non soffrire troppo, ma la disponibilità mi è sembrato avesse indubbiamente per loro la priorità.
Alcune volontarie hanno affermato di basare il proprio intervento sulla spontaneità, seguendo l’istinto e quello che il momento richiede per dare conforto; altre si sono dichiarate preoccupate per le persone e hanno considerato la preparazione come uno “scudo” di fronte alle incertezze e alle difficoltà da superare.
Assieme a loro si è convenuto che una variabile fondamentale, impossibile da inquadrare o da analizzare, è rappresentata dal carattere soggettivo e dalle esperienze personali. Nel colloquio, sia educatore che educando intervengono come persone uniche: sia l’aiuto che la risposta degli utenti dipendono molto dalle peculiarità individuali. Questo spiega da una parte la diversità di accostamento ai casi, che emerge dalle interviste alle volontarie e di cui solo in parte, in sede di analisi, si può avere una chiara idea; dall’altra potrebbe essere motivo che spiega gli insuccessi negli interventi, dettati dalla libertà e unicità di pensiero dell’utente.
Dopo aver presentato, a grandi linee, le modalità sulla base delle quali il CAV si propone di impostare la relazione d’aiuto, si cerca ora di analizzarne singolarmente le “fasi” del colloquio.
Prima di entrare nel merito di ogni concetto, ho scelto alcune frasi estratte dalle interviste dei volontari per “riassumere” e motivare la scelta del concetto relativo e la sua importanza nell’intervento di aiuto, ma anche per introdurre alla descrizione di ogni fase utilizzando le parole dei volontari stessi, aprendo una finestra sulla loro sensibilità.
DISPONIBILITÀ’
“ Bisogna prenderla per mano, accompagnarla come fosse la propria figlia “.
“ Il primo caso che ho avuto qui nel 1986 lo sto seguendo ancora oggi ”.
“ C’è entusiasmo…io sono una persona che se faccio una cosa la faccio con amore, prima di tutto, la faccio spontaneamente e di buona volontà “.
Già dal momento dell’accoglienza deve essere chiaro agli occhi degli utenti la disponibilità dei volontari ad aiutare. Secondo tutti i volontari con i quali ho parlato, rappresenta il centro focale della dinamica d’aiuto nella sua complessità e la condizione perché il rapporto possa andare a buon termine.
Diversi segni vengono rivolti alle persone che si recano al Centro, sia durante il primo incontro, sia nel corso della relazione: si punta a dimostrare che la disponibilità non è solo un proposito, ma si fa aiuto concreto. Gli utenti vengono informati di tutti gli aiuti che il CAV può fornire, in termini materiali e di contenimento di fronte alle difficoltà. Questo è già un modo per dichiararsi “ a disposizione” dell’altro e, nel contempo, per conquistane la fiducia.
Ma la disponibilità è anche molto altro: è dimostrare interesse per la persona e per quello che racconta; è dimostrare vicinanza; è assicurare la riservatezza, facendo capire che non la si tradirà mai, che è rispettato l’anonimato; è dare garanzia di essere presente nel caso arrivasse una richiesta urgente oltre gli orari del Centro e oltre quelli del proprio turno; è cercare di non dare l’impressione di perdere tempo, ascoltandola, anche se ci sono altri impegni, magari arretrati, da sbrigare; è far capire che la disponibilità è impegno personale che si ha piacere di realizzare, pur nelle difficoltà che questo comporta; è prenotare le visite, accompagnare chi vorrebbe avere qualcuno vicino ma è solo e non ha appoggi né dalla famiglia né dal partner; è andare incontro alla persona quando arriva al Centro e abbracciarla a fine colloquio, dando una dimostrazione di affetto; è farsi dare un recapito e chiamarla la sera per sapere come sta; è dichiarare di poter anche parlare con il partner o con la famiglia; è offrire la propria sensibilità; è far capire che non si chiedono i dati per divulgarli, per una statistica, ma per aiutare; è disporsi ad un aiuto “completo”, accettando la responsabilità che questo comporta.
La disponibilità viene manifestata dalle volontarie del Centro anche nel periodo successivo al parto e anche nel caso sia stata presa una strada diversa da quella proposta. La persona viene contattata anche attraverso il telefono, per farle capire che il rapporto può continuare, che non la si vuole abbandonare nella sofferenza, nel senso di colpa.
Segno per eccellenza della disponibilità di condividere con l’utente un periodo di vita accostandosi alla sua difficoltà è l’ascolto.
La disponibilità, però, non deve essere un requisito a senso unico, ma deve coinvolgere anche le persone che richiedono l’aiuto: devono poter parlare, ma anche tener conto dei consigli, seguendo il percorso di riflessione che viene loro proposto; devono soprattutto dimostrare lo sforzo di provare a conoscersi, di immaginare la presenza dentro sé del bambino.
Da parte degli utenti c’è, secondo la maggioranza dei volontari, una disponibilità di partenza innegabile, perché anche il solo fatto di presentarsi al Centro è segno che vi hanno riposto speranza e che vedono i volontari come persone realmente disposte all’aiuto. Quello che è importante è che capiscano di essere supportate e che l’intervento non è solo finalizzato a far accettare loro il bambino, ma a far comprendere in modo pieno e maturo il valore della vita, anche insito nel poter dare vita.
Ø Questa modalità di intervento corrisponde a quanto è stato detto in merito ai presupposti per costruire la relazione richiesti a educatore e a educando: entrambi devono voler rispettivamente realizzare e ricevere l’aiuto[242].
Inoltre, il rapporto non si vuole concludere semplicemente risolvendo le problematiche manifestate, ma deve intervenire nei confronti della globalità dell’utente[243] da aiutare nel percorso di maturazione personale.
Relativamente a quanto affermato in rapporto all’handicap da Rovetto[244] è inutile insegnare a compiere azioni meccaniche, bisogna aiutare a concettualizzare. Così, nel caso dell’aiuto alle donne in stato di gravidanza, è ulteriore responsabilità dell’operatore insegnare alla persona il suo sbaglio che ha determinato la situazione di difficoltà, per prevenirlo nel futuro e, inoltre, aiutarla non solo ad accettare il bambino, ma ad amarlo. L’intervento si dimostra estremamente ampio e complesso, ma solo così – ha anche affermato una volontaria – diventa aiuto alla Vita, certamente più difficoltoso, ma fondato su basi solide.
RESPONSABILIZZAZIONE
“ L’importante è farla riflettere, mettendola comunque in guardia, rendendola pronta ad affrontare con responsabilità le difficoltà “.
“ …noi possiamo fare fino ad un certo punto, perché le persone devono comunque essere libere “.
“ …lei deve capire il valore della vita, bisogna puntare su questo, il valore della maternità… la responsabilità non solo di far nascere il bambino: avere un bambino, infatti, non vuol dire solo farlo nascere, no? “.
La persona viene immediatamente coinvolta come madre, per fare in modo che, fin da subito, prenda coscienza della sua nuova condizione. Le viene fatto presente che l’aiuto esterno può servire solo se si trova l’interesse e l’impegno, anche da parte sua, ad aiutarsi.
L’intervento non si conclude con la risoluzione del problema dettata dall’educatore, perché deve essere parte attiva anche e soprattutto l’educando, che poi è la parte interessata: si interviene sia stando vicino alla persona, sia, nello stesso tempo, insegnandole a camminare con le proprie gambe.
Secondo una volontaria con cui ho parlato è controproducente dire “Non fa niente” e soprattutto non è questo il modo di affrontare gli imprevisti della vita. Bisogna metterla di fronte alla situazione. Nel percorso di aiuto, le persone, anche giovani, sono condotte per mano, non sono sole, però sono sollecitate a coinvolgersi, a non restare indifferenti di fronte ai cambiamenti che nella loro vita ci sono stati e che dovrebbero essere portate ad accettare, per apprezzarne il lato positivo. La volontaria, infatti, mi spiegava che lei non interviene dicendo che non ci sono problemi, ma che la vita cambia, che ci saranno tanti sacrifici rispetto ai quali è necessaria la disposizione ad affrontarli.
Il fatto che la donna venga condotta a guardare con responsabilità le difficoltà, rende importante trattare anche un altro argomento: il Centro interviene per tutelala, anche rendendola cosciente del fatto che la responsabilità si ripartisce. La donna deve sentirsi “parte in causa”, ma dovrebbe poter condividere il peso o comunque la difficoltà con il proprio partner, invitato ad esprimersi e a non ritenersi estraneo alla decisione. Anche in questo senso viene razionalizzata la nuova condizione e vengono poste le premesse per sviluppare una nuova consapevolezza.
Questa riflessione riconduce all’idea dell’opportunità di realizzare una relazione d’aiuto che si svolga a partire dalle due dimensioni umane, interiore e sociale, e che tenga sempre in gran conto la capacità - da potenziare e valorizzare - della persona di essere responsabile di se stressa.
Ø Coerentemente con il presupposto della pedagogia, i volontari del CAV mettono al centro del proprio intervento la persona, con le sue capacità da far emergere, e scommettono[245] sulla sua possibilità di riuscita: impiegano tante energie e speranze perché sanno che assieme ai loro utenti si può realizzare un aiuto alla vita; sanno che il loro impegno può non essere vano perché credono nella capacità umana di fronteggiare e risolvere i problemi. Più di qualcuna ha affermato che la maturazione passa attraverso il superamento degli ostacoli della vita, non permette di schivarli: il ruolo degli operatori consiste nell’essere accompagnatori degli educandi nel percorso di maturazione, per intraprendere il quale, però, gli educandi stessi devono sentire il desiderio di essere aiutati.
Vengono di seguito presentati gli altri concetti ritenuti rilevanti nell’aiuto, che hanno la caratteristica di combinarsi vicendevolmente fra di loro. Mi è sembrato che anche i volontari stessi pensassero al rapporto con le utenti rilevando una certa complementarietà fra gli atteggiamenti di accoglienza telefonica – primo incontro di persona; fra la riflessione su chi parla di più e la modalità con cui si svolge il dialogo; fra l’ascolto delle parole e del non verbale; fra distacco e ripercussione; fra diversità di fronte all’altro e non giudizio.
ACCOGLIENZA
“ Nell’accoglienza noi cerchiamo di essere (…) molto rassicuranti, nel momento in cui la persona (…) viene qua dentro già con l’idea di fare la scelta dell’aborto…l’approccio è molto difficile “.
“ E’ proprio una questione di saper agganciare per non perdersi per strada “.
“ Quando vengono le persone per i colloqui è un momento difficile…”
Accoglienza è la parola d’ordine che deve caratterizzare i due differenti approcci con le persone: il primo contatto per telefono e l’incontro diretto. Certamente già il primo impatto deve trasmettere all’utente la disposizione ad aiutarlo e a venirgli incontro, facendogli superare eventuali blocchi emotivi o di diffidenza. Entrambe le modalità di incontro non devono essere di carattere burocratico, ma si devono proporre come accoglienza umana ed entrambe richiedono competenze specifiche.
Per quanto riguarda l’approccio telefonico il volontario si presenta dicendo il proprio nome, in modo tale che l’utente possa fare altrettanto e, inoltre, sappia successivamente di chi chiedere. C’è il rischio che l’utente usi questo mezzo per mantenere l’anonimato e sia difficilmente disposto a fornire i propri dati o addirittura a farsi risentire: la non rintracciabilità potrebbe segnare la fine di una relazione d’aiuto che avrebbe potuto realizzarsi.
L’ideale sarebbe ottenere i dati principali, facendo appello alla propria abilità di “agganciare” la persona, garantendo la riservatezza di tutti i dati e di qualunque informazione venga fornita: orientare il dialogo nella dimensione del “privato” e del rispetto della privacy è un modo per sgomberare le difficoltà di inizio.
Secondo alcune volontarie, nell’approccio con la persona che prende il primo contatto telefonicamente, la difficoltà consiste nel doverla convincere a farsi vedere, a recarsi di persona al Centro. “L’importante è vedersi”, mi ha detto una volontaria. Per farne capire anche all’utente l’importanza – infatti l’aiuto “da vicino” può concretizzarsi nel modo migliore - un’altra volontaria ha affermato che la sua “tecnica” consiste nel non dire tutto per telefono, ma nel lasciare curiosità, per sollecitarlo a recarsi all’incontro. Dicendo che non è possibile parlare liberamente per telefono, perché non si possono trattare argomenti così delicati in fretta, in modo staccato, e che di persona se ne può parlare in modo più approfondito, si può anche riuscire a vincere la diffidenza.
Per quanto riguarda l’incontro diretto, primo vero incontro – trattato nella seguente “fase” -, si devono cercare le premesse per creare un rapporto intimo, convincendo gli utenti che tutti i loro problemi resteranno segreti. Nel caso in cui il rapporto cominci con la telefonata, vedersi di persona è una meta necessaria verso cui approdare per poter cominciare il rapporto d’aiuto.
Ø L’accoglienza così come viene attuata nel concreto risponde alla necessità teorica che l’educatore sia guida e detenga il controllo: dispone della possibilità di allontanare o avvicinare l’utente, a seconda della sua capacità di coinvolgerlo, convincerlo, di trasmettergli fiducia e disponibilità. Egli è stato considerato “strumento” della relazione d’aiuto[246], così come i volontari hanno dimostrato di esserlo. Tuttavia, a loro volta, anche gli operatori devono disporsi a imparare ad arricchirsi nell’incontro, senza far pesare all’educando la caratterizzazione asimmetrica del rapporto. Nella relazione d’aiuto, l’amicizia – che generalmente non accetta diversità – diventa possibilità reale, perché sembra educatore ed educando siano effettivamente sullo stesso piano, soprattutto perché l’educatore dà senza pretendere riconoscimento, ma interpretando il miglioramento delle condizioni del soggetto come la più significativa soddisfazione personale.
PRIMO INCONTRO
“ Il primo incontro è il momento più delicato e difficile, in cui si crea il rapporto, si stabiliscono le basi “.
“ L’approccio iniziale è sempre un po’ titubante, diciamo. Si cerca di mettere queste persone a proprio agio “.
“ E’ importante e difficile cercare di mantenere il dialogo per dare il primo aiuto “.
Dalla maggioranza dei volontari è giudicato il momento più difficile, perché è quello in cui si stabiliscono le basi per la costruzione di un rapporto, che possa essere strumento e speranza di aiuto. Si devono creare i migliori presupposti per una relazione interpersonale di fiducia, disponibilità reciproca, avente l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche e spirituali in cui la persona si trova.
Generalmente, come ci si propone di fare nel corso del primo aggancio telefonico, si cerca di raccogliere informazioni, dati personali. E’ necessario, nel compiere questo passo, valutare la reazione della persona che, desiderando mantenere l’anonimato, in alcuni casi potrebbe risultare disturbata dalla presenza di fogli di schedario. Una volontaria ha affermato di aver effettuato i primi incontri con un’utente, senza sapere nemmeno come si chiamasse. Da quest’esperienza ha dedotto che ci possono essere altre occasioni per trascrivere dati, magari con il consolidarsi del rapporto, magari in un momento di minor tensione emotiva.
Accade che le persone si rechino a chiedere aiuto anche in lacrime, che espongano svariati problemi, per cui non si riesce a capire nella globalità la situazione, ma quanto basta per cominciare a operare.
Sarebbe auspicabile cercare di avere un colloquio privato, che il dialogo fosse a due e non vi interferisse nessuno, né altre utenti, né altri volontari. Un modo per dare un’impressione di assoluta confidenza consiste nello stare a fianco della persona, non mettendo in mezzo neanche la scrivania, che potrebbe fungere da “barriera”. Gli utenti non si devono sentire come negli uffici, ma devono avere la sensazione si stia realizzando un incontro umano, che si protrae per tutto il loro percorso di difficoltà. Bisogna premettere che si è accanto a loro per aiutare, non per giudicare e che, da parte loro, per essere aiutati, devono parlare, spiegare. Non è conveniente aggredire con le domande, cercando di capire già tutto al primo incontro anche perché, se la persona non ha parlato subito nell’impeto del bisogno, dice tutto spontaneamente, senza sforzo, dopo che si è rilassata. In questo senso, si realizza una prima espressione del rispetto dei suoi tempi per vincere la paura o la riservatezza.
Ø Questa modalità di lavoro richiama perfettamente quanto è stato detto sul tema della comunicazione, sulla delicatezza costitutiva del dialogo, soprattutto nel caso si tratti di situazioni difficili.
Nell’incontro il soggetto B ( l’educatore) fa in modo che il soggetto A (l’educando) sia disposto a incontrarsi ancora, a intraprendere un percorso di relazione, a verbalizzare i propri pensieri[247]. L’altro deve essere lasciato libero di parlare e di esprimersi, nel rispetto dei suoi tempi, dell’eterocronia.
Il primo incontro è un momento fondamentale perché l’utente studia la volontaria, il Centro, valuta l’opportunità di riporvi fiducia: c’è grande responsabilità, “ci si gioca tutto”, ha affermato qualcuna delle volontarie. Sono determinanti le prime parole e come vengono pronunciate, anche se la relazione d’aiuto non si riduce a queste né in esse si esaurisce totalmente.
CHI PARLA
“ …meno si parla, più l’altro parla ”.
“ …in genere io parlo molto poco, anche per cercare di capire… “
“ Non si deve dare l’impressione di invadere il suo campo, ma le domande sono finalizzate all’aiuto ”.
Due differenti approcci, giustificati dalle diversità soggettive, vengono realizzati nell’aiuto a seconda l’utente porti avanti un dialogo spontaneo o difficoltoso.
Nel primo caso più che far domande, si lascia parlare la persona. Alcune volontarie hanno ammesso che chi viene a chiedere aiuto ha estremo bisogno di sfogarsi, quindi parla spesso spontaneamente, senza aver bisogno di sollecitazioni, perché desidera condividere le difficoltà con qualcuno che si disponga nei suoi confronti ad un ascolto reale. Le utenti con facilità rispondono alle domande, perché hanno bisogno estremo di essere ascoltate.
Nel secondo caso, invece, si è di fronte a una persona che vive la difficoltà in modo diverso - forse più personale, privato - oppure non è abituata a parlare in modo approfondito e a fidarsi. Capita le utenti abbiano paura che non sia rispettata la loro privacy o di essere giudicate. Confidano che il caso di cui stanno parlando riguarda un’amica, mentre, in seguito, dichiarano di essere loro stesse le interessate.
Ø Anche in ambito teorico si è riflettuto sul caso in cui l’educando dimostri resistenza e su quanto sia più difficile operare in queste condizioni. Da parte loro, i volontari hanno dimostrato di saper superare questo ostacolo – coerentemente con quanto detto in teoria – con il dialogo. Rispetto a tali difficoltà non mi hanno mai manifestato alcun atteggiamento di impazienza, ma tutt’altro.
L’ascolto, la disposizione totale verso l’utente sono atteggiamenti gratuiti, naturali, spontanei che dimostrano, nella sequenza di incontri, di condurre per la maggior parte dei casi all’obiettivo sperato: l’accettazione della relazione d’aiuto.
Bisogna far parlare e quando ciò accade è segno che stanno crollando le resistenze; bisogna far emergere le capacità di relazionarsi con i volontari, senza voler mantenere segreti che potrebbero rischiare, invece, di ostacolare il tentativo di risoluzione delle difficoltà. Gli utenti vengono aiutati a parlare, sollecitati attraverso domande e, qualora non si sentissero di recarsi di persona al Centro, vengono invitati a incontrarsi da un’altra parte, viene dato loro il numero di telefono privato e la disponibilità a ricevere chiamate in qualunque ora.
Per quanto riguarda il tempo da dedicare al colloquio, alcune volontarie affermano che non è necessario parlare troppo a lungo, anzi sarebbe addirittura controproducente: gli utenti potrebbero interpretare la ripetizione come colpevolizzazione. Pur non essendo la rilevazione di una colpa lontanamente l’intento delle volontarie, gli utenti devono esserne convinti, soprattutto perché già sentono come un peso la responsabilità di trovarsi in un momento difficile e perché non vedono via d’uscita. E’ necessario, proprio per aiutarli ad affrontare le difficoltà, fare in modo che si dispongano positivamente a realizzare la relazione d’aiuto nel modo più sereno possibile.
Secondo altre volontarie, invece, è necessario protrarre il colloquio finché la persona si sentirà rassicurata.
DIALOGO
“ C’è un dialogo che si viene ad instaurare ”.
“ Il dialogo deve essere sempre molto pacato e non invadente… ”
“ …trovare le parole giuste, come si troverebbero per un’amica ”.
Per evitare che la persona si spaventi, il dialogo deve essere molto pacato, non invadente. E’ lo strumento che permette all’educatore di scoprire la situazione, ma perché questo accada, non ci dovrebbe essere il senso di fretta, condizione non sempre possibile da realizzare.
Molte volte capita che le persone si rechino al Centro senza chiedere niente altro e senza dimostrare problemi economici, semplicemente per parlare. Nel momento in cui si “affidano”, è fondamentale trovare le parole giuste, di conforto, di consiglio, dimostrazione che si ha capito la situazione.
La disposizione a fare domande dipende anche dal carattere della volontaria, più o meno espansivo, con più o meno esperienza. La maggior parte, però, ha affermato di evitare di fare domande, seguendo il principio secondo cui meno si parla più l’altro, che ne ha particolare bisogno, parla. L’importante è non essere aggressivi, non “puntare il dito”, non far pesare il fatto che viene chiesto aiuto, ma nemmeno trattare gli utenti con compassione.
Non raramente i volontari hanno confessato la grossa difficoltà nella costruzione del dialogo, per l’impegno, la responsabilità, l’interessamento e la disposizione totale, per la difficoltà di avere a che fare con casi che si collocano completamente al di là dei propri valori. Eppure, proprio nelle difficoltà, nell’affrontarle, nasce la vicinanza: una volontaria, in particolare, ha affermato che il dialogo che si crea può essere chiamato “comunicazione amichevole”: sdrammatizzando tutta la portata di complessità, l’ha paragonato a quello che si userebbe di fronte ad un’amica.
Il diverso grado di percezione delle difficoltà da parte dei volontari dipende anche dalla drammaticità o meno dei casi che hanno affrontato nel corso delle loro esperienze precedenti. Fra le componenti costitutive del dialogo che l’educatore deve realizzare, oltre alla consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo, è necessaria anche una disposizione di serenità, ottenibile grazie alla “spartizione delle responsabilità” con le colleghe –con le quali ci si confronta per dipanare le strade possibili di risoluzione del caso – e con l’utente stessa.
Ø Il dialogo, che si potrebbe considerare momento successivo all’ascolto, è anche occasione per dimostrare che si è ascoltato e che ci si vuole mobilitare nella direzione della risoluzione dei problemi che l’educando ha esposto.
E’ condizione necessaria, indispensabile che, proprio come affermato in linea teorica, deve rispondere a regole ben precise. La modalità con cui i volontari lo attuano risponde perfettamente all’osservazione di precisi principi, alcuni dei quali sono stati precedentemente esposti nella tesi[248]: lo dimostrano manifestando spirito critico-riflessivo sul proprio operato e chiedendosi continuamente come intervenire in modo più appropriato. Cercare i pilastri del rapporto di aiuto per garantire serenità e disposizione di fiducia nelle utenti mi è sembrato un intento sempre vivo fra le volontarie, che hanno dimostrato flessibilità e diffidenza all’idea di lavorare sulla base di schemi prestabiliti. Piuttosto hanno desiderio di continuare a imparare da se stesse - fidandosi della propria volontà di aiuto - dagli altri volontari e anche dagli specialisti nei momenti di formazione.
ASCOLTO
“ Cerchiamo soprattutto di ascoltare. Fondamentale è l’ascolto “.
“ L’ascolto è fondamentale, perché ascoltare con attenzione è un po’ diverso dal sentire - infatti sentiamo parecchi rumori senza porvi attenzione -, è forse la posizione che più ci dispone a capire la persona e a far sì che la persona capisca che in quel momento tu la stai capendo, che stai camminando al suo fianco “.
Per definire l’importanza dell’ascolto sono state generalmente usate poche parole ma chiare, con le quali si è posta questa disposizione al centro della relazione d’aiuto. E’ fra le altre condizioni chiave, realmente il fondamento primo di ogni rapporto, a cui nel percorso di aiuto è dedicato il maggior tempo possibile, visto il bisogno manifesto dell’utente di trovare comprensione e accoglienza “visibili” nell’ascolto.
Ø Alla domanda posta alle volontarie, relativa a come si effettuasse la costruzione del rapporto con l’utente, rispondevano che, fondamentalmente, il loro compito consisteva nell’ascolto.
Come affermato più volte in sede teorica, essere ascoltato trasmette la sensazione di essere accettato, di non essere solo, di trovare comprensione e quindi aiuto[249].
Saper ascoltare, afferma Salomè, vuol dire dare spazio all’altro, anche ai suoi silenzi[250]; contemporaneamente ci si dà tempo per capire, partecipare e subito dopo razionalizzare le problematiche.
I volontari attuano sul campo una vera e propria pratica di ascolto partecipato, nel senso che danno all’altro la possibilità di essere libero, di dirsi senza paure e, da parte loro, trovano in questo momento l’occasione per sforzarsi di acquisire il loro punto di vista.
Nella pratica si dimostrano professionisti della conoscenza umana: una volontaria ha affermato di saper conoscere le persone che si rivolgono a lei affidandosi all’ascolto costante, interessato, concentrato. Mi è parso che ai loro occhi esperti gli utenti fossero libri aperti, sia vista la loro competenza relativa alla problematica delle gravidanze, sia visto il loro interesse reale ad aiutare, che diventa motivazione a conoscere a fondo il caso.
Molte volte ai volontari capita di aver già sentito la stessa problematica precedentemente sia dalla stessa persona che da altre, ma ciò non viene fatto trasparire, né impedisce l’ascolto.
E’ la modalità di intervento che più dispone a capire la persona e a farle capire che in quel momento le si è accanto. Questo, per prima cosa, trasmette fiducia e le dimostra che se si è lì vicino non è per caso, ma per condividere quel momento difficile. Il colloquio possibilmente deve, nella sua prima fase, portare la persona a parlare ”a fiume”, per poi poterla ascoltare. Si cerca di fare in modo torni, non si difenda, ma si apra alla prospettiva del cambiamento e della maturazione.
Diverse volte gli utenti dimostrano di non avere necessità materiali, ma chiedono espressamente solo di essere ascoltate, magari dieci minuti. A mio avviso il fatto che ai volontari del CAV sia esposta tale richiesta è sintomo sia della rilevanza del loro ruolo, sia della loro capacità di alleviare le sofferenza. Le parole di conforto – hanno affermato alcune – nascono sul momento, ma ciò che più conta è l’attenzione verso la persona, la trasmissione della sensazione che tutto quello che dice è realmente compreso e che lei stessa e il suo benessere rappresentano l’interesse primo. Questo atteggiamento si trasmette anche attraverso i gesti, lo sguardo, il sorriso.
ASPETTO NON VERBALE
“ Ci sono anche degli atteggiamenti che vengono usati per dimostrare disponibilità, o il modo stesso di parlare, la disposizione… ”
“ …la voce deve essere dolce… “
“ …un sorriso a volte non costa proprio niente…un bacino, una carezza “.
Ø La convinzione delle volontarie che l’aspetto verbale sia una componente altrettanto importante quanto il dialogo nella relazione d’aiuto rispecchia perfettamente l’insegnamento della scuola di Palo Alto, secondo la quale non si può non comunicare[251], e la riflessione di Salomè che avvalora il silenzio attribuendogli significato in rapporto a quello che sa trasmettere: anche oltre le parole, le persone dialogano.
L’ascolto non riguarda solo le parole, esprime un’attenzione privilegiata per la persona che sta di fronte a sé e che si sta cercando di capire nella sua totalità, per poter progettare in seguito un percorso di aiuto da attuarsi secondo le modalità più produttive. Nella relazione sono implicati anche tutti quegli aspetti che vanno oltre le parole e che, accanto ad esse, trasmettono partecipazione, attenzione, disposizione o, al contrario, disinteresse, chiusura.
La questione relativa agli aspetti facenti parte del non verbale riguarda due fronti: da un punto di vista il non verbale mette in luce le emozioni sia dell’educatore che dell’educando, dall’altro può aiutare a esplicitare tutte quelle disposizioni che favoriscono la costruzione di un rapporto di fiducia - posto che la fiducia è una questione che va oltre le parole e riguarda il modo in la persona si pone.
Per quanto riguarda il primo aspetto, una volontaria ha affermato che, nel momento del colloquio, osserva com’è la persona, l’ascolta, anche andando oltre le parole. L’ascolto, secondo lei, riguarda l’altro nella sua globalità, conosciuto attraverso la gestualità, le espressioni del viso, lo sguardo, il movimento delle mani. Anche questi segni permettono di leggere e interpretare il disagio, che viene portato a galla, per poi essere affrontato assieme. Questa dimensione fa anche capire perché alcune volontarie hanno affermato di essere in grado di conoscere la persona anche se non parla molto e deve essere sollecitata. Le parole non sono l’unico mezzo di comunicazione che viene usato nel colloquio, anche se così potrebbe apparentemente sembrare.
Da parte dei volontari - ed entrando anche nel merito del secondo aspetto che riguarda il non verbale, ovvero il favorire la fiducia -, il tono di voce dolce, l’atteggiamento disponibile che si esprime anche nella scelta del posto da occupare attorno al tavolo sono alcuni dei segnali che dimostrano interesse ad aiutare, e, nello specifico, anche accettazione dell’altro e possibilità di “contatto” . Uno degli accorgimenti suggeriti da una volontaria consiste nel far trovare il tavolo vuoto per dimostrare che l’attenzione è concentrata sull’utente e molte altre anche hanno sottolineato il valore dell’abbraccio a fine colloquio. La vicinanza fisica permette di trasmettere un’associazione vicinanza-partecipazione interiore.
Le persone che chiedono aiuto devono sentire che dai volontari ricevono anche affetto e che il rapporto non è solo una profilassi da seguire meccanicamente, ma ha a che fare con l’incontro umano. La vera funzione dell’incontro fra educatore ed educando è proprio la rassicurazione, la testimonianza che c’è qualcuno che elimina la portata demotivante della solitudine. Basta anche un sorriso per trasmettere queste sensazioni, l’atteggiamento è quello che conta, non è semplicemente completamento delle parole, ma sembra davvero essere la condizione per disporre le basi di fiducia da parte dell’utente: nel rapporto entrano in gioco le parole, quanto l’umanità. Tanto varrebbero, infatti, buoni propositi se non si concretizzassero o se fossero smentiti dall’atteggiamento.
L’educatore, quando si dispone di fronte all’altro, lo fa anche contando sulla base di tutta quella serie di caratterizzanti che possono essere considerate parte, in un certo senso, del non verbale, come l’età o il sesso. Tali aspetti vengono trattati in questo contesto perché vanno al di là di ciò che nella relazione può essere controllato, non sono neutri ma, al contrario, indipendentemente dalla volontà di entrambe le parti in gioco nel rapporto, condizionano. I volontari stessi affermano che la questione dell’età non è indifferente, infatti le ragazze più giovani sembra si sentano protette dalle persone più mature, per il fatto di avere a che fare con qualcuno più grande di loro. Anche essere uomo o donna dispone in un certo modo, può darsi che le donne parlino più volentieri con le donne, anche se - afferma l’unico volontario col quale sono riuscita a parlare – è probabile che quando le persone si recano al Centro per chiedere aiuto, non si preoccupino tanto del sesso dell’operatore, quanto della sua disponibilità ad aiutare e dell’accoglienza o si basano sul fatto che si sono create le condizioni per un rapporto di simpatia reciproca.
Ciò che, al di là delle distinzioni individuali, caratterizza l’incontro in ogni sua tipologia è la percezione della complementarietà fra non verbale e verbale che si sostengono reciprocamente per raggiungere l’obiettivo comune della relazione d’aiuto: la salvaguardia dell’uomo.
DISTACCO
“ Per quanto riguarda il coinvolgimento personale, le dico la sincera verità, non ho assolutamente difese “.
“ …c’è un farsi forza per aiutare la persona “.
“ …personalmente io non mi sono mai messa in mezzo, per non far capire alla persona che io ho agito in un modo e ho agito bene“.
Il tema relativo al distacco viene sviluppato secondo due ottiche - che non è detto si oppongano, dal momento che è a volte capitato, infatti, convivessero nella stessa persona, la quale considerava entrambe come auspicabili. Si tratta della necessità di “prendere distanza” e la necessità del coinvolgimento.
E’ certo che fra chi aiuta e chi è aiutato si crea un rapporto, il più delle volte duraturo nel tempo. Le persone tornano spontaneamente al Centro, anche dopo aver superato il periodo di gravidanza, oppure vengono chiamate dalle volontarie che desiderano informarsi sulle loro condizioni di salute o serenità e per restare in contatto. In alcuni casi si cerca il recapito, se non è stato dato dall’utente, per avere notizie, dichiarare la disponibilità a seguirle ancora, anche se la decisione presa è altra rispetto a quella che era stata consigliata. Nell’aiuto si crea un vero rapporto di “amicizia”.
Il coinvolgimento è una caratteristica fondamentale del rapporto umano, necessario, secondo alcune, per capire lo stato d’animo dell’utente, per entrare in relazione empatica con lui, per dare un aiuto appropriato, per rendersi conto del momento terribile, conflittuale che l’utente sta vivendo. Se non c’è passione non si può fare niente, ha detto una volontaria.
Nello stesso tempo, però, se la comprensione dell’altro passa attraverso l’empatia, la possibilità di risolvere la situazione passa attraverso la razionalità: se ci si lascia coinvolgere troppo emotivamente, non si riesce a trovare vie d’uscita, perché già la persona è emotivamente stravolta e reagendo allo stesso modo non le si è d’aiuto. “Non si risolve niente se, invece che in uno – ha affermato una volontaria – si piange in due”. E’ necessaria lucidità, che diventa conquista impossibile nel momento stesso in cui ci si lascia prendere dal sentimento. Il problema deve essere ben calcolato, ben concepito: in un primo momento ci si “impossessa” del caso, come se stesse succedendo a sé, quindi, assieme alla persona si cerca la soluzione con più obiettività.
Inizialmente è difficile conciliare questi due atteggiamenti, è l’esperienza che aiuta. Si deduce che anche l’educatore stesso deve affrontare un percorso personale di maturazione.
La consapevolezza dell’importanza del distacco, però, non fa perdere di vista ai volontari quanto sia arricchente e impagabile relazionarsi con le persone, pur con tutta la sofferenza che questo comporta. Un’altra consapevolezza dei volontari riguarda il valore del proprio impegno: una volontaria ha affermato che quando si comincia questa attività non ci si può tirare indietro anche perché si vive un incontro diretto con le difficoltà e ci si sente in dovere di sollevare le persone che le provano e sono meno fortunate.
Ø I volontari trovano nell’esperienza sul campo la risposta – lontana dai ragionamenti teorici, ma vissuta sul campo – alla scelta anche a loro imposta fra burnout ed empatia.
Quella che propongono non è una soluzione definitiva, ma una riflessione – ragionata e conseguente all’operatività – che evidenzia pro e contro di entrambi gli atteggiamenti. Sia coinvolgimento che distacco sono necessari per poter intervenire, per capire – da una parte - e risolvere – dall’altra – i problemi.
In sede teorica grande preoccupazione suscitava l’idea di rimanere coinvolti, quasi coincidesse con la perdita del proprio ruolo o della propria identità, per colpa dell’identificazione. La linea direttiva proposta da quasi tutti i volontari invece - convinzione maturata dal lavoro pratico quotidiano - tiene soprattutto conto della necessità di empatia e distacco contemporaneamente.
Affetto e “presa in carico professionale” sembra siano due aspetti che si compensano e che gli educatori stanno molto attenti a “dosare” per salvaguardare la propria sfera emotiva e non soffrire troppo, ma anche per garantire in questo modo l’aiuto dell’altro.
RIPERCUSSIONE
“ Le difficoltà più grandi da gestire sono quelle a livello relazionale in cui è fondamentale trovare le parole giuste al momento giusto, perché altrimenti può rischiare vadano via scontente “.
“ …quando si fallisce, non si riesce a convincere la persona a non abortire, lo si registra come un proprio fallimento, ci si sente un po’ in colpa…un po’ molto…per il fatto di non essere stati all’altezza “.
Quasi la totalità dei volontari, parlando della propria esperienza, ha espresso l’inevitabilità del fallimento. Fa parte dell’intervento la possibilità che questo vada a buon termine, oppure che si risolva in modo negativo o perché la donna decide di abortire o perché non si riesce a costruire una relazione d’aiuto.
L’educatore deve prepararsi ad avere a che fare con ostacoli che non riesce a superare, anche se il suo approccio deve sempre essere improntato sulla speranza e sulla fiducia nel recupero e nel risollevamento dell’ utente.
Una volontaria mi ha parlato di “semplicità della persona”: un modo per non farsi prendere dallo sconforto di fronte al negativo è non pretendere da sé di risolvere tutti i problemi del mondo. Un’altra ha affermato di non parlare della responsabilità dell’educatore, quanto di quella dell’educando: c’è sensazione di dispiacere, ci si sente amareggiati se non si ritiene opportuna la scelta dell’utente, ma bisogna necessariamente “cedere” di fronte alla sua libertà.
Oltre a considerare, a monte del rifiuto dell’aiuto, il “libero arbitrio” dell’utente, le volontarie hanno anche aggiunto tutta la serie di dinamiche esterne al loro rapporto con lui – riguardanti le sue relazione interpersonali con il partner, la famiglia e i condizionamenti ricevuti da loro – rispetto alle quali loro non possono avere alcuna influenza. I volontari infatti possono dare delle indicazioni all’educando, orientandolo sempre verso la strada della riflessione, dell’autonomia della decisione o, eventualmente, del confronto, ma tutto sta nelle mani dell’utente che è decisore anche nella “non decisione”, anche nel “farsi condizionare”.
Ai volontari spetta, da parte loro, un costante e profondo lavoro su di sé, accostato ad un impegno di formazione continua e di riflessione sul vissuto - come alcune di loro hanno affermato – per imparare a vincere il senso di colpa, la sensazione di non essere state all’altezza. E’ facile sentirsi inadeguati, in questo volontariato, colpevoli, perché l’insuccesso è frequente e continuamente incombe, soprattutto quando si ha a che fare con persone determinate, che si sfogano, ma non si danno né danno possibilità di aiuto.
Una volontaria ha affermato che la caratteristica del lavoro di aiuto è sentirsi coinvolte quotidianamente a livello mentale: anche se ci si reca solo una volta alla settimana al Centro, la disponibilità è costante.
I volontari hanno espresso gli effetti concreti del coinvolgimento e come questo viene vissuto. Non si può dire la preoccupazione che ho visto nei loro volti per i casi più problematici, segno di un interesse umano, su un piano che si colloca al di là dell’interesse per il semplice lavoro, e segno della motivazione che li ha spinti verso il volontariato.
DIVERSITA’ DI FRONTE ALL’ALTRO
“ …comunque io parto da una posizione, non posso nasconderla ”.
“ …i miei principi sono sempre rimasti uguali, però ho imparato a staccare, a togliere le mie osservazioni. Siccome ho dovuto seguire delle situazioni che avevano proprio tutto quello che era contrario a come io credevo le cose dovessero andare “.
L’accoglienza è spontanea, immediata: in primo luogo, perché ci si rende conto che gli utenti hanno bisogno di aiuto e, inoltre, perché si impara a fare in modo che il giudizio e la “simpatia” siano estranei alla relazione.
Nelle prime esperienze, in particolare, bisogna superare la difficoltà di relazionarsi con l’altro, con la persona diversa. Col tempo si acquisisce una modalità di aiuto che si fonda sull’accettazione incondizionata.
Ø Un riferimento teorico più volte trattato nel corso del testo, specie in riferimento a Bauman, è la paura del diverso. Si è anche affermato - e lo si dimostra sul campo – come questo sia sentimento iniziale, dovuto a diffidenza, ma che ben presto viene superato e si carica di portata assolutamente positiva: ci si rende contro, proprio nell’incontro, di quanto, pur essendo sempre diversi gli uni agli altri, gli uomini si possano infinitamente arricchire.
Una volontaria ha dichiarato che il contatto con l’altro è sempre una questione di “feeling”, reazione incontrollata che inevitabilmente fa parte del rapporto. Per questo è necessario che l’utente abbia sia la possibilità di costituire una relazione d’aiuto con la stessa volontaria, sia di cercare qualcuno con cui si trovi meglio, tutto purché non abbandoni il contatto con il Centro. La volontaria ha affermato che, già dal primo contatto telefonico, chiarisce all’utente che può valutare di persona se continuare a rivolgersi a lei o cercare un’altra, ma l’importante è che provi a dare avvio ad un incontro, perché c’è la disponibilità di tutte.
Alla diversità, anche di valori e di condizioni di vita, ci si avvicina tramite la comprensione. Si cerca di leggere dentro gli utenti, nei loro sentimenti, guardando come vivono la situazione attraverso quello che dicono e quello che fanno intendere, attraverso i gesti, l’atteggiamento. Lo strumento primo, costante, indispensabile per capirli, per accettarli, per accostarsi all’alterità, è l’ascolto.
Si impara a relazionarsi con le persone col tempo, pazienza, passione, ricordandosi sempre che, nella loro povertà, nella loro difficoltà e soprattutto in queste stesse condizioni, sono persone.
NON GIUDIZIO
“ Si cerca chiaramente di ascoltare tanto, senza fare tante domande, ma ascoltare e basta, non tanto dire il nostro parere, ma non giudicare, perché dobbiamo sempre metterci dalla parte di chi parla “.
“ Sono già loro stesse che si sentono valutate e che si colpevolizzano …“
“ Siamo qua come confessori…ascoltiamo, non giudichiamo “.
“ …non sono per l’invadenza, la forzatura, per il giudizio, dire – Tu fai così, quindi sbagli -. No, non mi sento di colpevolizzare “.
Ø La professionalità con cui i volontari gestiscono il non giudizio richiama i principi della scuola di Palo Alto, sostenitrice dell’esistenza di una dimensione relazionale con l’altro difficilmente percepibile dalla persona che la trasmette con il proprio comportamento: agli altri inviamo sempre messaggi di accettazione o rifiuto sulla base dei quali si dà avvio o meno all’aiuto stesso[252]. Questa dinamica risulta inconscia, ma dall’operatore – una volta nota la sua esistenza e la sua importanza – può essere controllata: parallelamente le volontarie, coerentemente con il principio dell’accettazione incondizionata, hanno imparato a risolvere la questione della diversità attraverso la sospensione del giudizio e la comprensione, per concretizzare l’avvicinamento.
Anche il non giudizio è uno dei presupposti per l’aiuto: l’intervento dell’educatore che opera nei casi in cui emerge, con forza, la sofferenza delle persone deve essere caratterizzato da estrema delicatezza. Oltre a richiedersi una costante disponibilità e attitudine all’ascolto, è opportuno tenere sempre sotto controllo gesti e parole. Il volontario non deve tradire l’utente - del quale, anche con fatica, ha conquistato la fiducia - dimostrando di non condividere le sue scelte passate, presenti o future che siano; non deve dimostrare invadenza; non deve trasmettergli l’idea che è lui stesso a possedere le soluzioni giuste; non deve dire alla persona che sbaglia o che ha sbagliato.
Il giudizio fa crollare la fiducia, perché crea nell’educando la convinzione che l’aiuto sia soggetto a determinate condizioni - riconducibili per esempio dalla necessità di mettere in pratica i consigli dati dall’educatore -, mentre al contrario la relazione d’aiuto non prescinde assolutamente dall’innegabile libertà umana, né vuole snaturarla in nome del “giusto consiglio”. Non bisogna far trapelare i propri valori e a volte nemmeno i consigli che si ritiene portino alla risoluzione della difficoltà. Questo vale soprattutto di fronte ai casi più complicati.
Molto spesso non si condivide quello che le persone hanno fatto, ma bisogna assolutamente prescindere da questo, non valutare quello che sta dietro alle situazioni per le quali gli utenti chiedono aiuto, anche perché, fra l’altro, là sta la radice della loro sofferenza. Semplicemente bisogna prendersi carico del problema e, nelle parole – così ha detto di fare una volontaria - prescindere da quello che si pensa, garantendo innanzitutto conforto, sostegno.
E’ capitato anche che il parere di alcune volontarie fosse diverso: senza voler minimamente contraddire la necessità di sostenere la persona e garantirne il rispetto, sembra opportuno, invece, dichiarare apertamente il proprio punto di vista, ma non per contrapporlo o ancor peggio sovrapporlo a quello dell’utente, quanto per dipanare le diversità e relazionarsi nella chiarezza. Anche questa sarebbe una forma di rispetto, che si esprime in modo diverso.
L’obiettivo, pur nella varietà degli interventi dei volontari è sempre superare il giudizio, per non provocare senso di rifiuto nelle utenti e per non farle ulteriormente sentire inadeguate, in colpa.
Se il proposito primo del Centro consiste nel garantire un aiuto incondizionato, si deve intervenire, servendosi dell’ascolto e dell’accoglienza, per il superamento delle difficoltà. In questo senso il giudizio non avrebbe alcun valore, né ruolo per garantire tale modalità di intervento.
Ø L’obiettivo verso il quale il CAV si dirige rispecchia perfettamente quello della relazione d’aiuto, espresso in linea teorica: l’ e?poc? o sospensione del giudizio, funzionale a conoscere e capire.
Una volontaria ha affermato che non c’è motivo di considerare lecita la possibilità di giudicare solo per il fatto di essere state più fortunate nell’assegnazione da parte del Destino dei posti da occupare nella vita.
Considerazioni conclusive sul presente lavoro sul campo
Il mio intento di svolgere con i volontari l’intervista in modo tale che si avvicinasse a una discussione sulla relazione d’aiuto si è potuto realizzare ampiamente, grazie alla loro collaborazione. Inizialmente mi hanno parlato liberamente di come gestiscono il rapporto con le persone e nei loro racconti ho rilevato che tutti hanno dato grande valore ai temi appena trattati a cui ho deciso di dare un rilievo particolare in sede di analisi, considerandoli momenti focali dell’incontro con l’altro, ovvero della relazione d’aiuto. Ora, andando oltre al lavoro di analisi desidero aggiungere qualche considerazione ulteriore dei volontari, che è stata fatta al di fuori delle interviste “ufficiali”.Più di qualche volontaria mi ha esplicitato la difficoltà di parlare, in un certo senso a livello teorico, di come si svolga il rapporto, perché le modalità d’intervento sulle quali questo si basa sono soggette anche alla spontaneità – che non esclude la capacità riflessiva -, e anche a tutta una serie di “emozioni”, proprie della dimensione affettiva, che si sentono di fronte all’altro.
Molte volte non è nemmeno stato facile per i volontari esplicitare come si crea fiducia, come si dimostra disponibilità. Si è chiarito che non vi entrano tanto in gioco delle tecniche, ma capacità umane innate e, nel contempo, coltivate con l’esperienza, la passione, la pazienza, per questo difficili da spiegare a parole. Entrano in gioco le disposizioni personali, le proprie esperienze di vita, la sensibilità.
Allo stesso modo è difficile dire quali siano le parole che si usano, estrapolandole dalle proprie esperienze sul campo.
Posso affermare che personalmente ho potuto cogliere quella stessa disponibilità, che viene dedicata anche agli utenti, nel mio dialogo con i volontari. Più che chiedere a parole come si riesce a conquistare la fiducia delle persone, lo si può comprendere nel corso della dinamica dell’incontro, dell’esperienza diretta, del vivere il colloquio con chi ha imparato a relazionarsi autenticamente verso l’altro, avendo acquisito questa disposizione come modo di essere.
Attraverso un’immagine proposta da una volontaria, ci si rende conto di quello che nel Centro, come volontari, viene fatto, e, dall’altra parte, dell’affetto che si riceve: il Centro è stato paragonato a una grande famiglia, costituita dalle persone che lo compongono e da quelle che vi cercano aiuto.
Molto grande è l’investimento e, al pari, è molto quello che si riceve. La stessa volontaria che mi ha regalato quest’immagine ha affermato di aver visto, nella sua esperienza di aiuto, che ci sono persone carenti di molte cose “interne”, non solo esteriori. Arricchendo le persone dal “di dentro”, oltre che dando loro un aiuto materiale, si realizza un vero “aiuto alla vita”, disponendole a valorizzare-rispettare-arricchire la propria vita e quella del bambino che portano in sé.
Dalla mia esperienza di incontro con i volontari, posso senza dubbio evidenziare il contributo rilevante che danno all’aiuto. Hanno il grande merito di salvaguardare le persone in difficoltà, con una preoccupazione e un interesse che, oltre ad essere propositi e disposizioni, si fanno concreti.
La loro professionalità si dimostra sul campo negli atteggiamenti di disponibilità, sensibilità, interpretazioni partecipate delle difficoltà e nella ricerca degli stati d’animo non svelati dalle loro utenti, dandosi da fare in ogni modo per trovare soluzioni comunicative, di contatto.
Oltre all’impegno personale di ogni operatore è necessario sottolineare il valore del loro impegno di gruppo. Per cercare di garantire sempre agli utenti un’intensa partecipazione al loro personale vissuto, nel Centro si è creata una rete di sostegno reciproco fra i volontari per poter superare assieme le difficoltà che l’aiuto comporta e per condividere le esperienze, oltre che le informazioni e per aiutarsi reciprocamente. Anche l’intesa fra tutti i volontari del CAV è meritevole, segno di impegno, di reale “vocazione all’aiuto”, di disposizione verso gli altri che siano utenti o “colleghi”. Il sostegno reciproco e le riunioni settimanali fra volontari sono frutto della disponibilità e umanità dei volontari stessi oltre che di una precisa disposizione organizzativa di rete del CAV che coinvolge costantemente gli operatori del Centro (e anche fra Centri diversi). C’è un preciso fondamento axiologico su cui si fonda il Centro di Trieste e l’operato di tutti gli operatori che vi operano, tale da creare un clima sereno, pur dovendo venire a contatto con casi difficoltosi, pur dovendo fare i conti con le ripercussioni e il logorio umano cui il compito che si sono dati a volte conduce.
Ritengo che l’operatività al CAV possa davvero essere considerata come il reale luogo in cui la disponibilità da parte dell’educatore nei confronti dell’educando diventa proposta di relazione d’aiuto che si realizza sul campo per il bene dell’educando stesso, per tutelare la sua Vita.
5 CONCLUSIONE
La tesi che ho affrontato è caratterizzata da una linea dicotomica: gli argomenti principali si sviluppano su due versanti.
Ho trattato l’importanza, in educazione, dello sviluppo dell’io, da una parte, e, dall’altra, della socialità. L’uomo stesso è caratterizzato da entrambe queste dimensioni e una non si dà senza l’altra.
Ho trattato anche la capacità dell’uomo di essere attivo costruttore della propria vita, attraverso il processo di “significazione”, e nel contempo ho cercato di evidenziare il suo bisogno – che si dimostra nel concretizzarsi della relazione d’aiuto - della presenza dell’altro come guida e come “fornitore d’aiuto”.
Dell’educazione e dello spirito umano sono stati analizzati diversi versanti, per una visione complessiva, anche se non esaustiva. La complessità è, infatti, un altro ”filo rosso” che attraversa tutte le questioni trattate.
Essendo la pedagogia un campo tutt’altro che nuovo, perché le sue radici risalgono all’antichità, è stata rivolta attenzione anche al pensiero filosofico di alcuni autori del passato hanno sviluppato le teorie che sono modo di vedere il l’uomo.
A partire da queste chiavi di lettura, argomento cardine del testo, si dipana un’idea di come impostare la relazione educativa oggi, con uno sguardo alla saggezza filosofica. Accostandoci alla lettura della natura più profonda dell’uomo, della sua interiorità soggettiva e tuttavia protratta all’esterno, si può capire chi è l’educando che si ha di fronte e chi si è come educatori per poterlo aiutare. Entrando nell’interiorità si sono scoperte alcune delle potenzialità umane, da poter impiegare nell’intervento educativo, quindi nel contesto sociale, perché non restino aride, ma possano aprire gli orizzonti verso una reale condivisione arricchente.
Si capisce come la relazione d’aiuto pur intervenendo nella realtà della vita umana, si proietti oltre, verso quei terreni intimi e forse mai toccati e che si ha riguardo a scoprire. Per questo è viaggio alla scoperta più profonda dell’Uomo, dell’esistenza e del suo senso, più concretamente, del modo migliore per orientarsi nella vita, migliorandosi, imparando ad affrontare – nel sociale, con gli altri – le difficoltà.
Questa riflessione, che si fonda su una solida base filosofica, aiuta a comprendere che tutti gli uomini si trovano nella stessa condizione di dover capire se stessi, gli altri, il mondo. L’uguaglianza può essere motivazione per poterci fidare, nel rapporto educativo, dell’educatore il quale, con sensibilità umana, si dispone ad aiutare.
5.1 LA “SCOMPARSA” DELL’EDUCATORE
La caratteristica dell’analisi dell’intervento educativo è la circolarità: nel corso di questo testo molti sono gli spunti analizzati che, pur collocati in paragrafi definiti, si richiamano vicendevolmente. Ogni aspetto rimanda facilmente ad altri e tutti quanti assieme, senza un ordine preciso, concorrono a costituire il lavoro educativo che, di per sé, sarebbe infinito, mai risolto, perché sempre l’uomo é passibile di miglioramento, nel corso di tutta la sua vita.
Il compito dell’educatore è complesso.
La sua disposizione nei confronti dell’educando può essere, in generale, definita nei termini di “amore pedagogico”, così come lo delinea Rossi:
“ E’ l’atteggiamento assunto ed espresso da chi intende realmente aiutare l’altro nella pienezza del suo potenziale educativo “[253].
E’ desiderio di elevare l’educando. Per raggiungere questo obiettivo è necessario essere esigente, per il suo bene. Se l’amore “genuino” si caratterizza per il fatto di dare, senza nulla ricevere, l’amore in educazione esige, invece, coinvolgimento e impegno.
Proprio nell’amore pedagogico - che non si qualifica come semplice sentimento, ma disposizione che si attua nella responsabilizzazione e premura verso l’altro - si trova la soluzione alle contrapposizioni: nel suo nome si superano le difficoltà che il rapporto comporta. E’ garanzia di crescita in umanità e “prova” della profondità nel rapporto. Proprio l’amore dell’educatore spinge l’educando a riamarlo a sua volta, a riporre fiducia in lui, per poi, paradossalmente, liberarsi di quello stesso amore. La “liberazione” non è assoluta, ma se ne richiede una sufficiente perché l’educando si apra verso altre possibilità di amore. Il legame affettivo con l’educatore può essere la base sicura dalla quale, proprio perché sicura e protettiva, potersi dipartire.
L’amore nella relazione educativa, secondo Rossi, non deve essere presente per ridurre tale rapporto a “costruzione affettiva”, fino a scadere nel sentimentalismo, ma “è affermare l’originalità (dell’altro), è scoprirne ed esaltarne la singolarità, è rispettarne la distintività”. Diventa apertura alla libertà dell’altro e alla sua possibilità di maturare in umanità; è motivo di distacco, che non vuol dire abbandono, ma è il luogo in cui si rende visibile il lavoro condotto assieme, da parte di educatore ed educando, nel corso della relazione d’aiuto.
Crepet, a proposito del ruolo dei genitori, legge la loro difficoltà a fidarsi del figlio come segno del desiderio di considerare il proprio ruolo ancora indispensabile, di sentirne la sopravvivenza. Di fronte alla paura della propria esclusione, di un inevitabile tramonto, si risponde con questa forma di egoismo che, per garantire e perpetuare l’affermazione del sé, rischia di allontanane quella dell’altro, figlio o educando. Non è questo il compito dell’educatore nella relazione. Nell’aiuto si verifica una disposizione totale all’altro, si agisce per il suo bene, si fa in modo di renderlo autonomo, di condurlo verso il percorso di maturazione. Lungi dall’educazione è, all’opposto, il tentativo di legare l’altro a sé per sentirsi realizzati, per sentire – erroneamente – che il lavoro che si sta compiendo genera un rapporto solido, amichevole.
La relazione d’aiuto per diventare “appiglio nell’esistenza” non dev’essere “esclusiva”, ma “momento” in cui l’educando impara a costruire altri rapporti, ugualmente arricchenti, che lo coinvolgeranno, fino a fargli affrontare senza paura la vita stessa. Chiudendolo al rapporto con l’educatore, gli si impedisce di evolvere. La relazione d’aiuto ha una grande valenza formativa solo nella misura in cui apre l’educando a nuovi incontri, non lo “imprigiona”, ma gli insegna ad andare verso altre persone, facendo in modo possa contare su quello che ha imparato nel percorso con l’educatore e dall’educatore stesso come persona.
L’educatore non tronca i rapporti, ma si mette da parte per far evolvere il soggetto.
Knowles[254] afferma che le persone si possono autorealizzare, oltre che “conformasi” a programmi prestabiliti per loro. La differenza è rappresentata dal fatto che nel primo caso sono in grado di staccarsi dall’educatore, nel secondo, invece, non maturano la propria personale creatività. Dal momento in cui tutti gli esseri umani sono creativi – è questa la chiave di lettura che fa da sfondo all’intero approccio educativo –, devono essere abituati e aiutati ad esercitare questa dote.
L’educatore è colui che ”fa staccare” l’educando dalla relazione d’aiuto, senza che questi provi paura, perché viene preparato ad affrontare il passo, diventando conscio delle proprie potenzialità, di cui fa tesoro e che può utilizzare nell’incontro con gli altri.
Il rapporto educativo può essere paragonato all’allenamento, seguito dalla prova generale, per vivere: è palestra in cui l’educando impara a conoscersi e a “provarsi” nel rapporto umano con l’educatore - una delle tante figure significative che attraverseranno la sua esistenza.
E’ possibile trovare delle modalità per aiutare il soggetto a non soffrire l’ansia da distacco, la paura di riperdersi nell’esistere. Due sono i lavori da operare.
In primo luogo l’educatore deve essere chiaro fin dall’inizio sulle finalità dell’intervento educativo, spiegando che non è perenne, che avrà un termine e che, per arrivare alla sua conclusione, bisogna dimostrare di aver compiuto dei passi. Questi passi avranno la funzione, da una parte, di rafforzare il soggetto, dall’altra di dimostrargli che sempre, pur nell’autonomia conquistata, ci sarà qualcuno, con cui ha creato un rapporto, disposto a dargli il proprio sostegno. L’educatore non abbandona l’educando, può diventare un “altro significativo” con cui i rapporti non sono troncati al momento della conclusione del mandato, perché c’è affetto. Arriverà un momento, però, in cui l’educando dimostrerà la capacità di camminare da sé, di saper scegliere da solo, di saper mantenere dei rapporti duraturi, di non perdersi nell’esistenza. Il legame può essere conferma che si è fatto un buon lavoro educativo, a patto che non sia più “aiuto”, a patto che il soggetto sia diventato autonomo. L’educando non deve essere costretto al rapporto né al principio, né alla fine della relazione educativa, deve essere sempre libero:
“ L’educazione, allora, è sempre un servizio alla libertà, un aiuto a diventare liberi mediante relazioni che creano in entrambi i termini in gioco valori di umanità: è un rapporto fra persone che si costituisca in nome del diritto di ognuno alla propria originalità e al proprio itinerario di vita. Senza l’educazione l’individuo non diventa persona; ma il vero compito dell’educazione è aiutarlo a essere se stesso “[255]
Il secondo lavoro da attuare per fare in modo il soggetto si apra ad altre relazioni è la costruzione di una rete. L’educatore, si è affermato più volte, lavora nel contesto sia per la lettura dell’atto di significazione dell’educando, con l’obiettivo di conoscere il suo substrato culturale-valoriale, sia per reinserirlo. Il reinserimento è funzionale a dargli altri legami, a farlo sentire parte di un gruppo, di una comunità, a dimostrargli che il rapporto con gli altri può essere arricchente e che in esso può scoprire i propri lati positivi, di cui ignorava l’esistenza, e quelli degli altri.
De Natale[256] riassume in questo modo le caratteristiche principali e costanti di tutte le reti: sono costituite da legami strutturalmente rilevabili; il loro funzionamento si determina attraverso gli scambi; la proprietà fondamentale è il sostegno; si verifica reciprocità negli scambi. Scambi, sostegno, reciprocità sono indici del fatto che nella rete si costruiscono rapporti duraturi e arricchenti. L’educatore cura l’inserimento del soggetto e l’accompagna nei primi passi fino al suo inserimento, fino a quando resta coinvolto, si sente protetto, trova ancoraggio. La rete è garanzia che il soggetto non è solo e che, soprattutto, non è abbandonato.
E’ importante per De Natale riflettere sulla nuova immagine della società, in cui non c’è più un “centro” della rete, ma ogni nodo è oggetto di attenzione: ogni singola persona, chiunque essa sia, vive all’interno di reti-contesti che sono essi stessi “centri”. Basti pensare ai giovani portatori di innovazione, intesa anche nei termini negativi di “devianza”: devono essere ascoltati nei loro bisogni, non si deve tentare di dirigerli forzatamente verso un modello diverso da quello che sentono più proprio, ma accompagnarli, conoscerli, aiutarli a sentirsi parte della società.
Diversi passi vengono compiuti per aiutare l’educando a realizzare il fine della relazione d’aiuto, vale a dire valorizzare la sua personalità, fargli acquisire sicurezza, autonomia. L’educatore, “strumento di maturazione” dell’educando, si mette a sua disposizione fino alla fine del rapporto, finché sarà certo di poterlo vedere camminare da solo: si ha soddisfazione anche nel momento di conclusione del rapporto.
Nella relazione d’aiuto ci si inserisce nell’itinerario della persona, “spezzato” dall’evento critico, non cercando di ristabilire le condizioni precedenti, ma aiutando l’utente ad andare avanti: si opera “per l’autonomia materiale, relazionale, cognitiva dell’individuo, cioè per stimolare nel soggetto l’aumento della possibilità di incidere maggiormente rispetto all’elaborazione e alla realizzazione del proprio progetto”[257].
Tramma afferma che l’educatore lavora per la propria autoestinzione.
5.2 CONTINUARE A IMPARARE
Facendo ancora riferimento alle riflessioni di Demetrio e al completamento di queste da parte di Desinan, si possono recuperare i quattro modelli, costitutivi dell’età adulta, sui quali è possibile fondare una nuova scienza. I modelli sono “condizionamento”, “cambiamento”, “comunicazione” e “riflessione”; la scienza è la “metabletica”.
La metabletica studia il passaggio da uno stadio all’altro. Concependo la vita dell’Uomo come cambiamento ed evoluzione continua, si è riflettuto sul fatto che sembra il percorso umano possa essere caratterizzato da una successione di stadi. Oggi questa idea è stata superata. Mentre nel passato c’era il tentativo di isolare i periodi della vita - intento che ha condotto a paradossi come, per esempio, l’associazione del sapere all’adulto, del non sapere al bambino -, l’educazione degli adulti è giunta a esaminare la limitazione insita nel concepire l’uomo come colui che vive l’esistenza passando da una tappa all’altra. Oggi l’idea dei periodi è insufficiente, basti solo pensare al fatto che i periodi “critici” sono più numerosi. Un esempio per tutti potrebbe essere quello relativo al nucleo familiare: una volta si aveva in mente l’idea della stabilità della famiglia, oggi, invece, è prevista anche la strada del divorzio. Inoltre, con la scolarizzazione femminile e la necessità di riqualificazione professionale i “periodi” si sono spostati, non possono più essere considerati “prefissati”, ma sottostanno all’andamento di svariate variabili, anche difficili da programmare e prevedere. Questi come tanti eventi imprevedibili determinano “crisi”, che devono essere affrontate per portare alla scalata verso un successivo passo o “periodo”. La crisi può essere più o meno lunga, facilmente risolta, oppure no. Tutte le problematiche che compongono la vita dell’uomo postmoderno concorrono a costruire una nuova visione della vita e dell’uomo stesso: invece di parlare di “età adulta”, bisognerebbe parlare di “età adulte”.
Far fronte al continuo cambiamento, parallelamente alle svariate difficoltà, conduce alla necessità di leggere l’uomo attraverso uno studio di casi non rigido: il ricordo, la narrazione prendono piede come metodi per continuare a imparare, per valorizzare la necessità di orientarsi in un percorso vitale non scontato, non predeterminato. L’educatore è anche portato a pensare al perché dei cambiamenti, in quali circostanze avvengano, quali siano i fattori che li determinano, come valorizzarli, o come far superare la paura del cambiamento. Attraverso l’autobiografia tenere un contatto stretto col passato vuol dire essere presenti a se stessi, ma conoscersi non vuol dire solo guardare a un sé che agisce nelle regolarità rassicuranti, ma anche scoprirsi attraverso la necessità di novità: compito dell’ operatore educativo è sostenere il soggetto alla ricerca di nuove conferme, impegno che si traduce nella “ricerca di sé”. La vita stessa viene presentata all’educando come ricerca di sé.
Nel percorso che ha attraversato tutto il testo, partendo dall’io, fino ad arrivare all’altro, torniamo, in conclusione, alla soggettività dell’uomo.
Una delle competenze dell’educatore, nella relazione d’aiuto, è cercare di capire il soggetto nella sua realtà. Da questo progetto gravoso e complesso discendono le capacità di ascolto, di decentramento per acquisire il punto di vista dell’altro, di dialogo. La disponibilità dell’educatore è sempre “delicata”, consiste nell’aiutare finché l’aiuto è necessario, altrimenti prevale un atteggiamento “possessivo”, che si traduce nella forzatura del legame. L’educatore ha la capacità di tenersi indietro.
Continuare a imparare, in educazione, si traduce nella necessità di accostarsi a sé, alla propria complessità, alle proprie necessità, superando l’idea di stabilità, per mettersi continuamente in gioco e ricercare le strade che più realizzano la propria umanità, non avendo paura del cambiamento. Questo vale sia per l’educatore che per l’educando.
Per Desinan, imparare in educazione ha un significato duplice. In primo luogo, risolvere i problemi dell’esistenza, sviluppando un atteggiamento adattivo. In secondo luogo, “sentirsi vivi”, imparando a fare parte del nostro “essere-nel-mondo” e superando anche la stanchezza del consueto.
Nella mappa ermeneutica, Demetrio[258] cerca di individuare come il soggetto adulto si modifica e cresce. Mettendola accanto alla mappa storica, si può individuare come l’adulto si sia incanalato nella vita, come abbia insegnato a se stesso. Una delle spinte all’apprendimento, all’emancipazione, è la necessità trasformativa, che deriva dalla stanchezza del consueto. Tuttavia, c’è un’idea di continuità nel modo di essere dell’uomo, perché egli cambia, ma anche “resta”. C’è un tentativo, nel compito dell’educatore, di conciliare questi due volti.
Le tipologie della mappa storico-ermeneutica sono quella adattiva, trasformativa e riproduttiva.
In virtù della capacità adattiva, l’uomo impara a fare della motivazione la propria forza per generare apprendimento. Mentre le motivazioni estrinseche derivano dall’ambiente e sono deboli perché si esauriscono rapidamente e non sostengono lo sforzo, le motivazioni intrinseche nascono da una discrasia che si verifica nel momento in cui ci si accorge di non essere competenti e per reagire, automaticamente, attuiamo un meccanismo di “ricomposizione dell’equilibrio”, consistente nella ricerca del cambiamento per risolvere i problemi.
In virtù della capacità trasformativa l’uomo esprime la propria voglia di cambiare, che è necessità di vivere: noi viviamo per progettare un futuro. Nell’ambito di un progetto di aiuto, l’educatore può puntare sul cambiamento come processo che può portare alla risoluzione dei problemi.
In virtù della capacità riproduttiva, l’uomo, accanto al cambiamento, dimostra la propria necessità di confermarsi come identità, autonomia, competenze, originalità, per il grande desiderio di dimostrare di esserci ancora, come ci si è sempre conosciuti.
Si ripercuotono sul nostro modo di essere le modalità con cui la società richiede adattamento, trasformazione e riproduzione: alla base dell’apprendimento c’è anche il fatto di essere inseriti in una società, aspetto della vita a noi richiesto, in quanto esseri sociali, che influenza il nostro modo di essere.
Motivazione, desiderio di cambiare e rimanere se stesso caratterizzano la vita umana e l’educazione, e devono essere opportunamente “dosati” dall’educatore. Riconoscersi nonostante i cambiamenti. Pur con lo sguardo al futuro, l’intervento dell’educatore non perde di concretezza, ma resta sempre ancorato al reale: il futuro non è utopistico, ma è costruito sulle possibilità d’aiuto e sulle possibilità che anche l’educando stesso ha di aiutarsi.
Il futuro dell’educazione è l’uscita dal solipsismo, è la ricerca continua della strada giusta, è tentativo di innalzare la dignità dell’uomo, è consapevolezza del vivere e del vissuto. L’educazione insegna a “esserci” nella vita: Spranger afferma che scopo dell’educazione permanente è “svegliare” gli uomini, che vivono una condizione di torpore, passività, scarsa partecipazione, adattamento nella società. Secondo lui è importante imparare a valorizzare l’umanità che è in ciascuno di noi. In una della prime conferenze sull’educazione permanente, a Elsinor, nel 1949, si dichiara che l’educazione permanente è educazione alla responsabilità, alla consapevolezza, all’autonomia.
Alberoni, con tono malinconico e poca fiducia di ripresa, denuncia la perdita del senso del futuro:
“ Il sociologo Alessandro Cavalli ha dimostrato che l’ultima generazione europea ha perso il senso del futuro e del progetto. Perciò ha perso anche il senso del passato. Vive nel presente. Per duemilacinquecento anni l’occidente ha costruito la sua civiltà sullo slancio verso il domani, sulla speranza. Ha sentito la storia come un vettore proteso verso l’alto, verso una meta infinita. Scrutava il passato per plasmare il futuro. Lottava per realizzare una vita infinitamente più giusta, più nobile, più pura. Forse questa spinta si è interrotta. E per la nostra civiltà giunta al suo apogeo, è incominciato il declino. L’occidente resta potente domina il mondo con la sua tecnica e la sua economia. Ma ha perso la potenza spirituale delle origini, il fuoco che accendeva gli animi e dava loro una meta, e ogni individuo considerava la sua vita un difficile viaggio alla ricerca dell’assoluto “[259].
Ritengo possa assumere il ruolo di quella spinta spirituale di cui Alberoni denuncia la scomparsa la relazione d’aiuto, occasione per mettere l’Uomo a contatto con il proprio destino e per fargli recuperare il senso del vivere.
Un modo per continuare a imparare - quindi anche per disporsi a ricevere aiuto dall’altro - è credere nelle possibilità umane di continua evoluzione, nonostante le difficoltà reali di cui è portatrice la postmodernità: l’educazione può proporsi come “spinta”, “stimolo esistenziale”.
Come afferma Tramma,
“ L’azione formativa (…) può collocarsi anche ricorsivamente nel tempo per supportare l’individuo nella costruzione e nella realizzazione progressiva del proprio progetto, come una sorta di metodologia di convivenza con l’incertezza ” [260].
Anche Seneca sosteneva che nel corso di tutta la vita si impara a vivere. La relazione d’aiuto apre gli orizzonti per una rinnovata fiducia nei confronti dell’uomo e una scoperta del senso della sua esistenza.
Appendice
Interviste
Ø 1)
Ci sono due approcci che caratterizzano l’intervento: quello diretto e quello per telefono. Nel secondo caso bisogna dichiararsi pronti a qualsiasi richiesta, e prima di cominciare bisogna fare un respiro profondo come per staccare e cercare la propria disponibilità. E’ importante presentarsi, innanzi tutto, perché se io mi presento sprono anche l’altra persona a farlo: infatti non sempre le persone sono disponibili a lasciare i loro dati. E’ importante dare del tu, per cercare fin da subito di dimostrare la disponibilità, a creare un legame di confidenza. Subito dopo la prima cosa che dico è “Cosa posso fare per te?”, e poi si ascolta. Certamente per dare aiuto è anche importante conoscere il caso, quindi si fanno delle domandine. Non si deve dare l’impressione di invadere il suo campo, ma le domande sono finalizzate all’aiuto. E’ importante e difficile cercare di mantenere il dialogo per dare il primo aiuto, almeno i dati principali perché altrimenti poi non si può rintracciare successivamente la persona. Se riattacca subito dopo aver spiegato il caso, senza averci lasciato i dati principali è impossibile rintracciarla. Se la persona non parla tanto si può dirle “E’ meglio vederci al bar, per bere un caffè assieme”. Si cerca di trovare anche altri posti, oltre al Centro, per farle stare a loro agio, e per dimostrare che le si vuole aiutare.
Dall’altra parte il secondo approccio, quello diretto, consiste in un incontro. Se avviene al Centro abbiamo salette come questa in cui trovarsi uno a uno, dando l’idea che quello che dirà sarà privato, creando le premesse per un rapporto intimo. Si cerca di farla parlare, per capire meglio il problema. Per esempio se dice ”Non ho lavoro”, bisogna far capire che l’aborto non è la soluzione al problema. E’ importante capire il vero problema. Una volta individuato, possiamo anche proporle visite con lo psicologo o il ginecologo, perché la nostra idea è il lavoro di rete per garantire il sostegno alla persona. Qualche volta anche noi volontarie possiamo confrontarci con l’equipe se il problema è particolarmente grave.
Il problema principale è l’aiuto. Quando la persona parla, è importante anche cercare di farla ragionare, di farle capire. Magari la sua reazione di fronte alla notizia di essere incinta è solo paura, tutte le donne la provano. Bisogna starle vicino, dimostrare solidarietà. Anche far capire l’importanza del coinvolgimento del partner può aiutare a risolvere la paura iniziale, in qualche caso infatti le ragazze vengono assieme al partner.
Si conquista la loro fiducia dicendole tutti gli aiuti che le si possono dare. In questo modo, acquisisce sicurezza, si fida subito, perché capisce che le stiamo fornendo aiuto.
Più che la preoccupazione del distacco, si crea invece un rapporto. La preoccupazione del distacco è secondaria, perché si crea una vera e propria amicizia che dura nel tempo. Non si crea distanza. Per esempio ho conosciuto una signora quando aspettava un bambino, che adesso ha otto anni. E lei lo porta qui da me giovedì, perché io gli dia ripetizioni per aiutarlo a scuola. Si crea un’amicizia.
La chiave è sempre aiutarle fino alla realizzazione di tutti i loro bisogni.
Non solo le si deve ascoltare, ma la voce deve essere dolce. C’è qualcuno che è fortunato perché naturalmente ce l’ha, io adesso non ce l’ho tanto, ma è importante anche l’atteggiamento. Ecco, per esempio il tavolo così va bene, deve essere vuoto perché anche questo è un modo per farle capire che lei per me ha l’esclusiva, che non ho altri pensieri, altre pratiche da sbrigare, ma che in quel momento è importante solo lei. Si fa capire la propria disponibilità anche lasciandole il numero di telefono. A me è capitato di lasciare il telefono di casa, per dimostrare che ci si può vedere anche fuori dal Centro.
Per esempio ci sono anche dei gesti che si possono compiere per farle capire che non è più sola, che le siamo vicino: dopo il colloquio io se possibile le abbraccio. Penso che il problema più grande in questi casi sia gestire la solitudine.
Ø 2)
In premessa tengo a precisare che ci sono due modalità diverse con le quali noi – io in particolare perché adesso io parlo per me ognuno ha il proprio modo di avvicinarsi – ci avviciniamo a queste persone: quando l’utente fa la prima richiesta per telefono e, invece, quando viene direttamente nel nostro Centro.
Al telefono in un certo senso è più facile perché l’anonimato da una parte e dall’altra può sgomberare da difficoltà di inizio, ma richiede un’altra abilità nel riuscire ad agganciare la persona che chiama. Qualche volta uno chiama e dice ”Quando siete aperti?”, non è che dice “Ho questo problema posso venire?”. Allora se uno chiede solo l’orario di apertura bisogna intuire che questa persona ha bisogno di qualcosa. E allora bisogna trovare la disponibilità nostra e le parole giuste per far capire a questa persona che siamo aperti, siamo disposti anche a riceverla per qualsiasi problema lei possa sottoporci. E questo è il discorso del telefono. Ritengo positivo se la persona poi viene e una forma di fallimento se non si è riusciti ad agganciare la persona. Bisogna dimostrarsi disponibili, ma soprattutto accoglienti e contemporaneamente riservati, non troppo curiosi. Sono tre cose che, messe assieme, determinano da parte nostra il fatto di dire delle cose, ma non chiedere più di tanto, perché chiedendo un momentino di più la persona si sente forse invasa e non vuole parlare. Anche in questo caso è un momento molto difficile da sbloccare. Si interviene facendo tesoro di un po’ d’esperienza - perché naturalmente alla prima telefonata non si può essere sempre perfetti -, un po’ di pazienza e un po’ di tempo, e, diciamo, anche un po’ di semplicità della persona - cioè non pensare di dover risolvere i problemi del mondo con una telefonata. E’ proprio la serenità e la disponibilità della persona che affronta la chiamata. E questo è un discorso.
Quando vengono le persone, anche qui - e in questo forse ritengo di essere fatta io in un determinato modo - c’è sempre subito un modo di essersi reciprocamente…non voglio dire “simpatici”, ma di avere di avere questa forma di accoglienza immediata e questa all’inizio è una cosa spontanea, proprio immediata, e qualche volta bisogna superare anche la reazione di fronte alla persona che può non andare proprio a genio. Bisogna stare attenti alle parole e anche all’atteggiamento immediato, all’impatto immediato. E’ difficile gestire questo impatto, quando la persona che entra sente “qualcosa di negativo”, ma proprio verso se stessa.
La relazione interpersonale iniziale è molto importante, potrei dire che per la maggior parte dei casi è sempre positiva, non crea problema, non ci sono difficoltà, quindi è facile poi anche andare avanti. Tante vengono qua e sono disposte a parlare perché ne hanno bisogno, ma tante hanno paura della loro privacy, della loro riservatezza e paura di essere giudicate per il problema che sottopongono. Siccome il problema che loro vengono ad affrontare qui normalmente ha solo due soluzioni - a parte che personalmente ritengo che tutti i problemi hanno solo due vie di uscita o positiva o negativa - e anche loro lo sanno. E allora, anche per loro mettersi di fronte a una terza persona che qualche volta può giudicare è difficile, per questo noi cerchiamo sempre di dichiarare apertamente il non giudizio.
Per me ritengo che il fatto di affrontare queste problematiche - che sono problematiche, allarghiamo un po’ il campo, di salute, di problemi mentali, di problemi di relazioni di coppia, eccetera - con dei familiari - e non solo dei familiari di famiglia stretta ma anche di parentela - coinvolge molto di più. Almeno questo è il mio pensiero. Mentre avendo a che fare con delle persone che, tutto sommato, sono estranee che non hanno con noi una relazione, e noi con loro non abbiamo una relazione – e per relazione non intendo solo la relazione sentimentale, ma proprio la relazione di dare-avere, di essere famiglia o no, di dover avere delle responsabilità nei loro confronti -, consente alla persona che deve gestire questo problema di essere, non voglio dire staccata, ma non coinvolta nel senso della responsabilità primaria. Se io ho a che fare con lei adesso posso discutere di tutti i problemi, ma so che non ho la responsabilità di quelle che saranno le sue scelte. Ecco, a me personalmente potrà dispiacere se lei fa una scelta quando io non sono d’accordo, potrò sentirmi amareggiata per non essere riuscita a farle fare una scelta che ritenevo più opportuna in quel momento, però non ho quel coinvolgimento proprio del sentimento personalmente di affetto e di amore che si ha con i familiari e con le persone vicine. Noi siamo tutti volontari, non siamo professionalmente preparati né in campo medico, né in campo ostetrico, né in campo psicologico, non abbiamo una patente, diciamo. Ci avviciniamo a queste persone solo dal lato umano, di relazione umana con l’altro. E allora a me non crea difficoltà, mi dispiace se la persona fa una scelta che ritengo che non vada bene, però la libertà individuale, la responsabilità personale l’assume lei, anche nelle conseguenze.
Noi abbiamo uno schedario, anche perché queste persone tornano nel tempo noi siamo dei volontari che stanno per un mese, un anno, dieci anni, però poi vengono altri, allora queste situazioni devono avere un minimo di riferimento per noi. Adesso con la legge sulla privacy dobbiamo far firmare una liberatoria, con la liberatoria la persona che viene qua sa che noi abbiamo i suoi dati ma servono a noi a lei e basta. Ci consente, se c’è la necessità di avere una relazione con l’assistente sociale, con il servizio comunale preposto alla tutela della maternità, di poter parlare anche con loro del caso, o andare anche assieme alle ragazze. Uno degli ultimi colloqui, quando solo ho preso il cartoncino sulla tavola, solo il fatto di aver tirato fuori sul tavolo il foglio, io ho visto che alla persona ha dato fastidio. Quindi la persona si è sentita evidentemente invasa, quindi io ho lasciato perdere, ho scritto nome cognome, punto e basta, e a questa persona non ho neanche fatto compilare il foglio per la privacy, ma ho sentito che non era il caso, che lei sarebbe stata disturbata. A parte che ci sarebbero state altre occasioni, quindi si rimanda anche a dopo, non è detto che la prima volta si debba essere fiscali in tutto: bisogna adeguarsi a quella che è la disponibilità della persona che si ha di fronte e al suo atteggiamento. Un altro episodio che mi è capitato per la prima volta in quell’altra stanzetta. Lì c’è il tavolo, ci sono le poltroncine, si entra sia da una porta sia dall’altra che dà sull’ufficio. Quella volta avevo altra gente con cui stavo parlando e ho detto alla ragazza, che doveva parlare anche lei con me, di avere un attimo di pazienza, di accomodarsi dove le sarebbe andato meglio, e che sarei arrivata subito. Tutti quanti o si siedono sul divano, e normalmente più lontano, qualche volta, se c’è qualche seggiola già aperta, si siedono anche sulla seggiola, invece, questa ragazza di 27 anni, calma, tranquilla ma sicura, non dubbiosa, si è seduta sulla seggiola che era lì dietro al tavolo. Praticamente ha preso posizione, si è messa lì coi gomiti sul tavolo: ha preso la sua posizione. Per me è stata una cosa stranissima. C’era una seggiola lì vicino all’angolo e io mi sono seduta vicino, non di rimpetto. Però questo mi ha dato qualcosa da pensare. Mi sono detta che c’era un qualcosa di diverso dal solito, no? Nel suo approccio: la sua grossa preoccupazione era proprio la riservatezza. Io credo abbia preso come una posizione, così, di comando, per cercare una sicurezza sua. Si intuisce anche in questo modo com’è la persona, cosa vuole da me. E a questa persona io mi sono rivolta proprio nella dimensione della responsabilità, siccome era poi una ragazza di 27 anni, non una quindicenne. Aveva studiato, aveva il diploma di scuola media superiore, era poi andata all’università, senza combinare niente, lavoricchiava perché la sua situazione economica familiare è buona, è figlia unica, non aveva mai pensato che ci potessero essere dei problemi economici. Il suo ragazzo, con cui poi aveva una relazione già da più tempo, ha 30 anni, quindi è un uomo, anche lui è economicamente più che autosufficiente, un lavoro che consente un buon reddito, tanto che ha un appartamento per conto suo, anche lui è figlio unico. Tutti stanno bene e la cosa grave è che lei con questo ragazzo aveva già avuto un aborto e questo sarebbe stato il secondo. Problemi economici non c’erano, c’erano problemi relativi a loro due, che non si ritengono ancora pronti per avere un bambino. Al che io ho detto “Va bè, io non giudico questo, però si prendono le precauzioni”, nel duemila passato, soprattutto dopo un’esperienza di questo genere La cosa strana è che, tutto sommato, anche la prima esperienza non è che abbia lascito quel, così detto, trauma post aborto. E questa è un’altra riflessione che noi dobbiamo trarre da questo discorso, perché, evidentemente, per i giovani d’oggi per i quali la legge - dovrebbe essere di “sostegno alla maternità” e invece è chiamata la legge sull’aborto - è una cosa normale, non è una conquista, un cambiamento, non è una differenza rispetto al passato. Quindi, probabilmente, per loro, come ci sono tutte le altre leggi, c’è anche questa: se c’è una legge vuol dire che le cose si possono fare, non è un reato. Mentre nel passato veniva vissuto come un reato e doveva essere eseguito in clandestinità, con le conseguenze di paura, terrore, il fatto di essere scoperto, di essere giudicato dopo, ed erano disposti a pagare anche chissà che cifre in Italia e all’estero, però era sempre vissuto come colpa, quindi probabilmente la cosa lasciava un trauma. Invece, soprattutto adesso quando andiamo a fare formazione a scuola - noi come Centro veniamo chiamati per parlare della nostra attività e di quello che facciamo -, i ragazzi non capiscono perché si debba discutere di questo problema: c’è la legge, chi lo vuole lo fa che lo vuole non lo fa. Non crea nessun problema. E allora con questa ragazza abbiamo parlato un’ora, che di solito io non mi dilungo mai più di tanto, perché le cose vanno dette, ma è però inutile starle a ripetere. Se uno parla di più la persona può avere un senso di stanchezza, di fastidio, si sente troppo – anche e non è giudicata – ma lei si sente un po’ colpevole. Poche parole ma chiare. Io l’ho lasciata parlare abbastanza, però, secondo me, mancava di maturità, nel senso di responsabilità delle proprie azioni. Invece dal mio punto di vista ognuno di noi può fare quello che vuole però deve prendersi la responsabilità delle conseguenze che derivano dalle sue scelte, ecco questo è il punto di base. Puntare sulla persona.
A 27 anni non si può non pensare. E come anche a lei ho detto che situazione ha con questo ragazzo. Mettiamo che lei decida di abortire, e che dopo continui lo stesso con questo ragazzo, che avrebbe potuto dire qualcosa perché questo figlio è anche suo. E allora nessuno dei due si prende nessuno responsabilità? Ecco, allora, non voglio né giudicare: siamo qui, anche in questo caso ho detto che, se avessero voluto, avrebbero potuto venire assieme, ne avremmo parlato ancora, vedendo i problemi.
Io cerco sempre di dare del lei almeno nel primo incontro, mi sembra una cosa molto giusta, non voglio invadere, anche se sono presone giovani, anche se faccio molta fatica perché io ho figli trentenni e oltre allora sono abituata con i giovani. Però qui come forma di relazione, mi sembra giusto, non per mantenere le distanze, ma per rispetto alla persona, ecco, per considerarla persona, persona adulta, responsabile, che deve sapere anche lei come agire. E anche perché probabilmente a me darebbe un po’ fastidio che mi dessero subito del tu, è la mia educazione, la mia abitudine del passato, io sono abituata così. Trovo giusto, soprattutto all’inizio, soprattutto le prime volte trovare anche questo modo per dare valore alla persona, perché col tu mi sembra quasi di sminuirle, di considerarle bambine, no?
Il dialogo generalmente si costituisce sulla reciprocità. Poi bisogna vedere. Ci sono delle persone che parlano a ruota libera e quindi all’inizio queste si devono lasciar parlare, perché hanno un tale bisogno proprio di uscire e di trovare qualcuno che le ascolta. Poi, ci sono quelle alle quali bisogna fare delle domande, che devono essere sollecitate per riportarsi sull’argomento giusto, ma anche per spronarle a non aver paura per la privacy, di essere invasa. Da ogni colloquio noi maturiamo la capacità di fare l’incontro.
Anche le nostre conferenziere che vengono a dirci spiegarci le modalità del colloquio, l’empatia. Queste sono tutte tecniche che a noi servono, anche a me servono quando le ascolto, anche per riflettere, però credo che ci debba essere nella persona la disponibilità ad ascoltare volentieri gli altri, ecco questo deve essere in partenza, e un po’ l’attitudine all’ascolto.
Conquistare la fiducia della persona, attraverso consigli. Il dare i consigli non è dire “E’ bene fare così, è male fare in quell’altro modo”, “E’ giusto fare così, è sbagliato fare in quell’altra maniera”. Secondo me non va molto bene neanche dire “Nella sua situazione che mi è capitata ho preso questa decisione”. Il coinvolgimento della propria esperienza personale nei casi specifici dal mio punto di vista non va bene. Per dire “Ho avuto anch’io questo problema e ho cercato di fare così”, ecco questo è un modo che non ho mai attuato. Ci vuole un po’ di distacco, personalmente non mi sono mai messa in mezzo, per non far capire alla persona che io ho agito in un modo e ho fatto bene. Primo perché penso che alla persona che mi sta di fronte relativamente può importare quello che è successo a me, le situazioni. E invece, secondo me, bisogna sempre cercare di far capire alla persona qual è il problema, quali sono le ipotesi di soluzione, e perché lei stessa ritiene che quello che ha deciso di fare è meglio dell’altra possibilità. Più che farla riflettere, farle capire che deve ragionarci su, sull’eventuale scelta, e che se c’è un’altra ipotesi bisogna valutarle entrambe e che se quelli che possono sembrare adesso dei problemi insormontabili, si possono anche superare. I problemi più grossi sono questi: non hanno una famiglia alle spalle; il rifiuto dalla parte del partner. L’intervento del partner è fondamentale: che lui accolga c’è già un 50% di positivo, no? Però, il non sentirsi accolte né da chi è dalla parte principale, cioè il padre, né dalla famiglia nella quale ancora vivono, dà un senso di solitudine. Nei confronti della famiglia si sentono più in colpa, nei confronti del partner meno, perché sentono di essere entrambi coinvolti. Ma nei confronti della famiglia d’origine dalla quale non si sono ancora staccate si sentono in colpa perché è come se avessero fatto una cosa brutta, cattiva. Con la legge 194, che dà la possibilità di andare ad abortire senza che sappia niente nessuno, c’è il rischio di un ragionamento di questo tipo: “Mi assumo io tutta la responsabilità, chiudo tutto, lo metto via in un bidone e ci penserò chissà quando”. Almeno ritengo che la legge sia grossa causa, una grossa motivazione, perché tante di loro vanno da sole, all’oscuro di tutti.
E’ importante con le donne che vengono esplicitare tutte le possibilità. Ma anche puntare la sua responsabilità in prima persona: io dico “In fin dei conti, noi stiamo discutendo, stiamo parlando, mettiamo assieme le ipotesi, punto. Ma voi - e preciso non lei e il suo ragazzo, lei e suo figlio - ci siete già”. Ecco, e questo un attimo fa riflettere, e dal quel momento io parlo di “voi”, non di “lei”. “Anche se il suo ragazzo non è pronto - dico - a voi potrebbe anche in questo momento non importarvene più di tanto, perché voi ci siete, voi avete una forza, voi siete una forza”. Il bambino è sempre una crescita, cerco sempre di fare pensare, perché loro lo pensano come un ingombro, come un fastidio, come una fatica, come una necessità di rinuncia alla propria vita. Dico, “Invece, guardiamo dall’altra parte: è un accrescimento, è un qualcosa di più, ti dà tanta responsabilità, ma tante cose in più dopo e ti troverai gratificata, e sarete in due dopo ad aver la forza di andare avanti”. Responsabilizzare la ragazza in prima persona e porle in questi termini la questione del partner: “Per il tuo ragazzo adesso potrebbe anche essere il modo di cominciare a riflettere e dire -Ecco, ma loro ce la fanno, perché io no?-”.
Se si riesce a coinvolgere il partner qualche volta si riesce, se il partner non vuole è difficilissimo convincere la persona ad andare avanti, soprattutto se è una coppia sposata. Può accadere venga anche il partner al colloquio. Direi che il caso della coppia che è venuta per questo problema credo di non averlo mai avuto, io ho sempre avuto la ragazza che è venuta per la prima volta. E’ capitato piuttosto che dopo sia venuto anche lui o che ci si sia incontrati assieme. Se loro sono d’accordo è facile, quando c’è il conflitto è un problema. E questa è anche una situazione che ho attualmente, però questa è più complicata perché il partner non è il marito, e c’è un marito e una figlia del marito. Questa è una di quelle casistiche molto complicata. Questa donna ha avuto molta difficoltà a realizzare il bambino che c’è, che non ha ancora partorito, ma lei è talmente presa dai problemi con la figlia, il marito e con questo nuovo compagno con cui non convive. E questa è una problematica infinita. Eh, cosa bisogna fare? Qui è molto, molto difficile, perché per me è facile sostenere lei e il bambino, ma le dico sinceramente mi sarebbe più facile sostenere l’avvicinamento familiare base, piuttosto che l’altro. E c’è questa grossa contraddizione, perché questo è invece un padre che vuole il bambino, giustamente, anche lui è padre, no? Ecco, come fanno, come si può fare a inserire queste tessere del mosaico così spaiate? Perché sostanzialmente è come se ci fosse un mosaico che ha le mattonelle di una misura e si deve inserire una mattonella di una misura diversa. La chiave è l’ascolto, perché io parlo più con lei che con lui. Loro hanno una psicologa, che però lavora in un’altra direzione, nella dimensione delle persone, non del bambino che deve venire, mentre noi siamo nella dimensione del bambino che deve venire. Però quando la situazione è così conflittuale a me personalmente mi crea un problema. Ecco io non affronto serenamente questa situazione, perché mi sento impossibilitata a risolverla. A parte che le situazioni non le devo mai risolvere io, questo è il principio, ma in questa dimensione qua mi riesce più difficile che nelle altre. Mi sento vicina alla signora, mi sento vicina al bambino che deve venire, però sento che lei ancora ha realizzato poco questo bambino. E questo a me dispiace sinceramente, perché lui nasce già con fastidi. Mi auguro che dopo le cose riescano a risolversi e che soprattutto questa donna sia capace di gestire la situazione, perché non è mica facile gestire una situazione del genere! Poi dovendo anche lavorare, avendo anche quest’altra bambina...Sono troppi nodi, e devono essere le persone a trovare la loro soluzione ed è anche su questo che io insisto con questa signora, le dico “Lei deve guardarsi dentro, cercar di capire cosa vuole, per sé, per sua figlia e per il bambino che deve nascere”.
Credo che quello che ho imparato in questi più di dieci anni che sono al Centro è - anche quando ci si trova in una situazione che non si approva - staccare la mia valutazione. Cioè i miei principi non li ho mai cambiati, io sono sempre rimasta coerente con i miei principi di base, che ho sempre manifestato per fare la mia famiglia e con la mia famiglia, mio marito e i miei figli, che ho cercato di trasmettere ai miei figli. A loro ho sempre detto “Noi siamo così, a noi va bene questo modo di vivere – certe cose che nella mia famiglia e nella famiglia di mio marito non andavano bene, però, le abbiamo sempre rispettate quando eravamo con loro. Adesso nella nostra famiglia noi portiamo avanti dei principi, voi seguite quello che a voi sembra vada bene, quando voi sceglierete la vostra famiglia non sarò mai io a dirvi -Non va bene-”. Ecco, in questo senso i miei principi sono sempre rimasti uguali, però ho imparato a staccare, a togliere le mie osservazioni. Siccome ho dovuto seguire delle situazioni che avevano dentro proprio tutto quello che era contrario a come io credevo le cose dovessero andare, ecco, allora ho imparato. Altrimenti si soffre troppo, allora, nel momento in cui si soffre non si è in grado di dare un sostegno alle persone, ecco questo è molto importante. Però, se si è convinti dei propri principi bisogna mantenerli, comunque, a meno che non si capisca di aver sbagliato. Ci possono essere delle situazioni in cui diciamo “O mamma mia che sbaglio che ho fatto!”, e si mette in discussione, si valuta, si capisce. Mi son resa conto che sono riuscita a mantenere la mia integrità come persona, sono sempre io con i miei principi, i miei comportamenti la mia assunzione di responsabilità, in più credo di essere riuscita a capire che anche queste situazioni, che a volte sono veramente difficili - non è solo la situazione dell’aborto per se stesso, l’aborto è il dramma grave, poi vicino ci si presentano tante situazioni problematiche, ci sono tanti problemi, non è solo il fatto del lavoro della casa, dei soldi -, non devono essere risolte da noi. Non ci sognamo neanche di risolverle, diamo aiuto nel momento del bisogno, iniziamo a rivolgerci a questo o a quello per avere i sussidi, cerchiamo di attivare le strutture pubbliche che possono sostenere questi casi, ma il resto non possiamo noi modificarlo. Quindi dobbiamo sostenere al momento anche quelle situazioni, no? E questo è quello che ho avuto io dal Centro e ritengo sia una cosa molto importante. Probabilmente se non avessi visto proprio sul campo cosa c’è nella società, anche a Trieste, non avrei immaginato che c’è un disagio sociale notevole, anche nella nostra dimensione piccola e non solo per l’extracomunitario, il somalo, chi viene dalla guerra. Quello è un discorso, ci sono altri problemi anche e penso si dovrebbe fare anche qualcosa di più, come società, non nella nostra Associazione perché non si possono offrire tutte le necessità, altrimenti si rischia di fare male troppe cose assieme.
Le voglio dire anche un’altra cosa, un’altra esperienza di famiglia regolare. Sostanzialmente non c’erano grossi problemi economici, lavorava solo lui perché lei seguiva la bambina, proprio una normale condizione familiare, avevano degli amici, uscivano a vedere il cinema. Cosa capita da un giorno all’altro alla famiglia che li sconvolge? Aspettano un bambino. Lei aveva un conflitto interno spaventoso. Per principio suo non si sognava minimamente di fare qualcosa contro, però non si sentiva accolta da nessuno, né dal marito, né dalla famiglia, né dagli amici. Complicava tutto, tutta la loro vita futura sarebbe stata complicata da questa tragedia. E allora io ho proprio capovolto la situazione, facendo vedere tutto il senso della positività. Allora partendo da lì abbiamo fatto un discorso, ma proprio era disperata, aveva pianto, abbiamo parlato una mezz’ora, tre quarti d’ora e dopo si è sentita rasserenata. Le ho mostrato tutto quello che poteva essere il positivo in questa nuova situazione, una situazione che proprio era adatta per un nuovo bambino, era perfetta. Allora dopo lei ne ha parlato con sua madre, che l’ha sostenuta, il marito anche, e dopo si sono trovati il muro degli amici. Lei è venuta da noi per diverso tempo lungo la gravidanza, era tutta contenta, ci partecipava di tutto, andava tutto bene, ad un certo punto non abbiamo saputo più niente, son passati quasi due anni, e ogni tanto mi chiedevo di questa persona, siccome aveva fatto visite mediche, analisi del sangue, e non sapevo cos’aveva che non era perfetto. Allora dicevo “Mamma mia, che non ci sia qualche complicazione”. Avevo paura che fosse avvenuto qualcosa di negativo. C’era questo pensiero che mi faceva star male, proprio non saper niente mi dispiaceva. Quando questa bambina che è nata aveva un anno e due-tre mesi, proprio all’inizio di questo anno, l’ho trovata che aspettava lì, fuori dalla porta con questo splendore di bambina. Ha detto che siccome il tempo passava, non riusciva a venire, si sentiva in colpa per questo, ogni volta trovava una scusa perché non sapeva come giustificare il fatto che non era più venuta.
Di solito aspetto che venga la persona, piuttosto che chiedere di ritornare, dopo aver risolto tutto. Dico la verità, per questa persona abbiamo cercato sull’elenco del telefono, il numero non corrispondeva più, non siamo più riusciti a trovarla. Pensavamo che se avesse voluto farsi viva sarebbe stato un bene, altrimenti pazienza. Comunque questa è andata a finire bene. Con quest’altra che le dicevo prima, io là ho fatto un’invasione di privacy, ho cercato sull’elenco del telefono e ho trovato il numero giusto. Ho chiamato in diversi momenti successivi, perché eravamo rimaste d’accordo che poteva venire, poteva venire da sola, col suo ragazzo, come voleva lei, le avevo dato il riferimento anche di Roiano se le fosse stato più comodo, e niente. Allora, passa una settimana, passano due, passano tre, un lunedì telefono, e mi ha risposto il padre e ho chiesto di questa ragazza e lui ha detto che non era in casa. Mi ha chiesto il nome, io l’ho detto, ho detto che sono un’amica e basta. Poi ho richiamato e riprova, riprova non rispondeva mai nessuno. Un lunedì l’ho trovata, era lei al telefono. Dico “Non mi riconosce chi sono?”. E lei ha capito, non mi ha chiesto come ho avuto il numero. Le ho chiesto come stava, dicendole che avrei sperato di vederla. Mi ha detto “Ho preso un’altra decisione”. Le ho detto “Mi dispiace, e il suo ragazzo? Pensa di continuare la situazione lo stesso?”. “Ma non so vedremo”.E io le ho detto che se avesse bisogno di parlare eccetera può venire in qualsiasi momento: non è che noi ci chiudiamo se la decisione è un’altra. C’è anche il caso opposto in cui non viene recepito il messaggio positivo.
Evidentemente anche da parte mia, se forse avessi operato in modo diverso, chi lo sa, ma a cose fatte…
C’è il positivo e il negativo, situazioni che vanno bene, e altre, qualcuna che non va. Qualche volta a me è capitato, ci sono stati due casi di aborto spontaneo, dopo aver accettato. Di queste una ha sofferto molto, una se n’è fatta una ragione.
Queste persone vengono qua anche per parlare del “dopo”, più che per tranquillizzarla, prima di tutto spiego questo principio: “Piangersi sopra non serve più”, dovrebbe servire come esperienza per evitare di rimettersi in un’altra situazione analoga. Da questo bisogna cercare di costruire qualcosa di positivo, e allora bisogna ricostruirsi, capire che è stata fatta una cosa che non andava bene, ristrutturarsi, ricostruirsi per evitare di sbagliare.
Ø 3)
Diciamo che, ovviamente, inizialmente è l’utente che parla, la persona che si rivolge a noi. Parla lei e dal primo impatto non si riesce a capire molto, ma si riesce a capire qualche cosa per arrivare ad introdursi, poi, con più incisività sull’argomento. Comunque diciamo che non solo nel primo impatto, anche negli impatti successivi il dialogo deve essere sempre molto pacato e non invadente - almeno questo è il mio punto di vista - per fare in modo che la persona non si spaventi. Poi, se si è troppo invadenti o dimostrando una visione del problema settoriale e di guardare così, col paraocchi, questa persona può pensare che noi lavoriamo per portarla verso una strada molto precisa. Certo, il nostro tentativo è quello di condurre su una strada precisa, e in questo momento mi riferisco al caso ci si trovi di fronte a una gravidanza non desiderata o comunque a una gravidanza che presenta dei problemi vari, di cui forse ne ha già parlato con le altre volontarie. Ecco, quindi si tratta di un rapporto molto “soft” inizialmente, e anche dimostrando che le decisioni sono sue, non certo nostre, anche perché lei sa personalmente se può affrontare certi problemi, non tanto come li deve affrontare, ma chi si trova davanti. Ormai sappiamo che ci sono anche casi di forzature estreme, minacce, è successo tante volte. Tutto questo viene fuori gradualmente col dialogo. Questo succede chiaramente quando abbiamo del tempo davanti, perché può essere anche che questa persona - come succede molte volte – venga da noi già con il certificato di interruzione di gravidanza, per cui questi sono casi molto più difficili. Il tempo è stretto e bisogna anche “catturare” questa persona nel vero senso della parola, bisogna anche ammettere che in queste circostanze abbiamo degli insuccessi, non si riesce ad aiutare, facendo portare a buon termine la gravidanza. Però molto spesso è successo che, invece, il caso è stato buono. C’è anche qualche volontaria che, quando sa che la situazione è incerta, corre al Burlo per vedere ancora di riuscire a evitare la perdita del bambino. Questo fa parte, meno male, dei casi estremi.
In generale, dopo il primo incontro, nei colloqui successivi, si comincia a parlare in modo più approfondito, cosa che può accadere anche nel primo stesso colloquio, perché ci sono anche colloqui che si protraggono anche per parecchio tempo, dai 5 – 10 minuti anche per tutto un turno, un nostro turno, che dura due ore, anche due ore e mezza, perché non ci diamo limiti di orario. Si parla, si capisce quali sono i problemi, se sono economici, se sono di carattere affettivo, se provengono dalla famiglia, se provengono dal partner. Qualche volta, nel caso provengano dal partner, chiediamo di parlare anche con lui, cosa che risulta difficile perché gli uomini sono riluttanti a presentarsi. Viene fatta una richiesta esplicita, chiediamo se è possibile avere un dialogo anche con lui, soprattutto nel caso che la ragazza dimostri che lei sarebbe d’accordo ma che il partner non lo è. Questo è un atteggiamento di disponibilità che cerchiamo di dimostrare.
Nei confronti della famiglia è un po’ più difficile. Se il problema è economico cerchiamo di prospettarle quali sono le nostre possibilità.
Ci sono anche situazioni abbastanza coinvolgenti. Qualche voltale le dirò, se devo essere onesta, bisogna avere il periodo giusto, bisogna avere disponibilità di spirito, non problemi personali, perché altrimenti è difficile darsi all’altro. Quindi bisogna essere molto sereni, anche per quel che riguarda il proprio personale vissuto. Però chiaramente se la situazione è pesante, si dimentica tutto, se si fa il volontario si deve dimenticare, si deve andare avanti, ci si deve concentrare. E’ difficile, perché finché c’è colloquio ci si dispone all’ascolto, ma quando si deve intervenire con collaborazioni interne allora diventa più impegnativo, anche se bisogna dire questi sono casi non all’ordine del giorno.
Quando queste persone raccontano la loro esperienza, c’è il rischio di rimanere coinvolti anche a livello emotivo. Se viene una ragazza qua, e va via senza aver dato nessuno sprazzo, nessuna chiara visione di speranza, viene l’ansia, perché se questa non viene più il caso lo può quasi considerare chiuso, perché non si può intervenire, violando la sua volontà e la sua privacy. Qualche volta se ci lasciano il numero di telefono, allora si tenta anche una telefonata, magari può capitare una rispostaccia, però c’è il tentativo. Qualche volta se non si è fatta sentire e si prova a contattarla, la situazione può avere anche un risvolto negativo. L’importante è che ci sia stato l’ impegno. C’è l’impegno perché noi viviamo il fatto di non sapere come finisce una determinata situazione sentendoci, non dico sconfitti, ma amareggiati – non si può parlare di sconfitta, però c’è stato l’impegno la preoccupazione e l’interessamento. Noi possiamo fare fino ad un certo punto. Ci sono diverse “correnti”, anche fra noi volontarie, io, per esempio, non sono per l’invadenza, la forzatura, per il giudizio, dire “Tu fai così, quindi…sbagli”. No, non mi sento di colpevolizzare, a parte colpevolizzare, di essere invadente, perché i casi della vita possono portare una persona anche a fare una cosa che prima non si sarebbe mai sentita di fare. Il non giudizio deve stare alla base del rapporto.
Riguardo alle parole che si usa bisogna dire che si è interessati a lei, a quello che racconta, bisogna dimostrarle di esserle vicini. Chiaramente le tecniche sono diverse, si realizza un approccio diverso anche, per esempio, a seconda dell’età della persona che viene. Di solito diamo loro un aiuto in un senso formativo, cerchiamo di far capire cosa avviene dentro di loro. Questo libretto che abbiamo è molto utile, glielo lasciamo perché così capiscono che hanno il bambino dentro di loro.
Il rapporto che si crea è di amicizia, se così si può dire. Sicuramente si riceve tanta gratificazione, le persone tornano, ci cercano, è un rapporto che va avanti nel tempo e dà molto. Infatti, quando si crea questo rapporto, si riesce a capire il problema che vogliono comunicare e che all’inizio, magari, nascondevano perché erano intimorite, perché si fidano e viene fuori tutto con il dialogo, nel corso del rapporto, man mano che si consolida.
Ø 4)
La persona si accoglie con spontaneità. Chiaramente bisogna essere portati per saper avviare questo tipo di relazione. La comunicazione è amichevole, si crea un rapporto tale che le parole sono come quelle che un’amica userebbe. Per esempio, è venuta una signora da me in lacrime, dicendo che aveva già un bambino, che non voleva averne un altro, perché voleva elevare il proprio tenore di vita e quindi quello della famiglia, ma non era convinta di non volere veramente questo bambino. Allora il mio approccio è stato proprio orientato nel senso di un colloquio amichevole.
Noi siamo volontarie, le avranno detto, sì, abbiamo una preparazione iniziale, però non siamo specialiste. Per questo facciamo degli incontri di preparazione, se così si può dire.
Una volta è venuta una psicologa, era molto brava, ci ha parlato per un’ora, noi eravamo tutte qua, in questa stanza, e non si sentiva volare una mosca. L’abbiamo ascoltata, ed eravamo tutte con la bocca aperta. Questa psicologa ci ha molto spaventate, perché parlava di empatia, di colloquio, e a me personalmente è venuta una grande paura iniziale. Ci dicevamo dopo averla ascoltata “Come faremo?”, “Non ce la faremo mai”. Ci ha detto cose che sapevamo, che ti fanno sempre pensare però.
Il mio primo lavoro era diverso, adesso io sono in pensione, era proprio tutto un altro ambito. Però mi pare che, dopo la paura iniziale, ho capito che il rapporto con queste ragazze che vengono da noi è più facile, mi ero spaventata inizialmente, ma basta dare disponibilità, e poi agire sulla base del buon senso, saper ascoltare per capire di che cosa hanno bisogno, verso dove indirizzare il nostro aiuto.
Una signora per esempio non voleva abortire. Le persone vengono qui perché sono indecise, hanno bisogno di conforto. Basta trovare le parole giuste, come si troverebbero per un’amica. Io fortunatamente ho avuto le parole giuste, come quelle che si aspettava da un familiare, e poi è andato tutto bene. A volte, forse, si parla meglio con un estraneo.
Nel Centro mi occupo di fare i test di gravidanza. Il Centro si occupa anche di questo, viene fatto gratuitamente. La maggior parte delle persone che ho incontrato erano contente della gravidanza. Sono capitati anche dei casi drammatici, sì, per esempio una ragazza abitava con il suo ragazzo che era drogato. E lei sperava di essere incinta, perché sperava di coinvolgerlo con la gravidanza, che potesse così essere spronato a uscire dalla droga. Quando ha saputo di non essere incinta era disperata. Io le ho detto “Stai contenta, che è meglio così, forse il bambino avrebbe sofferto, perché deve trovare un ambiente adatto”. Le ho detto che quello non era il modo per avere un bambino. Le ho parlato così, spontaneamente, poi di fronte alle situazioni che raccontano ti viene. Prima di venire qui ero anche preoccupata, mi sono detta “Chissà se ce la farò, se sarò in grado di parlare alle persone, di affrontare questi casi”. Io, nel mio lavoro qui, non ho visto casi disperati, disperazione, perché chi viene qui non vuole abortire. Io penso che anche negli ospedali, l’aborto sia affrontato con troppa leggerezza, viene visto come un’operazione qualsiasi. All’inizio, sentendo di essere incinta la donna si sente scioccata, c’è qualcosa che nasce dentro di te che si impadronisce di lei, è capibile che una possa stare male. Quindi è importante dare parole di conforto, cercare di capire il problema, mettersi nei panni della persona, ragionare a mente fredda, dirle “E’ una situazione che ti darà grande gioia, anche se adesso non puoi provarla e vedi solo il negativo”. Al momento è normale che la notizia della gravidanza crei problema: è impossibile sia contenta di una gravidanza che non vuole, se non l’ha decisa.
Una ragazza albanese aveva già un bambino, voleva abortire, era spaventata, disorientata per il lavoro, perché non sapeva se ce l’avrebbe fatta. Poi ha deciso di tenere il bambino ed era felicissima.
Viene spontaneo stare vicino a queste persone, ascoltare il loro problema. L’importante è accostarsi con sensibilità, cercare di strare vicino, di conquistare la fiducia.
I casi difficili vanno direttamente all’ospedale, io pensavo, quando sono venuta qua, di trovare molti casi di persone che volevano abortire e invece molte sono contente della gravidanza. Pensavo fosse difficile e invece non è difficile. Do loro parole di conforto, dico che il figlio è una ricchezza, tutte queste cose che si dicono in queste circostanze. E’ importante che noi quando parliamo con loro siamo serene, facciamo le cose in modo ragionato. Bisogna pensare che una persona che viene qua si fa il problema, se no va direttamente all’ospedale. Bisogna starle vicino.
Ø 5)
Le persone che vengono qui si trovano in condizioni difficili, tristi. Quando vengono qui, ti fai dire che cosa è successo, loro parlano, raccontano, perché hanno tanto bisogno di sfogarsi, di raccontare a qualcuno come stanno. Cercano chi stia vicino a loro. Tutte rispondono a quello che domandi, perché tutte hanno bisogno di sentirsi ascoltate. Le domande servono a capire meglio la situazione e ad aiutarle meglio dopo. Loro sono disponibili perché sanno che le stai aiutando. La preoccupazione per noi volontarie è quella di pensare come dare la soluzione migliore per questa persona. Noi pensiamo alla loro situazione che ci prendiamo in carico, e cerchiamo di aiutarle, ascoltandole, ma anche dando loro dei consigli, facendo domande per dimostrare che abbiamo capito, che abbiamo ascoltato quello che volevano dire, il loro problema. Noi ascoltiamo consigliando.
Le situazioni che ci troviamo di fronte sono sicuramente coinvolgenti, anche troppo. Per me personalmente è difficile gestire queste situazioni così coinvolgenti, perché alcuni casi sono veramente difficili. Infatti io cerco di farmi assegnare i casi meno complessi, cerco soprattutto di dare un supporto. Vedere queste ragazze giovani…a me dispiace per loro e cerco di fare del mio meglio, più che posso. Hanno bisogno di una parole di conforto, che magari nessuno le dà, si trovano persone veramente sole, vengono qui per non sentirsi sole. Parlano, si fidano di noi, e tu cerchi di consigliarle al meglio. E’ importante anche ascoltare molto. Il colloquio sta alla base del nostro rapporto che si crea con queste ragazze.
Ø 6)
Io lascio molto parlare, io più che altro ascolto. Ascolto molto e da quello che sento cerco di capire di che cosa hanno bisogno, mi indirizzo da quella parte, però direi che parlo molto poco. Quando il problema è molto grave nel senso che la persona è determinata a interrompere la gravidanza, allora faccio appello a tutto quello che posso, però in genere io parlo molto poco, anche per cercare di capire quello che serve di più alla persona. Può servire un sostegno psicologico o amicizia.
Quasi nessuna viene qui essendo proprio sola, perché ha un gruppo di persone che stanno accanto a lei, ma nell’affrontare il problema è realmente proprio sola, perché magari quelle persone non l’appoggiano: se viene qui ha bisogno di un aiuto. L’economico non è il problema più grosso, almeno non è mai o quasi mai il determinante.
C’è un dialogo che si viene ad instaurare. Preferisco non fare domande perché ho paura di invadere la loro privacy. Ho un po’ di difficoltà, ho visto che delle mie colleghe sono molto più brave a fare domande, hanno anche un bel modo, io ho qualche difficoltà, dipende dal mio carattere, sicuramente, quindi cerco di farmi dire senza domandare, se riesco, perché appunto ho questa difficoltà. Però alla fine riesco sempre a farmi dire quello che mi serve.
Si trattano casi anche abbastanza difficili, bisogna anche gestire il coinvolgimento, bisogna cercare di…non è facile, non è facile, perché per esempio quando si fallisce, non si riesce a convincere la persona a non abortire lo si registra come un proprio fallimento, ci si sente un po’ in colpa, un po’ “molto”, per il fatto di non essere stati all’altezza. Ma, ripeto, noi possiamo fare fino ad un certo punto, perché le persone devono comunque essere libere di esercitare la loro libertà. Però, a me è successo un caso di una ragazza, che non era neanche la prima volta che abortiva. Era sola, era completamente sola, lavorava in nero, quindi avrebbe dovuto essere assunta, se fosse stata incinta non l’avrebbero assunta, il padre del bambino come lei gli ha detto di aspettare un figlio se n’è andato. Lei che non voleva in nessuna maniera abortire, l’ha visto come unica soluzione e io non sono stata capace di convincerla che una soluzione poteva esserci, pur avendole proposto tutte le strade. Era stata convinta anche dalla mamma e dalla sorella ad abortire, perché la sorella aveva un figlio malato di mente e viveva molto male questa condizione, quindi la spronava a non mettersi nei pasticci, ad abortir. La mamma pure, perché diceva “Io non ti posso aiutare perché devo aiutare l’altra figlia”. Non era neanche di Trieste, era di fuori Trieste, quindi le era anche difficile incontrarci. Comunque io mi ero offerta di andare io, era di Gorizia, poi è venuta lei qui. E’ venuta per incontrarmi, abbiamo parlato a lungo, però lei ha pianto tanto, ma alla fine…Con questa ragazza io ce l’ho messa tutta perché mi dicevo che se veniva c’era motivo di speranza. Io le ho offerto tutte le possibilità, un po’ la distanza, io credo, se lei fosse stata di Trieste avrei potuto essere più concreta, no? Un po’ ha influito sicuramente quello, ma poi lei si sentiva proprio di non avere vie di uscita, perché aveva una storia difficile alle spalle, non vedeva speranze per il futuro. C’è un rapporto che si crea con il dialogo ma anche la vicinanza. Anche dopo l’aborto io l’ho chiamata, perché immaginavo la sua solitudine e, penso, anche il dolore, perché sono convinta che anche quando fanno l’aborto hanno un grosso peso da portare, c’è una sofferenza.
Ci sono anche degli atteggiamenti, che vengono usati per dimostrare disponibilità o il modo stesso di parlare, la disposizione. Io quella volta quando le ho fatto il test e ho visto che era incinta, l’ho abbracciata, sono cose che vengono anche spontanee, cioè una nuova vita porta a questa gioia, io cerco sempre di manifestarla perché la sento veramente. Eravamo in buonissimi rapporti, però c’è qualcosa che va oltre: la sua responsabilità. Mi è parso strano perché lei era fermamente decisa a non abortire una seconda volta e invece…
Nella relazione la difficoltà è di relazionarsi. C’è molta difficoltà. Le dico quello che penso io: non è facile dire “E’ un omicidio”, per cui c’è proprio una difficoltà di espressione, non è facile, bisogna dire e non dire, perché altrimenti ci possono essere delle conseguenze. Quindi c’è una grossa difficoltà in questo dialogo, a volte si cerca di dire senza parole, di far capire la gravità senza dire le parole che potrebbero pesare. Da una parte c’è la paura di non invadere la privacy, dall’altra la necessità di dire le cose, me non dire troppo.
C’è un incontro umano abbastanza partecipato, si crea un rapporto affettivo. Alcune a Natale o a Pasqua mandano anche i messaggini sul telefono, alcune con le quali si è arrivato a darsi i numeri di telefono. Si crea un rapporto di amicizia, non dico più profondo di quello con mia figlia, ma qualche volta un rapporto che ha di più, perché c’è una confidenza, fiducia. Magari i rapporti con i figli non sono sempre facili, no?
Queste persone vengono anche a chiedere consigli per allevare il bambino. Essendo essenzialmente persone che non hanno con chi parlare, almeno di certi argomenti - perché magari sono straniere, o non possono avere tanti amici e parenti che loro ritengono adatti a soddisfare quelle loro esigenze - veramente fanno riferimento su di noi. Tornano per chiedere consigli, una mano, allora viene istintivo aiutare e a volte si è meglio che come genitori perché si riesce a vedere con maggior distacco. Mentre nel figlio si ripongono delle aspettative, queste persone non le conoscevi prima, riesci ad essere più obiettiva forse, a me sembra, questo è quello che io sento.
Io adesso ho seguito una ragazza di sedici anni che ha avuto una bambina, è giovanissima. Ha avuto problemi, tutt’ora ha problemi con i genitori, in quanto adesso dipende economicamente da loro. Vive con i genitori, e ancora i genitori esercitano la patria potestà in una maniera un po’ opprimente. Ha una bambina, ma vorrebbe anche fare le cose che fanno i suoi coetanei, e così era qui con il suo partner, che è una ragazzo delizioso, abbiamo parlato, io ho cercato di far capire anche il punto di vista dei genitori, perché è un po’ difficile per loro vedere il punto di vista degli adulti, però capivo anche il suo punto di vista perché è ovvio che vogliano vivere la loro età. Si stabilisce proprio questo rapporto che vengono a chiederti come fare, come non fare.
Non succede spesso che venga la ragazza assieme al ragazzo, viene quasi sempre la ragazza da sola.
Nel colloquio questo libretto[261] ci è di molto aiuto. Molto spesso non sono molto onesti quelli che propugnano l’aborto, dicono che non c’è niente, c’è un grumo di sangue, invece il bambino già c’è, già sente, già risente. Parlare di questo penso sia l’argomento più convincente, far capire che il bambino già c’è, esplicitare. Io batto molto su questo, il bambino già c’è, non è che ci sarà fra nove mesi, far ragionare.
Il primo incontro è il momento più delicato e difficile, in cui si crea il rapporto, si stabiliscono le basi. Ci si deve conquistare la fiducia, rassicurare la persona. E’ soprattutto la persona che parla e racconta la sua storia. Anche perché meno si parla, più l’altro parla. Veramente succede così, nell’ascoltare quello che hanno da dire vedo che proprio parlano, hanno bisogno.
Quando accadono casi abbastanza difficili, c’è anche un problema di sospensione del giudizio, non far trapelare i propri valori. Non giudichiamo mai, forse accade di pensare se quello che fa la persona è giusto, ma anche e soprattutto nelle parole rivolte alla persona bisogna sempre prescindere da quello che si pensa, cercare di ascoltare a prescindere dal fatto di condividere o meno quello che uno ha fatto. Molto spesso non si condivide, però bisogna assolutamente prescindere da questo, prendersi in carico il problema, il problema c’è non importa tutto quello che ci sta dietro.
Ø 7)
Allora, l’utente parla molto poco, dobbiamo sempre partire dal fatto che la persona che si presenta qui da noi è in difficoltà. E’ in difficoltà, anche se non ha nulla da temere, perché noi assicuriamola riservatezza. Però, indipendentemente dall’età, tutte le persone che vengono qui sono disorientate dal fatto di doversi presentare e darci i loro dati, perché appunto temono che qualcuno possa telefonare, rivolgersi a noi, o assistenti sociali o familiari. Noi assicuriamo senz’altro per la prima cosa la riservatezza perché è fondamentale in qualsiasi tipo di colloquio di qualsiasi genere si tratti.
Quando io ho a che fare con una persona per la prima volta cerco di avere un rapporto privato, non vicino ad altre persone, che siano colleghe o altre mamme che vengono qui. Quindi è un dialogo a due, cerco di mettermi al suo fianco, non alla scrivania, perché mi sono accorta che proprio funge da barriera, che questa persona si sente come bloccata, allora ci mettiamo su due poltrone o, se non ho nessun’altra opportunità, cerco di dare un’impressione di assoluta confidenza, non che lei si senta come se andasse negli uffici del comune. Di solito bisogna cercare di “scavare” in questa persona perché le domande non sono ben precise, al momento uno si presenta e comincia a chiedere dalla fine del discorso, per esempio, comincia a chiedere cosa facciamo noi, se siamo in grado di aiutare, non dice “Il problema è mio”. Magari si presenta dicendo “Il problema è di un’amica” o per una parente. Dopo che abbiamo parlato, magari anche un’ora, viene fuori che il problema è suo. Man mano che andiamo avanti nel colloquio, io cerco sempre di dare un’impressione di assoluta confidenza e disponibilità, non che mi fa perdere del tempo anche se è vero, perché magari ho del lavoro arretrato o altre persone che mi stanno aspettando o magari l’orario non è quello. Vengono quando magari mancano cinque minuti alla chiusura, al limite, io non posso dire “No, torni domani” o “Rientro alle 16”. Ecco, quindi io devo essere disponibile a star qui anche in un orario che non è il mio, anche a ritornare. Io ritorno, per una persona, in orari che appunto non sono miei, o non sono orari del Centro, perché io do la mia disponibilità assoluta, al di là dell’orario, di quello che può essere il tempo, anche se io penso tutti quanti abbiamo altre occupazioni oltre a queste, no? Però dal momento in cui questa persona si accosta a me, basta: io sono a sua disposizione. Ecco, questo è il mio modo di operare, non dico che sia quello più comune. Per dire, se questa persona la sento tanto in difficoltà, a un certo punto dobbiamo concludere l’incontro, dopo che abbiamo parlato due ore. Quando abbiamo finito, cerco di farmi lasciare un recapito, le telefono anche da casa mia, per dire, la sera. Per sapere come va, per sapere se ha risolto, se ci sono state altre difficoltà, o indifferentemente semplicemente per sapere come sta. Non le dico “Ho telefonato per sapere come stai. Stai bene? ciao“. No, io devo essere disponibile all’ascolto, perché la cosa fondamentale in qualsiasi tipo di volontariato è l’ascolto. E questa persona naturalmente si apre e parla e parla tantissimo.
Nel primo incontro certe parlano di più, certe parlano di meno, non possiamo dire che le persone siano tutte uguali. Ci sono parole che si devono tirare fuori con le pinze o persone alle quali quando si chiede “Come ti chiami”, “Quanti anni hai” e si mettono subito sulla difensiva perché temono, hanno paura, non vogliono dare i loro dati. Insomma bisogna cercare di far capire che io non chiedo i loro dati per divulgarli, per fare una statistica, ma semplicemente per aiutare.
Scegliere le parole giuste è molto difficile. Io premetto sempre “Io non sono qui per giudicare quello che vuoi fare, non do giudizi, io sono qui per aiutarti, quindi tu mi devi dire quello di cui hai bisogno, le tue necessità, il tuo problema”. A questo punto la persona comincia a rilassarsi, ad ammorbidirsi un pochino, perché altrimenti sta sulle difensive, si vede dall’apprensione, si vede dal modo di gesticolare, si vede da tante cose il disagio. Quindi, dopo averla messa a suo agio completamente, si comincia a fare le domande, a discutere le varie problematiche, perché non è che si possa aggredire una persona, cominciando subito a dire “Lei lavora?”, “Da quanto lavora?”, “E’ disoccupata?”. Non si può fare in questo modo qui il colloquio. Sicuramente prima di tutto viene il rispetto, il fare capire che si è lì per lei. Dopo lo dice lei spontaneamente “Io sono studentessa” oppure “Sono casalinga”, “Ho difficoltà economiche”, no? Allora io dico “Sì, che tipo di difficoltà ci sono?”. Restando un po’ sul discorso che ha cominciato lei, ma non fare un interrogatorio, se no questa persona proprio si blocca completamente. Bisogna essere disposti all’ascolto, come chiave, non dico sia una ricetta, però questo è il modo. L’ascolto è il passo che permette di instaurare subito il rapporto, perché se la persona si sente ascoltata con sufficienza o di essere giudicata, oppure si rende conto che l’altra persona - che magari questa storia l’ha sentita all’infinito e sa già come andrà a finire - prova magari una sensazione di fastidio o insofferenza, non si riesce a instaurare un rapporto. Questa persona non ritorna più. Per questo motivo, torno a dire, io cerco di avere la sua fiducia, che mi permette poi di chiederle il numero di telefono. Se sono ragazze che vivono con i genitori, è chiaro che non posso telefonare a casa, o se telefono a casa, mi devo presentare sempre come un’amica, lasciando il mio nome di battesimo, così la ragazza capisce che ero io, quindi mi telefona, mi richiama, se non mi risponde lei. Ecco, questa è una cosa che s’impara. Se ha il telefonino, mi dice “Guardi, non c’è problema, lei mi può chiamare di sera a qualsiasi ora”, e io sono disposta. Mi dice delle fasce orarie, ecco.
Si crea un rapporto, una relazione con la persona che ha bisogno del nostro aiuto.
Un rapporto umano, come tale, ha come caratteristica il coinvolgimento. Bisogna cercare di capire il problema della persona e cercare di non lasciarsi coinvolgere emotivamente, perché dal momento in cui io vado nella mia sfera emotiva è chiaro che io posso sbagliare, perché l’emotività non aiuta a essere razionali, e quindi manca l’obiettivo che è aiutare. Io non posso coinvolgermi, devo sempre arrivare fino ad un certo punto e sapere gestirmi, perché se mi lascio coinvolgere emotivamente, basta, non sono più neanche io in gradoni vedere chiaramente il problema. Già questa persona viene qui che è emotivamente stravolta, perché è chiaro, sono persone che hanno problemi grossi, se no, non si rivolgerebbero da noi per cose da poco. Quindi io devo essere con i piedi piantati per terra. E’ una difficoltà, torno a ripetere, però se si parte dall’ascolto, dopo viene tutto pian pianino, dopo non è difficile.
Quindi l’ascolto è capire il problema, accostarsi all’altro, ed essere disponibile, dare disponibilità. Quindi la persona sa che può chiamare, sa che io la chiamo anche alle undici di sera se me lo chiede, o di domenica, per dimostrarle che io ci sono. Non è che io ti abbandono, che tu vieni qui, ti troverai un’altra persona e devi raccontarle tutto di nuovo. C’è continuità, perché il rapporto che instauro io devo seguirlo io, è assurdo che questa persona torni domani, torvi una mia collega e debba raccontare tutto. Siamo, sì, tutte quante operatrici, ma ognuna opera in modo diverso, non è che siamo fatte in serie: ci sono quelle più aperte, più simpatiche, più fredde. Ecco, io prendo questa persona e la seguo in tutta la sua difficoltà. Evidentemente è libera di fare le sue scelte, anche, perché è libera di scegliere la strada che ritiene migliore. Io posso consigliare, ma non posso costringere, no? Però io seguo questa persona in tutto il suo percorso. Per dire, se ha una gravidanza, io la seguo per tutto il periodo della gravidanza e anche dopo, quando ha bisogno. Quando lei si sente sicura e affrancata e non si rivolge più a noi, lo chiude lei il rapporto, non lo chiudo mai io per prima. E anche se le cose vanno male, non è che io chiudo il rapporto, seguo questa persona in tutta la sua difficoltà, anche dopo, perché è il momento più difficile. Anche se ha fatto una scelta che io non condivido, premetto “Io non condivido la tua scelta, ma non sono qui per giudicarti, ma per aiutarti”. Quindi io faccio questo discorso, che devo fare per dimostrarle disponibilità all’aiuto, che sento di farlo, non per dovere, perché ci credo, perché altrimenti non sarei qui a fare la volontaria. Però io la seguo in tutto, anche nel caso decida per l’aborto, perché a quel punto c’è il crollo, e non è giusto abbandonarla perché non ha seguito i miei consigli. Ecco, quindi lei sa di poter contare su di me. Se io non la chiamo ho notato che certe dicono “Ma, aspettavo la sua telefonata ieri sera”. Se uno riesce a instaurare questo tipo di rapporto, trova la disponibilità anche in questa persona, che altrimenti si chiude a riccio. C’è bisogno di disponibilità reciproca e c’è bisogno di tanta disponibilità da parte dell’operatore. La persona che viene qui da noi viene qui per un bisogno, però oltre che ad ascoltale, lasciarla parlare, io devo darle anche l’impressione che è vero che le do tutto la mia disponibilità, che non è solo una parola. Appunto per dimostrarlo le telefono, la chiamo di sera, la chiamo al di fuori del mio orario, se vuole ci vediamo, ci diamo un appuntamento qui in ufficio e io vengo. E lei non parla con le mie colleghe, con le signore che sono di là, ma cerca me. Quindi stiamo qui altre due ore, per dire, non è che in un colloquio dico “Abbiamo parlato mezz’ora, basta”, io devo stare fino a quando sento che questa persona ha bisogno di sfogarsi.
Noi cominciamo sempre un colloquio dicendo “Perché, per quale motivo viene qui da noi, è stata mandata da qualcuno, come ha saputo di questo Centro? L’ha saputo da una pubblicità, da un’amica? Ha qualche problema? Qual è il suo problema?”. Pian piano, perché ci sono vari tipi di problemi, ci sono persone che vengono qui, aspettano un bambino, oppure hanno un bambino piccolo, hanno problemi economici e hanno bisogno di essere supportate con tutte le cose che servono, dalla carrozzina , al corredino, ma quelli sono casi facili, anche se non è facile per queste persone chiedere. Cominciano a chiedere “Ho bisogno di un paio di scarpine”, poi viene fuori che hanno bisogno di tutto, no? Ecco, questo è un altro tipo di servizio che diamo noi, però è più facile.
Non sono tanto rari i casi in cui la ragazza viene col ragazzo, capita soprattutto se sono giovani. Certe volte capita che se sono giovani, anche studenti, si presentano assieme, allora appena arrivano dicono “Possiamo parlare in privato?”, dicono subito questo. Dicono subito il problema, dal momento in cui si presentano sono disponibili, non occorre stare lì a tirar fuori le parole. Non è un problema questa situazione perché se si presentano assieme è più facile, perché vuol dire che anche il ragazzo non vede la paternità e la maternità in modo negativo. Se no la ragazza è sola, completamente sola.
E’ fondamentale non far trasparire i propri giudizi, dare questa impressione di calma tranquillità, anche perché se io mi faccio vedere nervosa e irritabile è chiaro che, insomma, non è il massimo, perché questa persona deve sentirsi a proprio agio, questo è fondamentale.
Nella relazione giocano parte in causa l’aspetto dialogico più quello non verbale. Entrambe le cose sono determinanti.
Ø 8)
Io sono in un turno proprio di quelli più impegnati, il turno del giovedì, assieme a quello del lunedì, sono i turni che hanno più “traffico”. Vengono qua direttamente oppure abbiamo un telefonino ventiquattro ore su ventiquattro e lo teniamo a turno, dove ci arrivano le richieste d’aiuto più urgenti. E’ proprio una questione di saper agganciare per non perdersi per strada. Io ho avuto fortuna, le gravidanze che ho seguito sono andate tutte in porto, sono riuscita in qualche maniera a convincere la persona, garantendo la privacy, ad avere proprio quell’incontro fisico, dopo la telefonata, che è importante ottenere.
Noi facciamo sapere siamo un gruppo – almeno io uso questa tattica qua – che siamo un gruppo di volontarie, che oltre a garantire appunto l’anonimato, che è importante, siamo pronte ad ascoltare, a non giudicare. Poi, se credono, dopo che ci siamo visti, si può darsi un nuovo appuntamento, perché alla persona abbiamo ispirato fiducia, perché magari quello che si detto è convincente. In realtà, nel tempo del primo incontro, ci si studia un po’, una volta che ci si vede di persona, per cui se ispiro fiducia chiaramente la persona viene più volentieri. Poi appunto facciamo sapere che siamo qua, perciò partiamo da dove vogliono loro. La disponibilità di partenza, è importante, siccome la maggior parte delle persone che si rivolgono a noi hanno problemi familiari, o perché è la ragazzina giovane e ha paura a parlare con i genitori, o perché c’è la donna coniugata il cui bambino non è del partner, o ci sono persone che non lavorano – anche se capita ci sia solo la donna coniugata e basta - e perciò ci sono situazioni quasi sempre pesanti. Raramente si rivolgono a noi persone che stanno bene, però accade anche questo, per esempio da noi è capitata una richiesta d’aiuto da parte di una signora che aveva già dei figli grandi, per cui si è trovata di nuovo in maternità e tutte le perone che stavano attorno a lei le dicevano “Ma chi te lo fa fare, dopo tanti anni, adesso ormai sei libera”, e lei aveva l’istinto, il desiderio di maternità, si sentiva di volere il bambino, perciò era molto confusa perché aveva tutti contro. Lei sola era quella disposta a continuare la maternità e da sola non ce la faceva a convincere tutte le altre persone. Diciamo che questo è un caso ottimista, perché noi sentiamo anche casi di ricatti veri e propri da parte della famiglia, perché non accettano la situazione. Allora loro, venendo, trovano un gruppo di persone disposte ad ascoltare. Io volendo sono anche riuscita a stabilire dei rapporti di amicizia, tra virgolette, anche perché i casi che si presentano nel nostro turno ce li portiamo avanti, per non costringere la persona ogni volta ripetere alla mia collega di nuovo tutto. Magari loro trovano il coraggio di parlare una volta, ma non lo trovano una seconda. L’importante è sapere se vuol parlare ancora, se ha bisogno di me – a parte che la disponibilità c’è sempre, in ogni ora del giorno e della notte, qualunque giorno della settimana oltre al mio turno. Però l’importante è stabilire un rapporto in questi termini. Io mi trovo particolarmente fortunata, perché fra i tanti casi che ho avuto, con tre casi sono riuscita proprio a stabilire un percorso. Per cui abbiamo cominciato in questo modo: lei mi ha raccontato tutta la sua storia, io le dicevo “Si può fare questo, si può fare questo, si può fare quest’altro, da dove partiamo, cosa vuole che facciamo?”. Allora siamo riusciti proprio a portare avanti la gravidanza, ad avere il figlio e, comunque, ad andare avanti.
La fiducia è un po’ una questione di feeling. Si sente subito se c’è il contatto, se le cose vanno bene. Si trovano anche persone che hanno paura di confidarsi, ma che lo vogliono, allora bisogna riuscire a vincere questa diffidenza, a dire “Bé, ma guardi, adesso ci siamo viste, facciamo un altro incontro, ci vediamo, ne parliamo”. Qualche volta proprio mi è successo che sono andata avanti due tre volte senza sapere come si chiamava questa persona, però tornava, e questo per me era importante. Sarà una questione proprio di pelle, però è importante sapere che noi non giudichiamo, cioè, la persona che viene qua sa di poter parlare, per una volta, a ruota libera, senza essere giudicata, acquisendo pian piano la speranza di farcela. Allora è importante per noi fare capire che cosa accade dentro di loro, abbiamo anche opuscoletti che servono soprattutto per le persone che magari dicono “Io vorrei un figlio, però in questo momento non posso”. L’importante è sapere, arrivare a capire se il figlio lo vuole, se è solo una questione di paura. Allora pian piano, pian piano, smussiamo le paure. Diciamo “Guarda, se hai questo problema ti possiamo dare una mano, un aiuto”, se le serve l’appartamento “Cercheremo assieme una soluzione”, prendiamo noi i contatti con le varie istituzioni. Cerchiamo di dare un aiuto a tutto campo. L’importante, la cosa principale, è vedersi, potersi parlare. Più difficile è quella persona che prende contatto telefonicamente, che si confessa telefonicamente. Convincerla a venire, quello è un po’ il punto più duro, no? Allora io dico “Lei venga, se non vuole venire in sede, non facciamo l’incontro in sede”, perché tante magari temono di essere viste, allora dico “Va bè, guardi, ci troviamo fuori, beviamo un caffè assieme, se lei ritiene che io possa ispirarle fiducia e che ci possa essere un proseguo bene, se no lei sarà libera di decidere”.
Così va anche bene, però ci sono dei casi un po’ più estremi. Veramente qualche volta, diciamo, per fortuna, poche, qualche sconfitta l’abbiamo avuta. Però diciamo che ci amareggia. La domanda qual è? “Dove non siamo riusciti a capire”, no? Anche in queste sconfitte rare – eppure, però, qualcuna c’è stata - l’unica cosa che riusciamo a fare è domandarci “Dove abbiamo fallito?”. Ecco, perché noi pensiamo comunque al bambino, pensiamo che c’è un bambino in meno. Questo dispiace.
Le dirò una cosa, nelle relazioni che costuiamo, dobbiamo rimanere un momentino…staccate. Sì, ci facciamo coinvolgere, però dobbiamo rimanere un momentino lucide, no? Se no, se ci facciamo prendere dal sentimento diventa difficile, non si può operare lucidamente. Allora il coinvolgimento c’è, però diciamo che lo teniamo per noi, no? Esternamente, siamo volontarie, che diamo una mano e ci dimostriamo disposte in qualunque maniera ad aiutare, dopo salta fuori il coinvolgimento, magari dopo aver risolto tutto. Per esempio per un caso io sono andata a far da madrina. Salta fuori evidentemente il coinvolgimento, per esempio, con questa persona sono rimasta in contatto. Essendo lei una ragazza giovane e avendo io un’età “da nonna” - infatti sono effettivamente nonna – si è sentita un po’ protetta. Forse hanno meno problemi a parlare con noi proprio le ragazze giovani, forse perché hanno problemi di famiglia: non hanno avuto rapporti familiari, non hanno magari l’occasione di poter parlare in famiglia. Allora, trovando una persona disposta ad ascoltarle, che non le giudica, si sentono più disposte a parlare.
E’ fondamentale il primo incontro, l’impatto iniziale: ci giochiamo già tutto con la telefonata. E’ difficile, c’è responsabilità. La chiave è che noi diciamo tutto, ma non tutto, lasciamo quel poco di curiosità nella conversazione al telefono, cerchiamo di incuriosirle. Allora questa persona viene. Magari le diciamo “Adesso al telefono non ci possiamo dire tutto, ma di persona riusciamo a parlare più approfonditamente”. Infatti queste cose che sono così delicate non si possono dire con fretta, in modo staccato. Il problema è vincere un po’ questa diffidenza che hanno. Gran parte sanno di noi perché hanno avuto delle conoscenze, delle amiche che hanno parlato e hanno fatto il passa parola, oppure perché hanno visto la nostra pubblicità. Il caso forse un po’ più difficile è quello della persona che ha saputo di noi attraverso la pubblicità, perciò non sa come siamo noi…perché magari se fanno il passa parola dicono “Vai in questo turno, c’è questa persona, ha pazienza, ti ascolta”.
Più di tutto secondo me è importante il fatto della pazienza nella telefonata, no? Perché quasi sempre il primo aiuto avviene proprio attraverso un telefono, per questo motivo abbiamo istituito questo telefonino attivo sempre. Non sempre la persona dice subito tutto, c’è chi non dice subito la verità, chi la dice per gradi. Dice e non dice, comunque anche noi diciamo e non diciamo, in maniera da suscitare quel po’ di “curiosità”.
Di solito non facciamo domande, lasciamo che parli la persona, cioè che ci dica quello che vuole. Dopo le facciamo, una volta che siamo sicure che questa persona si fida di noi, allora cerchiamo di entrare un po’ di più proprio nel particolare, per capire un po’ di più la sua personalità, i problemi. L’importante è che la persona sa che viene qua, troverà me, che l’ascolto, non giudico e mi baso su quello che mi racconta. Alcune vengono anche per il test di gravidanza, allora sperano e non sperano, no? Allora noi vediamo la reazione che hanno e cerchiamo di far capire che è normale la preoccupazione iniziale. Tentiamo di capire perché c’è preoccupazione. Allora non so, se il motivo della preoccupazione è la famiglia, diciamo “Va bè, possiamo fare qualcosa”, oppure troviamo un modo per rassicurarle. La gran parte, per esempio, ha paura che i genitori reagiscano. Dico “Sì, reagiranno, perché magari sono delusi, tutti i genitori hanno delle precise aspettative nei confronti dei figli”. Mi “metto in mezzo” anch’io sempre in prima persona, allora dico “Sì, essendo un genitore è chiaro che se capitasse a mia figlia…”, però sottolineo che i genitori sono anche i primi a perdonare, per cui di fronte a una nascita, di fronte a un bambino le cose cambiano, si rendono conto che è un miracolo. Insomma, dopo riusciamo, qualche volta, con fatica e fortuna, a coinvolgere la famiglia, indirettamente, perché non abbiamo quasi mai colloqui con la famiglia. Suggeriamo il modo, il comportamento alla persona, rare volte entriamo noi in rapporto con la famiglia, perché la gran parte non vogliono coinvolgimento, no? Non ci sono rapporti diretti, se proprio non viene la ragazza con la madre. In questi casi, il più delle volte, abbiamo più problemi con la madre che con la ragazza. Rare volte, rarissime volte, capita, perché appunto se hanno la famiglia alle spalle non hanno problemi e sono risolvibili, la necessità di venire qui da noi viene soprattutto quando non hanno la famiglia alle spalle.
Bisogna prenderle per mano, accompagnarle come fosse la propria figlia. E io sono entrata anche addirittura in sala parto con alcune di loro, perché poi a quel punto ci chiedono quella piena disponibilità che noi, a nostra volta, diamo. Per questo motivo si parla di rapporto di amicizia, che, quando subentra, diventano un po’ figlie adottive. Io dico che, per me, ho una figlia in più, ecco.Noi diciamo comunque “Noi ti diamo una mano, ti aiutiamo, però devi darti una mano anche da sola, far vedere che ce la farai, hai responsabilità, non sei più sola, devi decidere sempre per due”. Per cui la coinvolgiamo come madre subito, no? Cerchiamo di farle capire, anche dagli opuscoletti, che, insomma, il bambino c’è già dal primo momento. La gran parte non sapevano neanche cosa succedeva in loro. C’è anche un aspetto formativo.
Si crea un rapporto, fondato sul dialogo, sull’ascolto. Questa è proprio la base, perché poi per dare la maglietta e tutto il resto si sta poco, sono cose più facili, più risolvibili. Devono sapere che possono venire qua e trovare delle persone che sono disposte ad aiutarle, senza chiedere niente in cambio.
Noi lasciamo che parlino loro, se poi abbiamo intuito che possiamo osare, osiamo. In qualunque caso, quando vengono per chiedere aiuto, manteniamo sempre l’anonimato, rispettiamo la loro privacy. Questo è il punto base per loro di capire che alla fine noi non le tradiremo mai. Anche perché sono spaventate, si trovano di fronte a problemi che non pensavano, inaspettati. Proprio alcune di loro non sanno niente, sono anche alla prima gravidanza, per cui noi diciamo “Guarda, succede questo. Ti accompagnamo qua, prenotiamo e portiamo noi alle visite”. Andiamo alle visite al Burlo con loro, addirittura gliele prenotiamo noi. Poi, se occorre, facciamo anche da tramite con gli assistenti sociali. Loro non sanno proprio dove andare, a chi rivolgersi, per cui uno che tolga le castagne dal fuoco fa anche comodo, diciamo. In questo senso si fidano.
Le parole che si usano non sono standard, no? Si trovano anche sul momento, quando la persona è davanti. Comunque sempre è più quello che non si dice che quello che si dice che convince. Ci può essere la richiesta d’aiuto telefonica e noi diciamo “Guardi, non c’è problema, non si preoccupi. Vuole che ne parliamo di persona? Se non vuole ci troviamo in un altro luogo, se non vuol dirmi il nome non me lo dirà neanche”. Così già c’è il primo impatto. E dopo, le dico, parole di conforto d’istinto. L’importante è non essere aggressiva, non essere quella che punta il dito, non trattare lei come la poveretta che chiede aiuto: siamo due persone amiche che si sono incontrate e si raccontano le loro disavventure, una racconta, l’altra ascolta. Dopo, non c’è un “sistema”. Io cerco di entrare nella mentalità loro, nel loro punto di vista, cerco di non dire “Questa ha sbagliato”. Dico “A questo punto noi siamo qua per poter risolvere”. Faccio capire che comunque non c’è mai da dire “E’ finita, non c’è più speranza”, c’è sempre una possibilità, siamo sempre nella direzione della possibilità, far parlare, farla cercare una strada, no?
Ø 9)
Intanto si parte dalla problematica specifica. Nel “Centro di Aiuto alla Vita” dovrebbe essere l’accoglienza e l’aiuto alla donna in difficoltà per la gravidanza in attesa. Accompagnare la donna affinché faccia una scelta per la vita e non per l’aborto, questa è la problematica nostra specifica. Però in realtà accogliamo anche mamme già con bambini, con bambini già nati che hanno problematiche diverse. L’approccio al colloquio dipende dal problema per cui si presenta la persona, che non è sempre identico. La teoria dice di fare “accoglienza – ascolto – accompagnamento”, insomma, la relazione d’aiuto è questa. L’approccio è questo, ma dipende molto da come la persona si presenta. Nell’accoglienza, noi cerchiamo di essere così, anche molto sorridenti, molto rassicuranti, nel momento in cui la persona si avvicina, viene qua dentro già con l’idea di fare la scelta dell’aborto, che rischia di diventare un passo che verrà attuato concretamente. In questo senso l’approccio è estremamente difficile, pur partendo sempre dall’idea che, se una persona viene qua, probabilmente è ancora molto incerta sulla scelta da compiere. Per cui bisogna un attimino rassicurare la persona.
Personalmente devo dire che quando faccio il colloquio, guardo, osservo un attimino com’è la persona. Per capire cosa dire non dire all’inizio, è importante, sono determinanti le prime parole e come vengono pronunciate, sia da parte nostra, sia da parte della persona. Io credo bisogna metterla a proprio agio, farle sentire che si trova in un ambiente rassicurante. E poi credo che bisogna ascoltare, proprio, anche ascoltare la persona oltre alle parole che ti sta dicendo, quindi , oltre alle parole ci può essere la gestualità che ti può aiutare un attimino o, non so, la gestualità in senso complessivo, il viso, gli occhi, se si “stropicciamo le mani”, magari se fumano la sigaretta. In quest’ultimo caso garantire la presenza della saletta dove si può fumare è fondamentale. L’idea è di ascoltare. Chiaramente, la donna che viene qua ti dice quasi sempre subito “Io ho pensato di abortire, perché non so come fare, come andare avanti, se portare avanti questa gravidanza”, o racconta mille, mille problemi.
Partiamo sempre dal discorso, come diceva Maria Teresa di Calcutta, di non dire mai che una donna sia portata a fare una scelta di aborto per un problema economico. Quindi vengono fuori mille problemi, ecco. Allora io credo che fra i mille problemi che qui dicono, bisogna focalizzare l’attenzione su un punto: qual è il problema principale. Alcuni problemi che vengono posti sono conseguenza del problema principale. Quindi capire se è un discorso di solitudine della donna, che è stata abbandonata, o può essere il problema dettato dal fatto che partner spesso dica di starle accanto, qualunque cosa decida. A proposito della posizione del partner, questa è una cosa che mi fa molto arrabbiare, in una coppia, quando il padre dice questo. Io pendo “No, è come uno scaricare le responsabilità sulla donna”. Ognuno deve dire chiaramente come la pensa, anche perché la donna deve essere nelle condizioni di decidere del proprio futuro, non avendo l’uomo accanto “qualunque cosa accada”. Non è rassicurante assolutamente, anche se invece la donna ritiene questo sia un discorso rassicurante da parte del partner. Si sa benissimo che la scelta, in fondo, è della donna, è personale e le conseguenze, nel bene e nel male, se le porta la donna. E l’uomo accanto credo che ci sia e non ci sia, per carità, anche se si deve dire che alcuni uomini ci sono. Più spesso ci sono quando la donna fa la scelta per la vita, anche se sembrerebbe un controsenso, perché quando fa la scelta, così, di morte quella donna rimane molto scottata e avrebbe anche bisogno di conforto.
L’ascolto è fondamentale, perché l’ascoltare con attenzione – che è un po’ diverso dal sentire, infatti, sentiamo parecchi rumori senza porvi attenzione – è forse la posizione che più ci dispone per capire la persona e far sì che la persona capisca che in quel momento tu la stai capendo, che stai camminando al suo fianco, è questo l’importante. Questo è ciò che trasmette la fiducia, la persona lo percepisce se tu sai trasmettere questo: che tu la stai ascoltando, non perché sei lì dietro ad una scrivania o lì accanto a lei sul divano, ma perché stai condividendo quel momento, quel suo momento di vita difficile e travagliata, qualunque sia la causa, questo è l’importante. A quel punto scatta la fiducia, perché trova la persona che può dare informazioni, aiuto concreto, oltre che ascolto. Diceva una psicologa di Milano, venuta qui una volta a parlarci, che le donne in gravidanza, che spesso hanno difficoltà, hanno una storia in cui, nell’infanzia, si sono sentite forse rifiutate all’inizio, quindi hanno bisogno di trovare un “utero” per essere accolte. Probabilmente bisogna far capire loro che tu puoi essere forse l’ “utero”. A quel punto lì cominciamo.
Io non pronuncio mai la parola “aborto”, però dico chiaramente, una volta che l’ho ascoltata, come la penso io, secondo la mia vita, la mia educazione, il mio credo religioso, chiaramente proprio perché si capisca che comunque io parto da una posizione, non posso nasconderla, soltanto perché sto parlando con lei. Ma questo mi porta a dire che, comunque, una persona proprio perché – io lo dico sempre sono cristiana, quindi accolgo, sono amica di tutti a prescindere da qualunque cosa – anche la chiarezza nel rapporto è fondamentale, secondo me, non il nascondimento, perché uno che viene qua sa che noi comunque siamo per una scelta precisa, e nasconderlo non ha senso. Certo non pronuncio mai la parola “aborto”, perché è una cosa che spaventa, è come quando si parla della droga o del fumo come ciò che porta poi alla morte. Io credo che ci sia una reazione nelle persone a fatti del genere. Quindi aborto come forma, così, di morte e di assassinio non la pronuncio mai. Perché comunque anche qualora quella donna decida di farlo, voglio dire già si sentirebbe tutta la vita colpevole, non vorrei proprio, a cose fatte, si sentisse una vera assassina, perché deve pur ricostruirsi la sua vita, no? Perché se no che cristiani si è se uno sbaglia e poi non può ricostruire la propria vita? Ecco, quindi non l’adopero mai, certo, parlo di interruzione di gravidanza, parlo delle conseguenze a livello psicologico, parlo della gioia per una scelta di vita e poi arrivo a parlare di problemi più pratici, economici.
Chi ha problema di solitudine ha capito che ha trovato la persona che può avere al suo fianco, quindi il problema l’ha già in parte risolto, sa che può contare su di me, no? Allora questo è il lato risolto. In seguito, passiamo a parlare e a sostenerla, dicendo “Non sei sola, qualunque cosa tu decida, se per la vita o per la morte”, allora già la vedi più sollevata. Allora possiamo darle quegli “zuccherini”, che sono gli aiuti economici che possono avere dal privato, dal privato sociale, dal volontariato e dalle istituzioni.
In realtà, se fosse così semplice anche convincere la persona dell’aiuto, riuscendo a raggiungere donne in queste situazioni di decisioni difficili, non ci sarebbe questo numero enorme di aborti, in particolar modo nella nostra regione, nella nostra città, no? Io, però, devo dire che, in undici anni di servizio, mi è capitato una sola volta in cui proprio non sono riuscita…Non mi sono assolutamente colpevolizzata, probabilmente non sono riuscita a entrare in relazione, non sono riuscita a far capire. Poi però la donna aveva dei problemi maggiori, che io non ho colto. Per il resto devo dire ho avuto esperienze positive, hanno portato avanti la gravidanza ed erano contente.
Solo che è un tema talmente delicato questo, perché voglio dire non si accoglie solo la persona, ma una persona che ha un’altra persona dentro di lei, che non ha voce, quindi una doppia presenza. E’ molto più complesso questo servizio. Cioè è complesso anche l’altro servizio che faccio come Caritas, perché comunque accogli persone con varie problematiche. Però qui c’è un altro tesserino che non può dire le proprie ragioni, no? Quindi l’attenzione maggiore è questa, poi, insomma, anche noi abbiamo imparato a fare questo servizio, in realtà, soprattutto facendolo. Nell’esperienza ci confrontiamo molto nell’ambito dei gruppetti. Negli stessi turni si vede la diversità degli approcci, del carattere, delle persone. Fra di noi dopo ne parliamo, e poi ogni settimana c’è la riunione di giunta. La riunione di giunta è fondamentale, perché, intanto fai chiarezza; ci può essere chi ha colto, è più obiettivo rispetto a te nel giudicare, nel dirti se hai commesso l’errore, dove l’hai commesso e cosa sarebbe meglio fare, perché il colloquio non si esaurisce la prima volta. Certo la persona che decide di abortire non torna più, ma quelle che poi ritornano ancora e il margine di tempo per prendere la decisione c’è, tu sai che la settimana dopo le rincontri e hai il tempo di confrontarti con altre. E’ importante, anche perché in certi casi è facile proprio perdere l’obiettivo guida, no?
Io credo che proprio le persone che vengono qua capiscono che noi possiamo diventare un punto di riferimento fondamentale: è questo che devono capire. E cerco di far capire proprio anche nel caso che decidano per l’aborto, mi piacerebbe poterle rivedere. Noi le invitiamo a ritornare anche dopo, perché sappiamo che ha un bisogno estremo, così, dopo, ci possiamo appoggiare a chi ne sa più di noi, come la psicologa, perché il discorso è di levare proprio una colpa che nasce. Bisogna far capire che noi non siamo qui per giudicare, ma per accompagnare anche nel momento della sofferenza “post”.
C’è coinvolgimento, però, quando accadono gli insuccessi, bisogna farsene una ragione. Anche perché in questo volontariato, che è così specifico, è veramente facile sentirsi inadeguate, certe volte colpevoli. E invece queste riunioni di giunta che facciamo aiutano anche in questo. L’insuccesso nell’ambito dell’accoglienza è frequentissimo, anche perché qui purtroppo qui è il tempo che manca, nel caso dell’aborto. Se una persona viene, e già da due mesi e mezzo aspetta il bambino, il tempo è poco. Non c’è niente di tempo, in altri casi forse un po’ di più, in altri servizi di volontariato, di accoglienza. Si vede come accoglienza – ascolto – accompagnamento alla persona possa durare anche dieci anni, per dire che non c’è questa scelta vita – morte così incombente. L’insuccesso, nel caso dell’altro tipo di intervento, diverso dal nostro, è più facile da essere fronteggiato, perché puoi sbagliare, ma anche fare una revisione, rincontrare la persona, puoi fare un tipo di approccio in cui ti poni degli obiettivi assieme alla persona, da raggiungere assieme. E lì porti avanti il discorso dell’accompagnamento. Nel caso dell’accompagnamento alle donne in stato di gravidanza, il rapporto si può esaurire proprio anche in un unico incontro. C’è molta responsabilità, è un lavoro impegnativo, ecco perché io punto molto sui corsi di formazione di aggiornamento – infatti in Caritas do una mano per i corsi di formazione–. E’ un mio interesse, che ritengo importante per avere gli strumenti per fronteggiare un colloquio, per il quale bisogna essere un po’acculturati, perché non basta solo la pratica del servizio, ma anche la persona esperta che ti dice “Guarda che se ti capita questo puoi far così” oppure “E’ giusto che tu provi, è normale che tu provi la sconfitta, l’insuccesso, ma per gestirlo fai così”. Certe volte abbiamo bisogno di chi ci dice come fare, quindi è estremamente importante, fondamentale. E’ importante, una volta preparati, anche avere il coraggio di fare il primo colloquio, come per il caso per i volontari che cominciano. Io l’ho fatto dopo circa un anno di servizio, mi hanno proprio buttato dentro. Bisogna avere il coraggio, perché io cercavo di frenare. Poi, va bè, si comincia.
Io trovo comunque più facile aiutare le ragazze più giovani, perché il loro modo di vivere non è strutturato completamente, quindi è più facile riuscire a trasmettere messaggi diversi, che non avere la persona adulta, con trent’anni alle spalle, la quale, se ha deciso, raramente riesce a tornare indietro. E’ già condizionata, non so, ha una vita già impostata, nei suoi desideri, come comprare la casa, oppure ha dei problemi che deve affrontare, come nel caso in cui abbia perso il lavoro, e non se la sente di far fronte a una novità che comunque sconvolgerebbe la sua vita. Ha una vita impostata, si trova con un figlio, magari molto tardi, che rischia di vedere come il piccolo intruso che rovina il proprio personale tracciato. Quindi è più facile, tutto sommato, parlare con la ragazza giovane, che si trova sola. Trova magari in te l’amica, la mamma, l’utero, è più facile camminare assieme con lei, piuttosto che non con la persona adulta.
Tornando all’argomento tempo. Anche il professor Desinan, che è venuto qui da noi per conferenze, oltre a dirci come si fa il colloquio, capisce perfettamente che il nostro servizio è molto più veloce. Di fronte a una donna, che viene con il certificato di gravidanza ed è incinta da neanche un mese, io so di avere al massimo un paio di mesi. Non so, si deve essere estremamente bravi, e la donna è anche talmente incerta di quello che vuole fare. E’ capitato un paio di volte ad altre volontarie di donne che sono venute qui con il certificato e poi hanno deciso di non abortire. Quindi questo può capitare. C’è speranza, però, se una persona viene già con il certificato, io tremo all’idea di doverla accogliere una persona così, con il certificato in mano…magari ha anche già l’appuntamento. Quindi bisogna essere estremamente rapidi, riuscire proprio a trovare quel piccolo appiglio per costruire una relazione d’aiuto.
Io credo che bisogna ascoltare molto. Per cominciare un colloquio cerco, come si dice, di rompere il ghiaccio, però in realtà l’errore madornale che uno può fare è cercare già una risposta che sia un “sì” o un “no”. La domanda la puoi fare, ma per trovare una risposta un pochino più discorsiva. In quello che si dice, in tante cose che si dicono, magari, riuscire a capire come partire per la seconda domanda. Io credo un po’ si debba procedere così, perché se io domando “Si sola?”. “Sì”. “Pensa di tenere il bambino?” .“No”. Così il colloquio è già finito, sembra un interrogatorio. Quindi proprio fare una domanda che porti così a fare parlare “a fiume”, no? Fra mille cose che vengono fuori, tra queste – lì è la bravura – riuscire a poter agganciare un discorso, fra mille problemi che ti dice, qual è il problema principale. Fra mille parole che dice, qual è la parola chiave per andare avanti. Credo che, in fondo, questo sia il nostro compito. Non è facile, però noi ci aiutiamo molto l’un con l’altro e spesso a metà colloquio si può dire “Posso chiamare l’altra volontaria?”. Spesso chiamano me, io sono esperta un po’ di legge, di articoli. Quando siamo già a un punto nel colloquio in cui si arriva a cercare di capire quali sbocchi ci possono essere, se ha problemi economici, a volte mi chiamano, perché in ogni ambito poi c’è la persona che se ne occupa di più. In quest’ ambito sono più io che mi interesso di queste cose, anche perché mi piace, ho anche possibilità di trovare dei contatti. Ci si aiuta, nell’ambito del colloquio, anche quando si capisce che la persona ne ha bisogno, basta chiedere “Posso chiamare questa volontaria che si occupa di questa cosa?”, allora a questo punto la persona può anche pensare “Non posso contare solo su un aiuto, ma ne ho due”. Non accade all’inizio del colloquio, voglio dire, due volontarie di fronte a una persona rischierebbero di farla sentire a disagio...infatti è sbagliato un approccio così.
A volte hanno bisogno di una persona più giovane, a volte più adulta. Le ragazze che vengono sono anche talmente giovani che, voglio dire, io poteri essere, non la madre, ma la nonna. Chiedo “Lo sa tua madre?”. ”No”. Quindi, rispondendo in questo modo, in realtà, denuncia anche difficoltà nei rapporti fra genitori e figli. Generalmente non si riesce mai fra madre e figlia ad avere questi rapporti in cui la mamma veramente è la mamma, l’utero, e che quindi si ha il coraggio di dire “Sono rimasta incinta, mamma”. Quindi bisogna portarle a parlare con i genitori, se c’è il partner vedere, se si può, quindi, di ricostruire la rete familiare di base, se interrotta. Questo è un passo che viene fatto dopo, una volta che la donna dice di tenere il bambino, parte, scatta tutto l’altro intervento. Quindi, sì, ci mobilitiamo con l’aiuto economico da parte nostra e anche ci proponiamo di ricostruire la rete, laddove è possibile. Questo è il problema, e ricostruire la rete è la cosa in cui veramente il volontario deve fermare l’attenzione. Non tanto magari in questo caso, perché una volta che la mamma accetta il bambino qualche passo già è fatto, ma soprattutto negli altri casi di volontariato io dico sempre “Ma la rete? Bisogna ricostruirla”. Se un ragazzo viene fatto uscire dalla droga, e la sua rete amicale erano i tossici spacciatori e la famiglia ha chiuso la porta in faccia, se non ricostruisci una rete, la persona ricade. E lì ancora il volontario arriva poco a capire che il lavoro appena comincia, una volta che si è ben avviato il recupero. Qui, magari, una volta che c’è il bambino, la rete si ricostruisce, perché le mamme trovano poi all’asilo nido altre persone, tu le accompagni lì, poi si trovano fra di loro. Comunque la rete è fondamentale: la persona sola che non ha famiglia, non ha la casa, il padre se n’è andato…le amicizie le perdi, perché se tu sei in gravidanza hai altri problemi, non so, quelli dei casi in cui la ragazza ha diciotto anni, vuole andare in discoteca, non ci può andare perché ha il pancione. Quindi è chiaro che perdi le amicizie. Questo è un aspetto di conoscenza fondamentale. Noi creiamo la rete, perché, col buon senso, mettiamo in contatto le mamme che sono da sole, c’è anche il servizio che viene fatto alla Stock, in cui c’è questa possibilità: le mamme che hanno appena partorito o che si trovano in gravidanza e devono partorire si possono incontrare. C’è anche chi dà una mano là, ci sono psicologhe. E’ importante perché almeno queste persone costruiscono una rete fra di loro. Cerchiamo anche di coinvolgere delle mamme che hanno già risolto i loro problemi, che sono anche convinte della bontà della loro scelta, e le invitiamo a parlare.
Ø 10)
Io sono qua dal ’99, quindi, diciamo, sono una delle giovani, come esperienza, del Centro. Io normalmente mi dedico tantissimo ai vestitini, a distribuire scarpette e tutto quello che di vestiario serve alle persone. E anche questo, naturalmente, potrebbe sembrare una cosa, così, informale, come fossi una commessa della Chicco. Invece, nel momento stesso in cui ci si relaziona con queste persone, le si dà un vestitino, automaticamente si parla dei suoi figli, anche di lei come persona. Anche la signora che era qui due secondi fa ha il marito all’ospedale. Le persone che vengono raccontano dei loro problemi, parlano. Il rapporto non si esaurisce, cioè, in una maniera fredda, per dire, si fa una chiaccheratina, le do anche due bacini, perché si devono sentire anche un pochino confortate. C’è un avvicinamento in tutti i sensi. Arrivano volentieri qua da noi, arrivano sempre perché sono in difficoltà, e sono tante le donne che sono in difficoltà che vengono qui. Le difficoltà sono di tutti i tipi, non solo del gestire la loro gravidanza, proprio problemi nel gestire tutti i bimbi che hanno, le situazioni familiari che hanno. Però sempre il primo impatto è sempre stato il bisogno: si rivolgono a me perché hanno bisogno del vestitino, della scarpetta. Però se tu ti fermi a quello , sei una commessa della Chicco, quindi instauri un rapporto con loro, parli, le lasci sfogare, ascolti come va, come stanno i loro bambini, le aiuti. Se sono emozionate, tese, magari le supporti un pochino. Ci sono cere persone venute qua da noi, che non trovavano lavoro, le ho supportate a trovare per i bambini gli asili nido, o anche nel fare carte burocratiche. Nel momento in cui una persona ha bisogno di una mano, per fare carte burocratiche, perché ha difficoltà a scrivere, perché magari sono straniere - loro che scrivono in “cirillico”, quel modo un po’ particolare -, di fronte a care su carte, di cui l’Italia ne è piena, hanno bisogno di essere supportate. Anche per trovare lavoro, le ho accompagnate, per metterle in contatto con le cooperative, anche lì ho compilato tutto, le ho dato una mano, e quello impegna più di due ore, è inevitabile.
Noi siamo qui per tutta la settimana dalle dieci a mezzogiorno, ma quando si parte per aiutare una persona, nel vero senso della parola, si dà un aiuto che va oltre le due ore di disponibilità del turno. Cerco di stare vicina, di dare supporto, e qualcuna è venuta a casa mia, anche col bimbo. Cioè si diventa proprio una di famiglia.
Cerco di dare una disponibilità totale. Le persone che ho dovuto aiutare, mi telefonavano a casa all’una, alle tre di pomeriggio, di sera, dicendo “Ho problemi”, magari quando venivano sfrattate dall’appartamento o per altri problemi.
La battuta iniziale è sempre un bisogno materiale, e poi magari capita che vai a trovarle a casa loro, vedi in che stati vivono, anche in tuguri malsani, ti raccontano le loro storie, le loro vicissitudini, alla fine il tuo campo di intervento si allarga enormemente, alla fine i loro bambini ti chiamano “zia”. Capita che le ragazze giovani, che hanno le mamme magari in Serbia o in Kosovo, e vedono in me magari la mamma, hanno bisogno di qualcuno che si occupi di loro.
Per quanto riguarda il coinvolgimento personale, le dico la sincera verità, non ho assolutamente difese. Vengo coinvolta personalmente, vengo coinvolta e parto per la tangente, nel senso che qualche volta è successo che si usciva assieme alla persona e le compravo la spesa, è inevitabile. Magari io invito sempre a portare il problema qui e risolverlo qui, a parlare, e poi, in seconda battuta, entra in gioco tutto. Se quella persona vuole farsi aiutare, insomma, io so che ho fatto del mio. Il fatto di coinvolgersi, in certi casi, lo vedo anche come più produttivo. Chiaramente certe volte si prendono anche delle “stangate”, perché, insomma, la disponibilità nostra è totale e si parte spesso e volentieri – almeno per quanto mi riguarda – immaginando che tutto possa andare bene. Questa è una mai caratteristica, sono fondamentalmente un’ottimista, pur nelle situazioni difficoltose io penso che ci siano i lati positivi, e speso e volentieri ci sono anche certe persone che purtroppo che possono marciarci sopra. Cioè, non è totalmente valido quello che dicono, perché fondamentalmente ci sono certe che si trovano nel caos perché hanno delle sfortune, ma ci sono anche certe che sperano magari di approfittare. Noi partiamo sempre a spada tratta, sempre “Eccoci qua, arriviamo”, e l’altro lato, cioè il distacco, è una cosa che io, essendo nuova, dovrei già imparare un pochino, perché loro già sono più esperte.
Ci sono delle persone che sono in difficoltà, vorrebbero venirne fuori, ma è anche giusto dire “Sì, sono in difficoltà, ma non devono avere le pretesa da presidente della repubblica”. Sono in difficoltà, non sanno la lingua, non possono avere la pretesa di trovare subito lavoro da imprenditori, no? L’Italia non è, alla fine, una piccola America, anche qui ci sono difficoltà. Ci sono persone che non si accontentano, sperano subito di avere un tenore di vita più elevato. Questa è una cosa che però le mie colleghe, essendo valide e molto più anziane di me, cercano di tenere sotto controllo e tengono anche me un po’ sotto controllo. Noi gestiamo le varie situazioni, però le conosciamo tutte perché ce le raccontiamo, in modo da essere non semplicemente al corrente, ma scambiarci punti di vista, di sapere che alle spalle abbiamo un aiuto: nel momento in cui io parto troppo verso la strada della disponibilità, loro mi fermano e mi dicono “Non partire tanto, non dare subito tanto”. C’è l’esperienza la propria esperienza su cui contare, però c’è anche l’esperienza delle colleghe. Però la disponibilità totale, l’amore, secondo me – almeno per quanto mi riguarda - lo dobbiamo sentire. Questo è importante, è il punto di partenza sul quale instaurare poi un rapporto, in modo tale anche che si fidino. Si fidano di noi, senz’altro, noi dobbiamo cercare in tutte le maniere di non valutarle, di non darle un’etichetta, qualsiasi sia il tipo di difficoltà abbiamo trovato durante la loro esistenza. Questo è importante, perché lo sentono tantissimo, devono essere considerate per quello che sono. Sono già loro stesse che se si sentono valutate e che si colpevolizzano, tirando anche un po’ fuori l’angoscia, dicendo “Madonna mia, ho sbagliato tutto, avrei potuto fare meglio”, eccetera. Ma non deve venire fuori un giudizio da parte nostra.
Per quanto mi riguarda io non mi sento né tanto brava, né tanto in gamba, né tanto valida…Cioè il fatto di essere stata un po’ più fortunata, per il fatto anche di vivere in condizioni migliori, non è che sia stato merito mio, ecco. Cristianamente parlando “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”, per cui..Qua ci sono casi di condizioni familiari pazzesche, però non è nel mio compito di dire a una persona “Hai sbagliato questo, fai questo, fai questo, fai quest’altro”. E’una questione di rispetto della persona.
Io, di solito, cerco di trasmettere il mio ottimismo alle persone. Cerco di creare un aggancio in questo senso con le persone, perché sostanzialmente in questa terra siamo tutti un po’ soli, quindi non è solo il caso di queste creature che magari hanno delle difficoltà. Anche io sono sola, per mio. Ho tre figli, ho tutto quanto, però tutti quanti noi abbiamo dei momenti in cui siamo soli. Quindi cerco di sostenerle, no? Nel momento in cui sono più giù di morale, un sorriso a volte non costa proprio niente, no? Non è solo una questione solo di parole. Entra in gioco l’umanità. Un sorriso, un bacino, una carezza. L’avvicinamento è anche fisico per dimostrare la disponibilità. Io dico la verità cerco di essere molto affettuosa, dico “Amore mio, dimmi”. Una signora che è venuta adesso “Povera cara, quali sono i problemi”, mi ha mostrato delle carte che doveva portare per il marito all’ospedale. L’ho accarezzata, una carezza sulla testolina, insomma, perché spesso e volentieri magari noto che non sono abituate a queste manifestazioni, anche perché vengono da storie anche abbastanza disastrate. Credo che la comunicazione e una carezza sono delle cose che non costano niente e danno a chi le riceve. Per cui sia loro, ma anche i loro figli, quando vengono qua, vengono coccolati, vengono presi in braccio, loro stesse vengono abbracciate, accarezzate, un bacino, dire “Amore mio, come va?”, una buona parola. Vedo che sono quasi meravigliate. Ne ho avuto proprio un’esperienza questa mattina, per cui mi ricordo, ho abbracciato una persona, qui, e ho visto si irrigidiva, come non fosse abituata al contatto fisico, o le sembrasse troppo. Dopo si è rilassata, è stata contenta, magari, a volte, appoggiano la testa sulla spalla. Però l’impatto magari è di paura, arretrano. A volte io penso che anche quando vengono qua a chiedere i vestiti, eccetera, si sentano un pochino a disagio, perché chiedere non è mai semplice. E un’altra cosa che cerco di fare: di non fare sentire che stanno chiedendo, ma di farle sentire che è naturale il fatto che hanno bisogno di vestitini o di altre cose per i loro bambini, e quindi devono chiedere così, in serenità di spirito, senza impaccio. Per questo mi riprendono le mie colleghe, perché do sempre troppa roba, mi dicono “Basta, basta”, perché faccio i completini alla fine, no? Faccio completino con le gonnelline, le mogliettine, per dargli qualcosa di bello, no? Fossi una mamma vorrei anche io così per il bambino, mi immedesimo. Questo è il mio compito primario, di gestire il guardaroba, però poi si allarga. Ho anche accompagnato una persona al nido. Si può tranquillamente parlare di rapporto di amicizia che si viene a creare. Una mamma, per esempio, ci ha invitato al battesimo della sua bimba, ci portano anche le bomboniere.
Ø 11)
Io sapevo che veniva quindi mi sono portata queste carte, che possono esserle utili. Le ho portato questi fogli, che scrisse come spunti di riflessione la signora Magris. Ogni tanto, quando sono in crisi, me li rileggo, guardi, provi a leggere queste prime parole.
“La ricchezza di ogni volontariato, e quindi anche del CAV, risiede nelle doti umane e personali di fantasia, carisma, disponibilità, generosità ecc. dei propri collaboratori. La libertà di dare il meglio di sé, senza rigidi protocolli, è ciò che distingue un volontario da un burocrate”.
Qui c’è veramente tutto quello che può essere utile, mi sono sottolineata alcune parti. E’ un sostegno, in particolare qualche volta quando abbiamo casi difficili. Io seguo casi da quasi quindici anni. E’ sempre bene chiarire l’inizio e la fine dei nostri interventi:
“Dire di no è sempre difficile, perciò è utile poter gettare la responsabilità di un eventuale rifiuto sulla famosa “giunta” – che noi facciamo qua – con cui in effetti ci si deve consultare”.
Ognuno lavora come meglio crede, anche in base alla propria personalità, appunto. Guardi io le parlerei non entrando nei particolari, perché la riservatezza è una cosa basilare nel Centro.
Il primo caso che ho avuto qui nel 1986, il primo anno, lo sto seguendo ancora oggi. La persona si è ripresa, adesso. Era venuta da me, eravamo in via dell’Istria, e questa giovanissima ragazza, aveva diciotto, diciannove anni, tutta in lacrime, aveva passato la notte su una panchina a S.Giusto. Era incinta, aspettava un bambino. Aveva dei grossi problemi, una mamma con cui non andava d’accordo, il papà faceva il calzolaio ed era un alcolizzato. Già la famiglia di base presentava difficoltà, ed è così quasi sempre, quasi sempre è così, perché le persone che vengono per essere aiutate nel periodo della gravidanza, sono persone che non ingranano mai, hanno sempre bisogno di essere seguite, aiutate, in ogni momento. Io faccio una telefonata ogni tanto, per sapere come stanno, come si gestiscono, se hanno problemi. Come l’ultimo caso, guardi, abbiamo fatto questa relazione, legga pure.
“Presentiamo la grave situazione di *** che abbiamo conosciuto nel 1987. Vive con due dei suoi tre figli e in attesa di un bambino, che nascerà a fine anno. Il padre del nascituro è un extracomunitario irregolare e non è in grado di darle un appoggio. Priva di fissa dimora è ospite presso una coppia di amici, in un appartamento di piccole dimensioni del tutto inadatto ad accogliere cinque persone di cui una incinta”.
Guardi, siamo arrivate - io conosco in provincia il capo delle manutenzioni e cose del genere -, ci siamo allertate con il nostro fornitore di appartamenti a cui ci rivolgiamo molto spesso. Io dico sempre “Una volta o l’altra ci butta fuori dalla finestra!”. Insomma le abbiamo procurato questo appartamentino e quando siamo entrate, guardi, a me è venuto male: piccolissimo. Guardi il bagnetto era talmente piccolo che una persona doveva stare mezza fuori e mezza dentro. Tutto scrostato, anche i mobili. Insomma, ci siamo date da fare, è venuta questa persona con una squadra di suoi operai, ha messo tutto a posto. Mi sono impegnata io e un’altra signora. Tra noi, tra me, tra questa signora abbiamo messo a posto anche i mobili. L’assistente sociale ce l’ha messa tutta, ha dato un assegno, io sono andata dove vendono mobili rifatti. E venuto un piccolo gioiellino, però non funziona lo stesso. Ha tre figli, di cui uno è considerato un genio, l’abbiamo iscritto noi a scuola, gli abbiamo pagato le tasse. Abbiamo ricevuto una telefonata da questo ragazzo: piange perché ha difficoltà a rapportarsi con ragazzi di buona famiglia…non ha niente. Ci siamo date da fare noi qui, in maniera che non si trovasse a disagio, ma se non c’è un nucleo familiare… Sono in quattro figli, di cui uno è stato già portato via dall’assistente sociale. Quindi se non c’è una persona che non porta un sostegno, come fa a vivere? Lei comincia le frequentazioni nei bar…Questo extracomunitario io sola l’ho visto, non si è presentato dall’assistente sociale, ha paura no? E’ senza permesso. Si sono sposati, però. Insomma, questi sono i due casi che da anni e anni seguivo, ma…ma. Si è fatto tanto per queste persone, ma…Questa ultima persona ha lavorato per un periodo, ma tra una gravidanza e l’altra. Se uno non comincia dal principio a darsi da fare, a lavorare, se comunica a girare per i bar, nel pomeriggio, così, a non far da mangiare ai bambini. E questi sono così, in linea di massima, i casi. Ci capitano persone che hanno diversi problemi, persone che hanno una famiglia o che si trovano una gravidanza fuori dall’ambito familiare.
Si creano rapporti con queste persone di fiducia, di amicizia. Sono per carattere così, mi piacciono le persone, mi affeziono. E’ importante nell’accoglienza dimostrarsi proprio disponibili, io di solito mi alzo, vado incontro, a fine colloquio mi abbracciano loro. Una dimostrazione di affetto, di vicinanza. Quando sono giovani e si trovano improvvisamente il problema di una gravidanza, ma lo sa in che difficoltà si trovano? Da un momento all’altro, dall’oggi al domani. Alla mia età non c’erano questi problemi, come la canzone di Baglioni, no? “Non sapevo cosa dire, non sapevo cosa fare!”. Io frequentavo le scuole, venivano ad accompagnarmi, ma tutt’al più qualche pallonata di neve! Adesso le cose sono cambiate, con tutti i problemi che ne derivano e di cui noi vediamo le sofferenze e le difficoltà che comportano. Tanti, tanti casi, mamma mia, ho quattro agende zeppe, zeppe, zeppe. Ogni tanto me le rileggo e dico “Insomma…”.
C’è un coinvolgimento personale, così…Una ragazza che ho seguito per tanto tempo, per Natale mi telefona e mi dice “Guardi, ho un unico gettone, non so se telefonare a mia mamma, ma ho preferito telefonare a lei”. Mi ha fatto un piacere, ma un piacere. La sua mamma purtroppo non accettava questo figlio, che è nato già con un uomo anziano, che aveva lasciato la famiglia e le figlie, che erano più adulte di lei. Beveva, certo che beveva. Sa, una persona beve anche per dimenticare quella situazione, ma la ragazza che si è trovata in questa situazione, eppure l’ha sopportato fino all’ultimo.
Bisogna dare sostegno a queste persone. Sì…io ne ho passate veramente di queste situazioni. Ci si affeziona, però, a queste persone. Ma le dico, anche straniere, anche di Santo Domingo, vengono qua con la speranza di sposarsi, anche si sposano, ma quando la persona capisce che volevano solo la cittadinanza si capisce che cominciano i guai. Insomma di tutto di più.
Guardi se non dovessi lasciarmi coinvolgere smetterei di fare questo lavoro. Capire le persona, l’empatia…insomma, devo capire cosa sta passando questa ragazza, per cercare di aiutarla meglio. Non si va mai nei particolari, non chiedo mai né perché, né per come. Quello che raccontano..lascio parlare loro, si sfogano proprio. Un caso che mi aveva colpita, non faccio nomi, era una persona giovanissima, una ragazza, studentessa, di sedici anni. La mamma aveva avuto un aborto pochi mesi prima, lei è rimasta incinta, ha dovuto lasciare lo studio, è venuta qua con la mamma. Il papà di lei, il marito della mamma, insomma, ha preteso che la mamma, a suo tempo, abortisse. Può immaginarsi come mi sono trovata a seguire questo caso: se il papà non ha accettato che sua moglie…figurarsi la ragazzina. C’è una ragazza, una studentessa in legge, abbiamo gestito assieme questo caso, lei è stata bravissima. Non so cosa le abbia detto. La mamma era gelosa “Perché a te sì e io non ho potuto”. Questa ragazza, non so, è stata due ore con lei, non so cosa le abbia detto. Comunque ha deciso di tenere questa bambina, è felice, è contenta, anche a questa abbiamo procurato l’abitazione, l’alloggio. Quando c’è stato il battesimo – ci hanno invitate – lei dovesse vedere il papà, il nonno: la dolcezza che aveva nel tenere questo bambino. Mi sono commossa a vedere l’affetto…E la mamma sempre gelosa della figlia. Quante volte veniva dicendo “Ho fatto baruffa con mia mamma” e io le dicevo “Hai fatto colazione?”. “No”. Allora andavo in bar, le portavo la colazione, era felice di star qua.
C’è un rapporto che va oltre il dialogo, e si costruisce di tante cose. Ci invitano ai battesimi, matrimoni…una festa, guardi!
C’è un’altra ragazza che ha una situazione terribile, ha una creatura bellissima. Qui al CAV ci portano delle cose, mi hanno portato una tutina...mai vista una cosa del genere. Immediatamente ho detto a questa ragazza “Vieni qua”, perché gliela dovevo dare. Gliel’ho data pensando al battesimo. Lei mi ha detto “Non ho nessuno che mi tiene il bambino per il battesimo: mia mamma no…”. “Guarda - le ho detto – io ho una certa età, so che i santoli se c’è un problema devono seguire, è una responsabilità. Io adoravo la mia santola. Se proprio non hai una persona, un’amica, verrò comunque, ma se trovi una persona più giovane, che il bambino possa anche dire “Questa è mia santola”!”. Lei mi ha detto “Sì, ho capito questo, ma penso che verrà lei”. In questo senso io dico che si riceve tanto, tanto, tanto. Mi do da fare, sa. Tra poco smetterò, vengono su ragazze giovani, sono brave, bisogna che facciamo la loro esperienza, questo lo devono fare, perché non è dire “Buon giorno”, “Buona sera”…
Le racconto questa. Lei era più giovane, lui aveva un quindici anni più di lei. Era una relazione di una decina d’anni, abitavano in una villa. Lei è rimasta incinta e voleva abortire, è venuto lui, piangendo, qua “Guardi, signora, questo per me sarebbe l’ultimo treno, io le voglio bene. Capisco, lei dice che sono tirchio, che insomma non le faccio fare una vita…non la porto in gita, non la porto in ferie”. E io “Cosa vuole che le dica, sia meno tirchio, no?”…”Ma non lo vuole, non lo vuole tenere questo bambino perché dice –Un figlio da te non lo voglio - “. Anche con questa mia collega, quella volta, adesso non è più con noi, abbiamo fatto in qualunque modo per avere un colloquio con lei, visto e considerato che lei aveva un rapporto anche di lunga durata con lui. I genitori erano felicissimi, contentissimi, lei veniva da una famiglia benestante. Lei si è impuntata, era decisa che non lo voleva. Io non sono riuscita a parlarle. Quella mia amica, che era più giovane di me, ha scavalcato il muro ed è andata a parlarle. Ha detto “Non ho mai visto una persona più determinata: - No, no, no -”. Arriva il certificato per l’aborto, e lui una sera mi chiama a casa, perché io do la disponibilità anche a casa. E mi dice “Può farmi un po’ di compagnia, io passo una notte terribile...come posso fare? E’ mezzanotte, domani mattina alle sette ha l’aborto...”. Insomma due ore, povero, due ore terribili, lui ha pianto, finché ha detto “Ormai è fatta”. Di fronte a queste persone così determinate non si può far niente, e non è assolutamente un mio diritto, perché è il fatto di una decisione personale, che deve essere presa in libertà. Questa mia collega ha detto “Gli lasci il bambino, che lo tenga lui”. E niente, “Da lui non lo voglio”, ma dopo dieci quindici anni di rapporto. Ci sono queste cose che non si riesce a capire, insomma…lui ha promesso che le farà fare viaggi, che metterà tutti i suoi beni a sua disposizione. Non c’è stato più niente da fare. Ma di cose qualche volta così, che non stanno né in cielo né in terra. C’è diversità di valori, ma non si può far trasparire, o almeno fino ad un certo punto, per convincere la persona.
C’è una persona che proprio io adesso ho seguito per ultima. E’ una persona difficilissima, guardi. E’ che voglio bene a questi suoi bambini. Non so, ne ha tre, con questo è il quarto…Il fatto è che noi non possiamo agire dicendo “Se abortisci, mi te sparo!”, e, insomma…Bisogna costruire un percorso. Già l’ambiente, penso che predisponga, qui, è pieno di giocattoli, fa pensare ai bambini che verranno.. Ma se uno vuole abortire…Non le do l’indirizzo, ma, insomma, c’è una legge. Non si può obbligare, è una scelta. Se uno viene qua, vuol dire che c’è un problema. Se il problema è economico, son felice e contenta, perché tutto si può fare. Ma quando hanno problemi diversi, relazionali...a volte non sanno neanche chi è il papà.
E un bambino impegna tutta la vita. Una cosa le dirò, guardi, io ho lottato molto così per far capire, ma non ho mai sentito una mamma che dice “Son pentita di avere il bambino”. C’ era una signora che aspettava un bambino, si è trovata tutti quanti contro. Lei ha detto “Io voglio questa bambina, la voglio”. Io penso sempre questo, basta un bambino nasca, poi fa tutto da solo, con la sua presenza.
Io vengo volentieri, lavoro volentieri e le persone le seguo, non mi pesa, se mi chiamano al telefono magari, son contenta. Le persone che vengono dimostrano un conflitto interiore. Quando vengono all’incontro, per la prima volta, hanno tanto bisogno. E bisogna rendersi conto del momento terribile che sta vivendo. Quando facciamo il test, sto male io. E quando è positivo? Io le mando sempre a fare un esame ematico, l’esame del sangue, per essere veramente certi. Io dico sempre “Magari non fosse vero”, in alcuni casi.
Nonostante le difficoltà sono qui, certo. Ci sono dei momenti in cui, insomma, beviamo il caffè, chiacchieriamo fra noi volontarie, però ci pesa che non viene nessuno, anche per parlare, insomma è sempre un modo per dare aiuto.
Si creano dei rapporti molto belli, arricchenti anche per me. Anche se delle volte fanno arrabbiare. Ci sono sempre quelle tre, quattro, cinque persone che però non riescono a ingranare. Si ascolta, si sta vicino, ma dopo bisogna insegnare a camminare con le proprie gambe, ed è giusto. Io sempre penso: la chiave è la famiglia. Se insegna certi valori…adesso rischia di essere uno stile di vita poco relazionale, non c’è da dire “Ti porto in giardino”, non c’è l’idea di giocare con il bambino, di aiutarlo a giocare nella maniera giusta. Li si lascia spesso a guardare da soli la televisione.
E’ importante soprattutto l’ascolto con le persone. Nel primo incontro, non parlo, ma lascio parlare, perché sono un fiume in piena. Vogliono parlare. Io sto attenta. Le parlo di quarant’anni fa che avevo dei problemi e sono andata da uno psicologo. Io ero avvilita, e parlavo. Ero là, così, con i gomiti appoggiati sul tavolo e le mani davanti alla testa, alzo lo sguardo, e lui dormiva. Si era addormentato. Ho messo cinquantamila sul tavolo, mi sono alzata. Quando ero davanti alla porta si è svegliato. Io “Tranquillo, vada avanti”. Io capisco, sarà un colpo di sonno. E dopo, un’altra volta, una cosa che mi ha molto irritata. Era un professore. Quando mi sono seduta, ha messo l’orologio davanti al tavolo. Ho un problema da esporre, e la risposta dovrebbe essere la disponibilità, e tu mi metti l’orologio?…Se è una persona intelligente, mette l’orologio sul muro, così ogni tanto butta l’occhio là. Ma proprio lì davanti, come per dire “Fino a quell’ora, dopo basta”. Quasi far capire alla persona di sbrigarsi, mettendomi fretta. Quindi avendo vissuto anche dall’altra parte cerco di fare in modo di agire diversamente. Quando sono andati via gli Americani hanno aperto anche i campi profughi, io quella volta ero in attesa di sposarmi. Insomma li ho girati, ho visto la sofferenza veramente. Di notte, girare, ti chiamavano, l’unico punto di riferimento eravamo noi. Però, una cosa posso dirle, mai nessuno mi aveva fatto un dispetto. Anche quella volta là eravamo rispettate. Adesso succedono certi fatti…
Si impara a relazionarsi con le persone col tempo e con la pazienza, la passione. Bisogna ricordarsi sempre nel trattare le persone che– anche se povere, anche e soprattutto se con passati difficili - sempre persone sono, in qualunque situazione. Poi giudicare a che cosa serve? Siamo di fronte ad un fatto compiuto, se possiamo aiutarli in qualcosa, in qualunque maniera lo facciamo. Relazionarsi con le persone con tutta la sofferenza che comporta è comunque impagabile. Tutte siamo molto appassionate, diamo la piena disponibilità. L’importante è proprio l’impatto, il primo incontro in cui ci si vede.
Una volta, sono andata in un negozio “Vorrei questo”. E la commessa mi dice “Per lei?!”. “Sì”.. Con un’espressione mi dice “No! Signora, ma non abbiamo, per lei!”. Mi sono sentita un po’ così, poi le ho detto ”Mi scusi, da quando fa questo lavoro?”. E lei è rimasta, ha risposto “Da qualche anno”. “E ancora la tengono?”. Anche una commessa deve saper fare, perché comunque ha a che fare con le persone. Se fossi stata io avrei detto “Signora, questi pezzi sono richiestissimi. Ho venduto l’ultimo pezzo adesso, ripassi fra un paio di settimane”. E questa va via contenta. In tutti i lavori in tutti i mestieri bisogna saper fare, avere “educazione”.
Ø 12)
Devo premettere che io sono in questo centro da poco, da poco mi occupo di questo ambito. Sono arrivata qui nel ’98. Anche se sono già circa quattro anni, comunque sto ancora imparando dalle mie colleghe, soprattutto perché venendo solo una volta alla settimana mi sento ancora inesperta. Bisogna pensare di avere sempre da imparare, anche perché do la mia disponibilità, ma non sempre mi è possibile venire in tutti i periodi con costanza, lo faccio anche in base ai miei impegni. Quindi posso parlare sulla base di queste esperienze che ho avuto, tenendo conto del fatto che penso di avere ancora molto da imparare.
Sicuramente relazionandosi con le persone bisogna avere tanta pazienza e saper ascoltare. E’ importante l’ascolto, perché ritengo sia il punto da cui partire per capire di che cosa hanno bisogno e quali sono i loro bisogni reali, che magari non subito svelano. Molte volte le persone vengono qui semplicemente per parlare, anche senza chiedere niente altro, anche persone che non hanno problemi economici, quindi non chiedono aiuti materiali, soldi o vestiti per i bambini. Mi è capitato, per esempio, il caso di una signora che è venuta a parlare con me, dicendomi “Non mi serve niente, ho solo bisogno di parlare dieci minuti, mi lasci sfogare”. In quel caso è importante chiaramente dimostrare disponibilità, si crea un rapporto di simpatia, ma è anche molto importante stare attenti alla dinamica simpatia-antipatia, perché le ragazze che vengono devono potersi trovare bene con la persona con cui parlano. Le difficoltà più grandi da gestire sono quelle a livello relazionale, in cui è fondamentale trovare le parole giuste al momento giusto, perché altrimenti può rischiare di capitare vadano via scontente.
Io sono venuta qui a fare i corsi senza sapere che cosa poi avrei dovuto fare. Sono quei momenti in cui capita una svolta nella vita, che porta a voler fare qualcosa di diverso, a cambiare strada. Inizialmente avevo una certa perplessità iniziale, mentre adesso non andrei più via. Si creano dei bellissimi rapporti con le persone che vengono, ma anche fra noi volontarie c’è un rapporto di collaborazione e non di rivalità: c’è sempre il supporto di tutte e la possibilità di confrontarsi, per cui laddove non arriva una, può arrivare l’altra.
Ø 13)
Quando vengono le persone per i colloqui è un momento difficile, diciamo. Cerchiamo di aiutare. Poi dipende, se viene una ragazza giovane o una persona già più matura, l’approccio cambia. Si cerca chiaramente di ascoltare tanto, senza fare tante domande, ma ascoltare e basta, non tanto non dire il nostro parere, ma non giudicare, perché dobbiamo sempre metterci dalla parte di chi parla, immedesimarsi nella sua parte: quello che magari per noi è logico, per questa persona non è logico, perché noi vediamo dal di fuori, riusciamo a valutare le situazioni, a essere più obiettive, invece la persona viene qua anche disperata, si presenta con problemi. Se sono giovani hanno problemi di tutto, proprio. Ad una certa età, magari, hanno soprattutto bisogno relazionale, ma non è raro sia anche economico. Tante persone che riescono ad accettare il bambino vengono seguite da noi anche diverso tempo fino al momento in cui, insomma, riescono anche ad inserirsi, a superare il momento brutto.
Noi, certe volte, sentiamo che vorremmo dare di più di quello che magari si può dare. E’ difficile. Noi logicamente consigliamo sempre di tenere il bambino, in qualsiasi caso, anche se la persona ha problemi che le fanno vedere la situazione sotto un ottica negativa. Però, dopo dipende dal partner, dalla famiglia,dagli amici che sono vicino a questa signora, non ci siamo solo noi, che magari le sosteniamo, mentre non riesce a mettersi d’accordo con il suo compagno. Invece, altre volte, ci sono successi dei casi in cui l’uomo lo voleva a tutti costi, però lei non l’ha voluto, e noi, in effetti, non siamo riuscite a far niente per il bambino. Ed era anche in età. Tante volte se è in età il problema, però, è il lavoro. Essendo, secondo me, abituate a un certo stile di vita, non vogliono rinunciare, perché credono si creino dei disturbi, se arrivasse un bambino. Questi casi sono anche più pericolosi che quelli dei giovani, perché due giovani magari se sono d’accordo, hanno entusiasmo. Certo, non è facile, però superano questo momento, invece una persone d’età più matura pensa troppo a certe cose, non vuole cambiare il suo stile di vita. Non sempre è vero questo, perché abbiamo, invece, tanti casi in cui siamo riusciti ad andare avanti, mamma mia.
Cerchiamo soprattutto di ascoltare. Fondamentale è l’ascolto. Cerchiamo di metterci nei suoi panni e cerchiamo di dare un’alternativa a tutti i suoi problemi. Se è possibile chiediamo di parlare con il suo partner, è questo è un passo molto utile. Già, quando vengono qui, è un segno che sono titubanti, allora dobbiamo aiutare per far superare le preoccupazioni che portano verso la non accettazione e sviluppare, invece, quei pensieri di accettazione. In genere i futuri genitori non sono tutti due d’accordo. Se vengono, però, qui c’è speranza, cerchiamo di trovare questa piccola “scappatoia”, un punto d’incontro, che li porti verso il convincimento.
Ci sono delle parole, ma anche dei gesti che devono portarci a dimostrare disponibilità. Bisogna dimostrarsi disponibili, dare possibilmente anche il numero di telefono, impostare un’amicizia. E anche tante volte – ci sono anche persone disperate –un abbraccio aiuta molto. Loro devono sentire che da noi hanno anche affetto, e che il rapporto non è dolo una profilassi che noi seguiamo. Noi siamo dei volontari, perciò dobbiamo dimostrare che noi vogliamo col cuore questo, no? Cioè noi lo facciamo gratuitamente, lo facciamo per passione, per aiutare, e questa deve essere una ragione in più perché loro si fidino di noi. Per impostare un rapporto verso la disponibilità reciproca dobbiamo cercare di fare il massimo, anche abbracciandole, anche mantenendo fuori di qua un piccolo rapporto col telefono. In questo modo capiscono di avere una persona su cui fare affidamento.
C’è anche coinvolgimento personale che certe volte non è nemmeno facile da gestire, perché ci troviamo vari problemi forse un po’ troppo grandi, così come sembrano nell’impatto. Dopo magari cerchiamo di dire “Un problema alla volta”. Io dico sempre questo “Adesso abbiamo questo da risolvere, poi uno alla volta li risolveremo tutti”. Perché, in effetti, è vero così, passo passo. Bisogna farlo capire anche alla donna che chiede aiuto, perché abbia ancora speranza, per tirarla su. Poi noi le diciamo “Senta, deve sapere che nessuna qui è mai venuta a lamentarsi perché ha tenuto il bambino”. Però, in realtà, ci sono tanti casi di persone che dimostrano, al contrario, subito disinteresse, magari vengono qui per fare il test solo perché non costa, ma dentro di loro hanno già la loro idea e non creano rapporto con noi, per discuterne assieme: hanno già deciso. Purtroppo anche questo succede. Con queste persone è molto difficile perché loro nella loro testa hanno già deciso cosa fare, a loro non interessa l’aiuto. Comunque è sempre la donna che decide, perché è lei che porta avanti la gravidanza, anche se non è giusto così.
Si viene a contatto anche con situazioni coniugali che non sono corrette, in questo senso intendo che ci deve essere un non giudizio. Non giudicarle sicuramente, cercare di mostrarle tutto quello che possiamo fare: è un modo per trovare la fiducia e creare un rapporto anche di amicizia, per far capire che non sono sole. Noi siamo in turno qui ogni giorno, consigliamo di tornare. Non è detto tornino per parlare con la volontaria con cui hanno avuto il primo colloquio, possono anche cambiare, perché non è detto che si trovino subito, dipende anche dal carattere di entrambe. Almeno inizialmente, si cerca di fare in modo la donna sia seguita sempre dalla stessa persona, anche perché raccontano cose, fatti che non si possono raccontare a chiunque, perciò possono fare difficoltà a ripeterli. Se non si dimostrasse sensibilità, in questo senso, ci sarebbe già una “perdita” per noi, no? Per non aver creato le condizioni adatte per farla stare bene, a suo agio, ed essere la causa dell’allontanamento. Dopo, si cerca di trovarsi al di fuori di qua, di tenersi in contatto, di mantenere un orario flessibile per venire in contro, soprattutto all’inizio, fino a quando la donna esclude la possibilità di fare l’aborto, no? In quei momenti dobbiamo essere convincenti, non dico dobbiamo pressare, perché la scelta deve essere solo sua.
Ci sono tante dimostrazioni di vicinanza. Il problema principale di solito sono i soldi e la casa, però ci sono anche problemi veramente di affetti, potremmo dire. Tante volte ci sono anche le madri che intervengono nella scelta, perché non vogliono la vita delle loro figlie sia rovinata, e allora questo diventa un poco più difficile, perché ci sono tante mamme, in questo modo, però, non aiutano. Non tutte, per l’amore del cielo, però ci sono anche stati dei casi così. Di fronte a fatti estremi, in cui sono coinvolte delle variabili riguardanti il “contesto” dove è immersa la persona, non possiamo fare più di tanto, non è tutta nostra la responsabilità, però in quel momento ci si sente lo stesso responsabili: siamo di fronte a una persona che comunque conta su noi e viene a chiedere il nostro aiuto.
Sono anche più i benestanti che abortiscono, hanno già deciso la loro strada, hanno già deciso le loro cose, sono le più determinate, allora è difficile. E’ difficile, certe volte ci si dice “Mamma mai cosa faccio”, no? Intanto ti immedesimi, perché potresti essere sua mamma e vedi queste ragazzine, anche di sedici, diciassette anni, minorenni. Ci sono problemi nell’operare, anche se noi comunque ci consultiamo, non è che risolviamo da sole. Il colloquio viene fatto da una sola volontaria, ma dopo si parla tra noi, si cerca di discutere: è importante, perché così la responsabilità di fronte a queste persone non è di una sola.
Dirò che quando sono giovani speri proprio che il test sia negativo, perché hanno una vita davanti, è quasi sicuro che non ce la faranno. Una volta è capitato che è venuta una ragazza che desiderava essere incinta proprio per sposarsi, invece non lo era, ed era anche lei minorenne. Ci sono di quelle situazioni che a volte non so se sono giuste.
Per calmare la persona che viene qui e mostra comunque la sua disperazione cerco di parlare sempre di una cosa alla volta, questo io lo dico sempre “Cerchiamo di risolvere un problema alla volta. Lei adesso si trova a star male, però ce la faremo”. Bisogna comunque metterla di fronte alla situazione, certo non dire “Non fa niente”. Bisogna farle riflettere, comunque la vita cambia, comunque ci sono responsabilità. Bisogna maturare, ecco, io dico questo, e la maturazione avviene anche in questa maniera, affrontando – non i propri “errori”, “sbagli”, perché non è uno sbaglio – però le proprie responsabilità. Invece, se tu, di fronte a questo, ti lavi le mani, non hai più il pensiero, però dopo hai il rimorso, perché sono tante che lo hanno dimostrato, magari non subito. Ci sono, qui in Italia, anche associazioni di mamme che hanno abortito, e si sono dedicate al volontariato, per l’esperienza che hanno vissuto sulla propria pelle. In queste persone, così scottate, nascono i problemi psicologici.
Qualche volta, anche qui, vediamo persone veramente disperate. Si deve andare loro incontro, anche certe volte con un abbraccio: devono sentirti amica. Bisogna farla parlare, quando vedi che riesci a farla parlare, ecco, quello è un buon segno, perché è uno sfogo. Non tutte ce la fanno da subito. Poi bisogna in realtà stare anche attenti, perché, a volte, dicono quello che vogliono. Non è che tutte siano sincere, allora, dopo, dal confronto di noi colleghe, facciamo venire a galla le cose. Di fronte comunque ai casi più disperati, questo dico sempre: farla sfogare, e metterla comunque al corrente dei fatti. Non dirle che non ci sono problemi, ma che la vita cambia, ci saranno tanti sacrifici, però bisogna superarli. Mai nessuna che ha tenuto il bambino è venuta a dirci “Cosa mi avete fatto fare? ”. Anche questo lo diciamo, per tirare su la persona.
L’importante è farla riflettere, mettendola comunque in guardia, renderla pronta ad affrontare con responsabilità le difficoltà, e questo è un segno di maturazione. Qualche volta le persone si tirano indietro, ma non solo in questo caso, ma di fronte a tutto quello che è fatica, perché diventa un modo di vivere, di fare le cose con molta leggerezza. Le dirò, io ho un figlio che gioca a pallone, e lui mi ha raccontato che c’è un ragazzo giovane che gioca in squadra con lui, ha una piccola che neanche cammina. E così mio figlio, che le dico, ha diciotto anni, ha detto “Sono stati bravi, mamma, hanno preso le loro responsabilità”. Ecco, voglio dire, che questa riflessione a lui è venuta spontanea, l’ha vista come una cosa positiva, per una questione di responsabilità. Anche mio figlio, che è giovane, secondo me ha capito. Perché si può trovare soluzioni, questi due ragazzi hanno risolto la situazione portando la bambina dietro, lui giocava a pallone e la ragazza era lì, riuscendo lo stesso a fare le proprie cose, e questo è un segno positivo. Questo dico, anche di fronte alle ragazze che vengono qui, che è importante mettersi di fronte alle proprie responsabilità, e noi, però, dobbiamo aiutarle a risolverle. Far capire a chi viene che in noi hanno sempre un appoggio, perché noi li aiutiamo sia per l’appartamento, sia per problemi di soldi, sia per quelli relazionali. L’importante è che loro sentano di avere una persona vicino su cui fare affidamento, anche al di fuori della famiglia, perché tante volte sono più gli estranei che fanno. Allora noi dobbiamo pensare che siamo questi “estranei” che aiutano, e che loro devono trovare sicurezza e un appoggio in tutti i sensi, a tutto campo.
Ø 14)
Sono qui da sei anni, da quando sono andata in pensione, ero insegnante, per cui, appunto, ero abituata ad avere a che fare con bambini, con genitori e con persone con cui si deve aver bisogno di pazienza, comprensione, disponibilità. Arrivata in questo Centro, subito mi sono data da fare, ho fatto il corso di preparazione e mi sono sentita subito disposta ad aiutare queste persone, queste signore, queste ragazze spesso giovanissime. Il corso mi è stato utile, perché non è facile avere relazioni appunto con loro. Ci hanno insegnato che dobbiamo ascoltare soprattutto, far parlare, non giudicare e cercare di comprendere, metterci nella loro personalità e vedere come possiamo aiutarle ad affrontare questi momenti difficili, a volte difficilissimi per varie ragioni. Per cui, ecco, i primi tempi non è stato facile, perché è un atteggiamento che non si ha subito, e, a volte, ci si spaventa, anche per tutti i problemi di cui non ci si rende conto, se non si è a contatto, veramente quanto bisogno c’è di aiuto.
Per l’ aiuto...noi diamo un aiuto morale, psicologico immediato, le aiutiamo a vedere il lato positivo del problema, come risolvere i problemi e certi hanno bisogno anche di alcuni aiuti materiali, perché purtroppo in alcuni casi serve anche questo. Si è sempre disponibili. Noi facciamo i turni qua, però io, tra l’altro, sono una delle poche volontarie che tengono il trasferimento di chiamata sul nostro numero telefonico, ventiquattro ore su ventiquattro, per cui, ecco, siamo disponibili in qualunque momento. A me non è mai capitato che mi abbiano chiamato di notte, però qualche volta alle mie colleghe è successa l’emergenza, e in questi casi bisogna subito mettersi in azione, attivare tutti gli aiuti necessari, far venire qua, aprire la sede in qualunque ora, se c’è bisogno.
A me, invece, è successo di aver seguito una giovane mamma con tre figli, che poi ha avuto la quarta, era straniera. La bambina era nata in agosto e a Natale, il giorno di Natale mi ha telefonato, perché lei viveva in una comunità, era rimasta fuori di casa, faceva freddo, mi ricordo benissimo. E il giorno di Natale, il pomeriggio, sono dovuta correre e aiutarla, con questa neonata, non sapeva dove andare. Sono venuta qua, l’ho portata qua, e dopo abbiamo chiamato il responsabile ed è potuta tornare nel suo alloggio. Ecco, a volte ci si sente, come dire, a volte troppo impegnate. Però non ci si può, quando ci si impegna, quando ci si mette in questa attività, tirare indietro, anche perché, vedendo queste storie anche difficili, c’è un coinvolgimento personale. C’è, ma bisogna stare attenti a non coinvolgersi troppo, e questo, specie all’inizio, non è facile, soprattutto, appunto, quando si vede che hanno bisogno e non si sa se approfittano di noi o meno. E l’altra difficoltà è stare sulla difensiva, perché non è giusto che ci si coinvolga troppo, anche perché, dopo gli aiuti, queste persone devono proseguire da sole, essere autonome. Questo anche se noi siamo sempre disponibili, cerchiamo sempre di dare il massimo. All’inizio è un po’ più difficile conciliare questi due atteggiamenti, poi però si impara con l’esperienza, è anche quindi un percorso personale. Ecco, io sono qui da sei anni, le altre colleghe da molto di più, no? Dopo c’è sempre il caso particolare, per cui bisogna affrontare situazioni diverse e oggigiorno si sente di tutto. E’ importante l’impatto, il primo incontro, che è la base. Vengono per fare il test di gravidanza e allora sono nervosissime, specialmente se sono giovani, bisogna metterle a proprio agio. Dopo il test c’è tutto il discorso di costruire. Poi, se sono disposte a portare avanti la gravidanza, noi dobbiamo aver la capacità di far capire che noi le aiutiamo. Questa è la difficoltà. Se il test è negativo, magari sono giovani ragazze di sedici, diciassette anni, bisogna anche far capire che non si può giocare con la vita.
Qualcuno viene qui e si confida, ad altre invece bisogna proprio tirare fuori le parole, sempre con delicatezza. Loro sentono che si è disponibili. Si conquista la fiducia quando si è disponibili, sanno che non vogliamo sovrapporci a loro, che vogliamo aiutarle a decidere per il meglio. Loro sentono, l’atteggiamento si capisce. Sia per come si presenta il centro in sé, ma anche per noi: è una questione di rapporto. Io credo senz’altro che, se si è disponibili, anche con amore, amore verso di loro, si riesce a costruire il rapporto. E’ importante l’atteggiamento, è quello che conta. Infatti a noi ha aiutato molto il professor Desinan quando è venuto, perché non si ha mai finito di imparare, no? A volte si dimentica qualcosa, sopraffatti dalle esigenze materiali immediate, è importante riflettere. Difatti, facciamo ogni anno il corso di preparazione per le nuove, e noi “vecchie” assistiamo. E’ un rinforzo, anche perché si è sempre coinvolte, non dico quotidianamente, in questo lavoro, ma “mentalmente”. I primi tempi succede che ci si sveglia di notte con il pensiero, dopo bisogna rendersi conto che non è giusto neanche coinvolgere i propri familiari, bisogna proprio imparare a dividersi.
La nostra disponibilità di fronte alle persone si sente, proprio fa capire loro che noi siamo qui per aiutarle, che noi vogliamo aiutarle. Se non hanno nessuno, noi possiamo veramente essere come una mamma, e, se ci sono le giovani volontarie, come sorelle. Per cui, ecco, ci sono delle ragazze che non hanno nessuno che le sostiene in famiglia, allora si aggrappano veramente a noi, e noi le aiutiamo a vedere i problemi che loro hanno e come risolverli, soprattutto con amore, con disponibilità. Dopo le parole vengono, anche in base alla persona che ci si trova davanti, alla situazione, bisogna adattarsi in questo senso. Noi chiediamo subito qualche dato, ma non troppo, perché non si senta troppo “interrogata”, e dopo, pian piano, bisogna capire, no? Capire, capire qual è il problema, il problema che non vuol dire, che c’è sotto, di cui magari anche lei non si rende conto. Per esempio c’è il progetto Gemma: un’associazione di Milano che è collegata al Centro di Aiuto per la Vita, fornisce un assegno di trecentomila lire in casi estremi, in cui la persona ha particolari problemi finanziari, in cui questo è essenziale, per diciotto mesi. La signora che è venuta adesso ha ricevuto l’ultimo, il bambino ha compiuto un anno. Purtroppo in alcuni casi il lato finanziario è cruciale. Alcune hanno l’assegno di maternità, però molte lavoravano e ora non lavorano, molte si sono licenziate prima e non hanno alcuna indennità. Però adesso, grazie al cielo, possono avere anche aiuti dallo Stato. Per sostenerle si interviene da diversi fronti, è un modo per conquistare anche la loro fiducia, ma non è sempre essenziale, perché noi non è che con questo vogliamo dire “Sì, fai il figlio e questi sono i soldi”, lei deve capire il valore della vita, bisogna puntare su questo, il valore della maternità, della vita. Dopo, ecco, dopo ne parliamo, ma prima cominciamo a battere su questo.
Però è bello. A volte si vedono i bambini, qualcuno viene qui da noi ad aiutare per lavorare con i bambini, e invece noi vediamo le mamme. Poi, un po’ alla volta si crea un rapporto, andiamo anche a trovarli al Burlo...si resta legate. Si creano rapporti di amicizia, molte sono sole e ne hanno bisogno, sembra incredibile. A volte si riesce anche a far riallacciare i rapporti con i familiari, magari c’è la mamma che non vuole saperne, poi, piano piano, specialmente quando nasce il bambino, si riallacciamo i rapporti. Secondo me quello è anche un passo molto importante. Diciamo che lavoriamo su vari fronti. A parte le questioni materiali, per cui ci sono persone che vengono a chiedere vestiti, aiuti economici, non c’è tanto la paura di chiedere aiuto. Vengono, dimostrando bisogno, dicendo che hanno bisogno di parlare. Vengono per questo, dopo noi le rassicuriamo anche dicendo che possiamo aiutarle in tutto, allora si sentono tranquille, quindi affrontano i problemi con un coraggio diverso.
A volte bisogna farle parlare, tirare fuori la capacità di relazionarsi con noi, a volte è una disposizione spontanea, a volte no, però, pian piano, si riesce. Le si dice di tornare, tornano una seconda, una terza volta, si telefona, si dimostra loro di starle vicino, e allora dopo si aprono. Non tutte lo fanno subito al primo incontro, è importante puntare sulla costruzione del rapporto. Alla base c’è soprattutto il dialogo che costruisce le fondamenta.
Da parte nostra, se non si ha entusiasmo, non si può andare avanti. Si è in tante, ma, se alcune si allontanano per problemi personali, bisogna sempre essere disponibili per più di un turno. Di solito facciamo un turno alla settimana, ma se c’è bisogno anche di più. Mantengo nel corso delle mie esperienze di lavoro sempre l’interesse nei confronti dei bambini, io non ho avuto figli, forse per questo. Sono sempre interessata a favorire la nascita. Ci occupiamo di maternità, ma anche di educazione dei bambini: a volte facciamo anche questo, aiutiamo a fare i compiti, ma anche facciamo proprio educazione, nel senso di educare i bambini a certe regole, che le straniere non hanno. Siamo anche in contatto con i servizi sociali, cerchiamo di fare un programma assieme, cerchiamo di occuparci anche di questo, prendendoci la responsabilità non solo di far nascere il bambino: avere un bambino, infatti, non vuol dire solo farlo nascere, no? Noi seguiamo le mamme fino a quando hanno bisogno, a volte un anno, due anni, tre, a volte cinque sei, a volte anche dopo. Magari dopo loro ritornano per il figlio, difatti a volte le mie colleghe, che sono da tanti anni qua, si trovano delle ragazze che hanno seguito per la prima volta dieci, quindici anni fa, poi ritornano perché aspettano il secondo figlio. Per cui i rapporti sono anche molto stretti. Noi confessiamo che, in effetti, servono anche a noi queste relazioni, perché si aiuta gli altri, ma anche noi ci arricchiamo personalmente. E’ il volontariato che dà molto, richiede molto, è molto impegnativo, ma quando lo si fa volentieri dà molto.
Ø 15)
Normalmente le persone sono un po’ timide, sono un po’ restie a dare certe informazioni. Parlano sempre di un altro, poi normalmente quando uno parla di un altro, di un'altra, un’amica, già si sa che il problema è suo. Noi, però, rispettiamo la privacy, l’intimità che riguarda da vicino queste persone.
Io vengo dal Venezuela, sono qui da quasi un anno. Io ho cominciato il rapporto con le persone attraverso i massaggi, sono massaggiatrice professionale, e attraverso un programma che si è aperto in quel paese poco tempo fa, cioè l’assistenza alle mamme incinte, che consiste nell’insegnare loro a dedicare la propria attenzione al bambino, come far crescere mentalmente, fisicamente, spiritualmente, emotivamente un bambino ancor prima che nasca. E’ una bellissima cosa, molto bella: già la relazione non è a due persone, siamo in tre. Già è un’altra cosa, molto più grande, molto più bella. Poi, quando sono arrivata qui, mi sono trovata, per caso, davanti a questo manifesto “Fammi nascere!”. Allora io ho detto “Fammi nascere…guarda un po’, io che ne ho avuti tanti fra le mani prima che nascessero...perché no?”. Mi sono avvicinata, mi è piaciuto moltissimo e il mio modo di fare - un po’ sentimentale, un po’ psicologica, un po’ filosofica – è dettato dal fatto che con le persone mi adatto a un feedback, e la gente con me, moltissime persone, si aprono, mi raccontano quello che possono, eccetera. E io le aiuto in quello che sta alla parte psicologia mia, alla parte emozionale e spirituale soprattutto. Intervenire in questo modo io lo ritengo un vantaggio. Poi c’è l’altra parte, d’aiuto in cose fisiche, per esempio quando vengono qui delle madri che non hanno: una cosa che a me personalmente duole e alle mie colleghe anche. Duole moltissimo, perciò cerchiamo di aiutare la gente meglio che si può e con più si può.
Io ricordo una frase filosofica che dice che l’energia, se non circola, non funziona. L’aiuto è un’energia: per riceverla, bisogna darla. Un po’ filosofica, però credo che forse siamo così, a livello un po’ più profondo, di solito si è più superficiali. Rapporti così richiedono una base di questo tipo. L’aiuto agli altri è un castello che si costruisce su cose che non esistono, ma si percepiscono e che aiutano a poter aiutare gli altri. E quello credo sia la cosa più importante.
C’è entusiasmo. Personalmente, nel mio caso, io sono una persona che se faccio una cosa la faccio con amore prima di tutto, la faccio spontaneamente e di buona volontà. Se la devo fare di mal grado, sto a casa mia, mi sembra la cosa più logica. Se non c’è passione non si riesce, non si può fare niente. Se non c’è quella punta di entusiasmo, di passione, di amicizia, di filosofia anche, non si può.
Si deve gestire questa empatia, questa sensibilità, in quanto se io mi metto a piangere non ti aiuto. Se tu vieni da me piangendo, che si pianga in due, non risolviamo il problema. Il problema deve essere – come la vedo io – ben calcolato, ben concepito. Bisogna trovare subito l’immediato avvio verso la soluzione del problema, perché stare lì a piangere in due ci facciamo male sicuramente. Prima mi “impossesso” del fatto, come se fosse una cosa che stesse succedendo a me, e cerco la soluzione. In modo rapido. Perché, con il passare dei giorni, non risolvo niente. Una persona, qualsiasi persona che venga da me a chiedere aiuto, non può aspettare una settimana, dieci giorni, quindici giorni. Questo non è un consultorio medico, dove fare la fila. Se uno deve aprire il cuore lo deve fare subito, non fra quindici giorni, ma in modo immediato, per generare un rapporto, una certa confidenza tra una persona e l’altra, parlare come vecchi amici, senza voler mantenere tutto in segreto, perché se no allora io non posso aiutare, se io non so qual è la radice. Qualsiasi problema ha una radice, è da lì che parte, è come una pianta, cresce da un seme. Se non riusciamo a vedere in che terra è andato a crescere il seme, dove vanno a finire le radici, non possiamo far niente con questa pianta. Bisogna lavorare un po’ alla volta fino ad arrivare al punto, che è base e proprio punto di partenza del problema.
C’è un “fasi forza” per aiutare le persona, non farsi prendere troppo dall’emotività, anche se tutte abbiamo un po’ di emotività, è umano, altrimenti non risolveremmo assolutamente niente. Prendendo il problema in questo modo “Se capitasse a me, che cosa farei?”, automaticamente io do la risposta, il mio punto di vista, nel modo più obiettivo possibile. Nel caso in cui la persona dimostri incertezza, allora cerchiamo di vedere, fra le varianti, la risposta. E’ un lavoro molto impegnativo, però piacevolissimo, glielo dico di tutto cuore, piacevolissimo per chi ha imparato dalla vita. Se non si impara, se non si ha, non si dà. L’incontro con le persone arricchisce moltissimo, perché ci rendiamo conto che, pur essendo tutti diversi, siamo tutti uguali. I problemi che loro hanno avuto, i problemi che possiamo risolvere - mi sono resa conto nel corso degli anni - che li ho risolti per conto mio, che li ho avuti anch’io: non sono unica nel pianeta, anche se “mi sento unica”. Non solo le difficoltà che si sono superate aiutano, quanto gli obiettivi che si siano raggiunti. E’ come quello che va a scalare l’Everest: se non vai preparato, non arrivi. Appunto, la vita è come scalare una montagna. Se voglio arrivare alla punta dell’Everest, tutto si fa a tappe, non si fa in un solo giorno, tutto si fa a tappe, devi preparati prima, risolvere i tuoi problemi che trovi sulla strada per arrivare al punto. Quando se in cima puoi ringraziare il Signore di essere arrivato, di avercela fatta, poi ridiscendi a valle e ricominci con un’altra vetta. Se uno si propone le cose, le fa.
La fiducia sta alla base, come se si va dal medico o dall’avvocato: uno deve avere fiducia nel medico e nell’avvocato, se no non sta sbagliando strada. La fiducia è una questione che va oltre le parole, riguarda il come la persona si pone. Non mi pongo mai, generalmente, questa domanda, se ci sia fiducia in un rapporto: semplicemente, se una persona torna, vuol dire che qualcosa ha funzionato.
Gestisco il dialogo facendo più o meno quello che fa lei: ascolto. Prendo nota mentalmente di quello che succede, prendo nota psicologicamente di quello che sente, delle sue difficoltà. Le persone, generalmente, tutti noi, siamo dei gomitoli ingarbugliati, non troviamo mai il bandolo della matassa, allora ci perdiamo. Cadiamo in lacrime, molte volte, nella disperazione, nella depressione, eccetera. Praticamente le mie colleghe ed io, siamo qua come “confessori”. Ascoltiamo, non giudichiamo, cerchiamo la soluzione, fisica, mentale, spirituale, affettiva, soldi, aiuti, eccetera. Perché questo è il nostro lavoro, appunto, dare un aiuto. Perché la gente non solamente ha bisogno dell’aiuto monetario, che si può toccare, che si può sentire. Molte volte, moltissime volte, la gente ha bisogno di un aiuto interno, e quello è importante, è molto importante, perché se sono rinchiusi in una stanza buia, e non sanno su quale parete, o che su una parete, c’è una finestra o una porta aperta, mai usciranno. Però, se sei in una stanza chiusa, in qualche modo ci sei entrato, o da una porta o da una finestra. Cerca e trova la via d’uscita. Questo è come la penso io. Noi, in questo senso, aiutiamo a trovarla.
C’è anche il lavoro psicologico con la gente, la gente cerca aiuto perché non sa come sbrogliare la matassa, però se siamo totalmente incapaci di poter dare prima di tutto l’aiuto psicologico, non ce la facciamo. Si crea una certa profondità del rapporto, si potrebbe dire un leggere fra le righe, ossia capire quello che la persona non dice. Infatti, moltissime volte le mie compagne e anch’io, quando parliamo con una persona, facciamo una domanda, e già sappiamo che abbiamo colto nel segno, allora la persona comprende il suo stato d’animo, quello che l’ha fatta introdurre nella stanza, ma non la fa uscire, e automaticamente si apre: si comprende lei stessa, in questo consiste l’aiuto. Se accadono queste premesse, le cose sono molto più facili.
Io non posso sapere quello che sentono le mie colleghe, però penso che tutte abbiamo gli stessi sentimenti, le stesse percezioni. Dobbiamo per forza andare più in là delle parole e questo è il fatto in sé dell’aiuto. I rapporti, ho visto qui con le mie colleghe, si mantengono per anni e anni. La gente gradisce molto l’aiuto, viene, ritorna, fa vedere i bambini che hanno avuto, si forma una certa familiarità, una grande famiglia. Infatti credo che siamo un po’ una grande famiglia. Vengono le mamme, ci fanno vedere i bambini, noi le invitiamo alla festa di Natale. Si forma proprio una grande famiglia, quello è molto importante, anche perché così sanno che non sono sole, e che possono aiutare e portarci altre persone che hanno lo stesso problema che loro hanno avuto nel passato o che hanno ancora. Si rivolgono a noi, spiegano la condizione in cui si trova l’amica, magari l’amica è fuori dalla porta.
Ho visto che ci sono degli aspetti, nel rapporto d’aiuto che si crea, che vanno oltre quello che si legge sui libri. Ci sono degli aspetti che ho trovato che sono questioni umane. E’ logico, noi ci consideriamo individui, come dice quella frase, uno nasce solo e muore solo. Però facciamo parte di un pianeta, dal quale nessuno di noi, bianco, rosso, giallo che sia, possiamo andare fuori. Perciò se noi creiamo fra di noi l’amicizia, la stima, la fratellanza, possiamo arrivare al punto di risolvere i problemi agli altri, perché non siamo soli. Quello credo sia la base di tutta l’umanità, anche precisamente dei Centri come il nostro, in cui si aiutano le persone. Non siamo soli, è per questo che sorgono questi Centri. Perché se fossimo soli ognuno si dedicherebbe ai fatti propri, non gli importerebbe assolutamente niente di nessuno. A me piacciono moltissimo i detti vecchi, perché riflettono una profonda conoscenza della vita. Quel detto che dice “Ognun per sé e Dio per tutti” non è vero, perché, se fosse così, immaginiamoci una famiglia in cui “ognun per sé e Dio per tutti”: c’è un pezzo di pane, me lo mangio io. In Venezuela si dice “compartir es il secreto de vivir”: compartire è il segreto di vivere. E veramente così si vive.
E’ vero che comporta meno difficoltà, molta meno difficoltà pensare per sé. In metafisica si dice: più dai più ricevi. Se io mi rinchiudo nel mio guscio, non sarò mai un pulcino, sarò solamente un uovo. Più do, più ricevo, perché l’energia che tutti abbiamo si distribuisce: io do e la ricevo da un altro. Forse a queste persone manca loro questa convinzione che dando si riceva, hanno paura di aver dato e non aver ricevuto, magari trovandosi con un bambino si trovano sole. Molte volte si chiudono per non saper come aprire quelle porte di quella stanza nella quale si sono rinchiusi da sé, molte volte sono state tanto scottate che hanno diffidenza di tutti. Quando vengono qui, praticamente vengono perché gliel’hanno detto amici, e allora dicono “Proviamo”, e allora qui trovano amici e trovano aiuto.
Nella vita tutti abbiamo ricevuto dei colpi, e nessuno è disposto a riceverne più, e allora siamo diventati egoisti. La cosa così non funziona: se non dai, non ricevi, se vuoi amicizia, dai amicizia, se vuoi amore, dai amore con la “A” maiuscola. Ci sono tante cose, tante, tante cose dentro alle persone, purtroppo non tutti le sanno trovare, moltissimi hanno paura di trovarle.
Tutti mi dicono “E ma tu sei troppo filosofa”, effettivamente ho studiato filosofia, però mi sono resa conto che con la filosofia si va molto bene avanti. Senz’altro aiuta prima di tutto a comprendere se stessi, e poi comprendere che gli altri hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Credo che per conoscere gli altri credo bisogna aver lavorato per conoscersi dentro, perché in qualche momento della nostra vita tutti siamo passati per lo stesso problema, in una forma o nell’altra. Allora come puoi aiutare se non hai avuto l’esperienza?
Considero che non dobbiamo calcolare le persone che vengono da noi, non come persone che hanno bisogno solamente di un aiuto a livello materiale. La materia, a un determinato momento, anche i soldi, anche il latte per i bambini, si dimostra nel suo essere è transitoria. Quello di cui la gente – per quello che vedo io – ha bisogno, la base della loro miseria è materiale, e anche una parte spirituale, e anche una base psicologica, e anche una base affettiva. Ci sono persone carenti di molte cose, di dentro, non solo di fuori. Però, se possiamo arricchirli di dentro, oltre che dare un aiuto materiale, allora sì è un aiuto alla vita, non solamente la vita quella che deve nascere per i bambini. Arricchendo la persona di dentro si può fare in modo che lei si arricchisca di fuori, altrimenti non ci sarebbe una risposta al perché andiamo a scuola da piccoli: dobbiamo arricchire la nostra mente e la nostra anima. Se non fosse questo il senso, tanto vale restare tutti analfabeti, tranquillamente nessuno saprebbe leggere, scrivere, nessuno saprebbe fare niente, per vivere come animaletti. Però se abbiamo una mente, se abbiamo un’anima, se abbiamo un cuore usiamoli. Allora sì, su quelle basi possiamo scrivere il nostro cartello: “Fammi nascere”. Queste sono le fondamenta.
Analizzando la nostra vita interna, le nostre azioni, le nostre sensazioni, i nostri problemi, impariamo ad aiutare gli altri a risolverli, perché tutti siamo passati di là. Io, per esempio, ho un’età che considero meravigliosa. Considero la mia vita ricca, non quella di fuori, quella di dentro. Molte persone che vengono qui a chiedere un aiuto economico probabilmente hanno bisogno anche di questo, di sentire questo. Per me le due cose sono legate, materia e spirito sono due facce dello stesso foglio, non si può dividerli.
Passiamo nella vita “incoscientemente incoscienti”. Ci si deve rendere conto che si può aver una vita piena, anche di amarezza. Però sono amarezze che, in un determinato momento, quando te ne rendi conto, scopri che sono state una tempesta in un bicchiere d’acqua. Nel momento sembra che il mondo sia crollato, poi ci rendiamo conto che il mondo continua ad andare avanti, se ne infischia di noi, del nostro problema, allora tanto vale vivere.
In questo momento possiamo considerare che io qui al Centro sono una novizia, sono qui da poco, pochi mesi. A ottobre-novembre, abbiamo fatto il corso, e poi io sono stata integrata, vengo una volta alla settimana. Non ho il rapporto diretto, perché considero che loro hanno molta più esperienza. Però c’è sempre qualcuno che mi capita, non so per quale fenomeno, dicendo “Senta ho un problema..”. Allora dobbiamo risolvere i problemi. Io non voglio “irrompere” in un mondo che ha già per ora una sua forma di essere. Io potrei essere una nota stonata nell’orchestra, lascio le cose come stanno e aspetto che arrivi il mio turno.
Ø 16)
Queste persone si presentano qua generalmente in situazioni un po’ particolari, gravidanze indesiderate, imprevisti, problemi con il marito, nel caso di famiglie numerose, o con il partner, nel caso dei rapporti più precari. O vengono perché vedono la pubblicità su autobus, locandine o altro, o vengono mandate qua da conoscenti, da amici.
L’approccio iniziale è sempre un po’ titubante, chiaramente. Si cerca di mettere queste persone a proprio agio, farle sentire in un ambiente amichevole, un ambiente in cui soprattutto non si giudichi la persona, cioè trattiamo da pari a pari, mi raccontano le loro esperienze, ci chiamiamo per nome, garantiamo la privacy, l’anonimato. Gradatamente si cerca di conquistare la fiducia di questa persona. Tanti poi si aprono, magari piano, piano, chi prima, chi dopo, a seconda del carattere, della personalità che è sempre diversa, no? Si ascolta – perché innanzi tutto bisogna ascoltare il caso che questa persona ci prospetta - e poi vediamo di trovare assieme delle soluzioni. Esponiamo l’aiuto che noi possiamo dare: aiuto materiale e anche un aiuto morale, insomma, di sostegno. Tante volte vale molto anche una parola buona, più che un aiuto materiale.
Vengono anche perché si sentono sole, ci sono anche problemi di solitudine, ci sono persone extracomunitarie, ci sono persone che poi hanno anche divergenze nell’ambito della famiglia, diversità di opinione, nell’ambito della famiglia stessa, con i genitori o altri. I genitori, per esempio, dicono “No il figlio non lo tieni”, la persona invece lo vuole, per cui si rivolge a noi.
Piano piano si cerca di conquistare la fiducia di questa persone, ci sono persone che vengono qua anche da molti anni, si creano anche rapporti molto lunghi, addirittura con le figlie di persone che si erano già rivolte qua tanti anni fa e, a loro volta, vengono: questo è un buon segno, che l’aiuto è stato recepito e che non è stato buttato via al vento, per così dire.
Quando si ascoltano queste storie c’è coinvolgimento personale, bisognerebbe, diciamo, saper staccare il lavoro con la nostra vita privata. Aiutare sicuramente al massimo queste persone, ma cercando di non lasciarsi coinvolgere all’eccesso, anche perché è controproducente per sé, e anche per l’aiuto.
Bisognerebbe cercare di mettere tutti sullo stesso piano, trattare tutti alla stessa maniera, capire i loro problemi, aiutarli per quello che possiamo e indirizzarli verso le strutture degli enti locali, ma anche della Provincia, Regione, eccetera. Svolgiamo una funzione anche da tramite, li aiutiamo nelle domande per l’alloggio e la richiesta di sovvenzioni al Comune. Ci sono delle varie modalità per dimostrare l’aiuto, che noi a loro esponiamo. Generalmente lo standard classico dell’approccio iniziale è una persona che chiede di fare un test di gravidanza, perché ha il sospetto di essere incinta. Quando ha fatto il test, se risulta negativo, non si comportano problemi, se, invece, risulta positivo si ascolta un po’ la storia di questa persona, i problemi che si possono affrontare e si prospetta dei percorsi d’aiuto che vanno dalle informazioni sugli esami da fare al Burlo, accompagnandola fino alla nascita del bambino, si fornisce di un corredino completo, con eventuale aiuto economico-materiale. Si indirizzano, per la fornitura di tutto quello che hanno bisogno, anche al Comune, in attesa che provveda il Comune, provvediamo noi in qualche maniera. Generalmente aiutiamo fino ai sei anni, altrimenti rischiano di esserci problemi logistici di sistemazione delle cose. Queste cose che distribuiamo le riceviamo da offerte di privati, ci capitano anche casi in cui la mamma si presenta qui e ha cinque, sei figli, in una situazione di lavoro precario oppure è sola.
L’ascolto è sempre il punto di partenza, la base di tutto, comunque: capire questa persona, cercare di conquistare la sua fiducia. Diciamo che una persona che si rivolge qua ha già un minimo di fiducia. Sta poi a noi cercare di far aprire un po’ la persona, ma, in linea di massima, il rapporto con gli utenti è buono. Poi il caso della persona che viene qui e pretende è, insomma, il caso limite, ecco. In linea di massima c’è un buon rapporto con la maggioranza delle persone, anche perché venendo qui sono già in una condizione di bisogno e sanno che noi li sosteniamo. Si può dire che la caratteristica del Centro sta nel fatto che l’accoglienza certamente non deve essere di carattere burocratico, dev’essere un’accoglienza umana, perché questa persona deve sentirsi a proprio agio. Gli operatori fanno un corso di sei lezioni settimanali, in cui psicologi, medici spiegano un po’ l’atteggiamento da tenere verso queste persone. Praticamente uno dei punti basilari è proprio l’accoglienza e l’ascolto di queste persone. E poi ci si affida anche un po’ all’esperienza.
Io qui non sono l’unico uomo, ce n’è un altro, oltre al presidente. C’erano altri uomini che hanno fatto il corso, si che si sono inseriti per un periodo, poi hanno lasciato. Io sono qua da due anni, volevo fare del volontariato, anche perché ho del tempo libero, lavoro per turni, sono rimasto vedovo e siccome mia moglie faceva del volontariato, anche se in un altro ambito, ho pensato di continuare a fare anch’io qualcosa. Ho visto la locandina, ho telefonato e ho chiesto se era adatto anche agli uomini. Mi hanno detto di sì, “Più che volentieri noi vorremmo avere un aiuto da parte di un uomo”, almeno un uomo per turno. Non si presentano solo le ragazza, le donne, si presentano anche le coppie, la donna e il partner assieme, e tante volte si ha bisogno anche di questo tipo di comunicazione, in un certo senso, di un aiuto che provenga da un uomo. Un uomo magari parla più volentieri con un uomo, una donna magari parla più volentieri con una donna, anche se tante volte io sono stato contattato anche dalle donne, hanno parlato senza problemi. Anche quando vengono qua, non vedono in linea di massima l’uomo e la donna, vedono la persona disponibile che può aiutarli e può accoglierli, questo è il mio punto di vista. E poi siccome mi sono trovato bene, qui sono rimasto. Diciamo che può anche capitare di sistemare la roba nel magazzino, bisogna fare un po’ di tutto, perché lo spirito di adattamento si richiede in qualsiasi attività di volontariato. Anche per me è stata un’esperienza arricchente, un’esperienza positiva perché ci si sente utili e comunque c’è l’incontro con le persone, anche con i colleghi, anche nelle riunioni mensili di giunta allargata, in cui c’è occasione di incontro, con la “supervisione” del presidente, in cui chi è disponibile partecipa. In quella sede vengono messi sul tappeto i diversi problemi, sia di carattere generale, organizzativo, sia problemi pratici. Si dice anche “A me è capitato questo con una persona, ho agito male?”, si chiede un consiglio. Se ci si rende conto che si sono fatti degli errori, si cerca in futuro di evitare quegli errori e migliorare gradatamente.
Ho incontrato anche due volontarie che si occupano una del “guardaroba”, della cucitura di vesti, lenzuola per i bambini, e l’altra della contabilità, dell’aspetto più burocratico. Senza entrare nel merito del dialogo, essendo altri i loro principali compiti, mi hanno semplicemente spiegato la loro ulteriore funzione di sostegno. Le ragazze raccontano la loro esperienza, anche per spiegare il motivo per il quale chiedono aiuto. L’ascolto in questo caso si accosta a un altro impegno importante assolto dalle volontarie e dal Centro: l’aiuto concreto. Non si possono ritenere distinte le due modalità di intervento.
Bibliografia
Alberoni F., La Speranza, Rizzoli, Milano, 2001.
Anderson, H.H., (a cura di), La creatività e le sue prospettive, La Scuola, Brescia, 1972.
Apel K.O., Personalismo sociale, Studium, Roma, 1979.
Aranguren J., Sociologia della comunicazione, trad. it., Il Saggiatore, Milano, 1967.
Azzali F., Cristianini D., Programmare oggi. Le fonti, i modelli, le azioni, Fabbri, Milano, 1995.
Baldini M., Le parole del silenzio, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1986.
Batini F., Lo sguardo che carezza da lontano. Per una formazione alla relazione d’aiuto, Franco Angeli, 2001.
Bauman Z., La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999.
Benozzo A., Etnografia organizzativa: una proposta di metodo per l’analisi delle organizzazioni come culture, Cortina Editore, Milano, 1996.
Bentham J., The principles of morals and legislation, trad. it, Unione tipografico editrice torinese, Torino, 1998.
Bertin G.M., Contini M., Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, Armando, Roma, 1983.
Bertolini P., L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze, 1998.
Bertolini P., Ragazzi difficili, Scandicci, Firenze, 1994.
Blandino G., Le capacità relazionali. Prospettive psicodinamiche, Utet, Torino, 1996.
Bruner J., Il significato dell’educazione, Armando, Roma, 1973.
Bruner J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997.
Brusco A., Marinelli S., Iniziazione al dialogo e alla relazione d’aiuto. 1 e 2 livello, Il Segno, 1997.
Brusco A., Marinelli S., La relazione pastorale di aiuto. Camminare insieme, Edizioni Camilliane, 1994.
Buber M., Il principio dialogico, Edizioni di comunità, Milano, 1959.
Buber M., Il problema dell’uomo, Edizioni scolastiche Patron, Bologna, 1972.
Canevaro A., Chieregatti A., La relazione d’aiuto, Carrocci, Roma, 2000.
Cannella B., Cavagli P. – Tartaglia F., L’infermiere e il suo paziente. Il contributo del modello psicoanalitico alla comprensione della relazione d’aiuto, Il Segnalibro, 1994.
Caracciolo E., Rovetto F. ( a cura di ), Ritardo mentale, Franco Angeli, Milano, 1997.
CARITAS ITALIANA (a cura di), Ragazzi al margine. Emergenze e aree a rischio nella devianza minorile, Elle Di Ci, Torino, 1998.
Cecchini R.T., Bordogna M.T., Migrare, Franco Angeli, Milano, 1992.
Cian L., La relazione d’aiuto. Elementi teorico- pratici per la formazione a una corretta comunicazione interpersonale, Ellenici, 1992.
Clarkson P. Gestalt Counseling. Per una consulenza psocologica proattiva nella relazione d’aiuto, Sovera Multimedia, 1992.
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999.
Cortese C., L’organizzazione si racconta, Guerini, Milano, 2000.
Cracciolo E., Rovetto F.( a cura di ), Ritardo mentale, Franco Angeli, Milano, 1997.
Crepet P., Non siamo capaci di ascoltarli. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza, Einaudi Editore, Torino, 2001.
Dal Lago A., Non – persone, Feltrinelli, Milano, 1999.
De Leo G., La devianza minorile. Metodi tradizionali e nuovi modelli di trattamento, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1997.
De Natale M.L., Devianza e pedagogia, Editrice La Scuola, Brescia, 1998.
De Santi ( a cura di ), Il dloce morire. La relazione d’aiuto al morente nelle cure palliative, Carocci, 1999.
Delors J., Nell’educazione un tesoro. Rapporto UNESCO sull’educazione per il XXI secolo, Armando Editore, Roma, 1997.
Demetrio D., Educatori di professione. Pedagogie e didattiche del cambiamento nei servizi extrascolastici, La Nuova Italia, Firenze, 1992.
Demetrio D., Manuale di educazione degli adulti, Laterza, Bari, 1999.
Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Milano, Cortina, 1996.
Desinan C., Orientamenti di educazione interculturale, Franco Angeli, Milano, 1997.
Dewey J., Esperienza e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1949.
Dewey J., Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 1971.
Donadi P., Emarginazione e invisibilità delle donne senza fissa dimora, Editrice Montefeltro, Urbino, 1999.
Donadi P., I luoghi della salute delle donne, F.Angeli, Milano, 1996.
Ducci E., Essere e comunicare, Adriatica Editrice, Bari, 1974.
Erikson E. H., Gioventù e crisi d’identità, Armando, Roma, 1980.
Ferrucci G., La relazione d’aiuto. Teoria e tecnica della psicologia umanistico-esistenziale, Ma.Gi, 2001.
Fiche J.G., Sullo spirito e la lettera, Rosenberg & Sellier, Torino, 1989.
Fine S.F., Glasser P.H., Il primo colloquio. Coinvolgimento e relazione nelle professioni d’aiuto, a cura di Anchisi R., tr. Di Boria Migliorini M.C., McGraw – Hill Libri Italia, 1999.
Folghraiter F., Problemi di comportamento e relazione d’aiuto nella scuola, a cura di Belli M., Centro Studi Erickson, 1992.
Formenti L., La formazione autobiografica, Milano, Guerini Studio,1998 .
Frabboni F., Guerra L., Scurati C., Pedagogia. Realtà e prospettive dell’educazione, Bruno Mondatori, Milano, 1999.
Fromm E., Psicanalisi della società contemporanea, Edizioni di Comunità, Milano, 1976.
Galli M., Lo spazio dell’incontro, Meltemi Editore, Roma, 1996.
Galli M., Quali valori nella scuola di stato?, La Scuola, Brescia, 1989.
Genevay B., Katz R., Le emozioni degli operatori nella relazione d’aiuto. Il controtransfert nel lavoro con gli anziani, a cura di Gasperi L., Centro Studi Erickson, 1994.
Gevaert J., Il problema dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1978.
Ghiglione R., Minnini G., La comunicazione funzionante: io, la televisione, Milano, Franco Angeli, 1995.
Giovanni Verzellino (a cura di ), Relazione d’aiuto o…Professione d’aiuto?, Liguori,1996.
Giusti M., Il desiderio di esistere, La Nuova Italia Editrice, Scandicci, Firenze, 1999.
Grassilli B., Questioni di didattica generale. Azione didattica, Progettazione, Ricerca, anno accademico 2000/01.
Groppo M.(a cura di), Professione educatore.L’operatore socio-psico-pedagogico, Vita e Pensiero, Milano, 1994.
Gusdorf G., Filosofia del linguaggio, trad. it. , Città Nuova Editrice, Roma, 1970.
Hartmann W., Uomini in un’epoca senza linguaggio. Suggerimenti e prospettive per orientare i giovani oggi, La Scuola, Brescia, 1979.
Hegel G.W.F., Fenomenologia dello Spirito, Società Editrice Internazionale, Torino, 1996 .
Inghilleri S., Psicologia dello sviluppo, Guerini Studio, Roma, 1994.
Jaspers K., Filosofia, trad.it., UTET, Torino, 1978.
Knowles M.S., La formazione degli adulti come autobiografia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.
Knowles M.S., Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, F.Angeli, Milano, 1997.
Krikemans A., Trattato di pedagogia generale, trad.it., La Scuola, Brescia, 1971.
Lasch C., La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano, 1981.
Lazzari C., Come dare un aiuto psicologico agli altri senza essere psicologi. Guida alla relazione d’aiuto, Pitagora, 1998.
Lazzari C., La relazione d’aiuto. Come prendersi cura degli altri quando sono preoccupati per la propria salute, Pitagora, 1998.
Lévinas E., Altrimenti che essere, o Al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano,1983.
Lévinas E., Totalità e infinito, Jaca Book, Milano,1982.
Lombardi F.G., Politica e educazione nel personalismo di Mounier: saggio critico con ontologia del pensiero e critica, Massima, Milano, 1980.
Macchietti S.S., Pedagogia del personalismo italiano, Città Nuova Editrice, Roma, 1982.
Magro G., Rossati A., Stress e burnout, Carocci Editore, Roma, 2000.
Maritain J., La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia, 1963.
Mencarelli M., Creatività e valori educativi, La Scola, Brescia, 1977.
Mercuel A., Monfort J. C., Lauth B., Colloquio e relazione d’aiuto. Situazioni psichiatriche e psicologiche difficili, Masson, 2000.
Milan G., Educare all’incontro, Città Nuova Editrice, Roma, 1994.
Milani L., Competenza pedagogica e progettualità educativa, La Scuola, Brescia, 2000.
Minio Antonino, La relazione d’aiuto. Lascia che io mi avvicini a te, Monti, 2001.
Miodini S., Zini M.T., L’educatore professionale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1992.
Mizzau M., Prospettive della comunicazione interpersonale Il Mulino, Bologna, 1974.
Morselli E., Dizionario di filosofia e di scienze umane, Carlo Signirelli Editore, Milano, 1997.
Mounier E., Il personalismo, AVE, Roma, 1964.
Mounier E., Rivoluzione personalistica e comunitaria, trad.it, Ecumaica, Cassano, 1976.
Murgatroyd S., Il counseling nella relazione d’aiuto, Sovera Multimedia, 1995.
Nanni C., L’educazione tra crisi e ricerca di senso, Las, Roma, 1990.
Ong W. J., La presenza della parola, trad.it., Il Mulino, Bologna, 1970.
Pellerey M., L’agire educativo . La pratica pedagogica tra modernità e postmodernità, , Las, Roma ,1998.
Piccardo C., Benozzo A., Etnografia organizzativa: una proposta di metodo per l’analisi delle organizzazioni come culture, Cortina, Milano, 1996.
Pollo M., Educazione come animazione. Il metodo, Elle Di Ci, Torino, 1994.
Reale G., Antiseri D., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, ( vol. 1,2,3), La Scuola, Brescia, 1994.
Redigolo D., Kaldor K. – Illica Magrini R., Il processo comunicativo nella relazione d’aiuto. La comunicazione interpersonale come strumento di lavoro, Rosini, 1995.
Ricoeur P., Sé come un altro, Jaca Book, Milano, 1993.
Rigobello A., Il personalismo, Città Nuova, Roma, 1978.
Rigobello A., Soggetto e persona: ricerca sull’autenticità dell’esperienza morale, Mialno, S. Paolo, 1998.
Rigobello A., L’Altro, l’estraneo, la persona, Città del Vaticano, Urbaniana University, 2000.
Rogers C.R., I gruppi d’incontro, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1976.
Rogers C.R., La terapia centrata-sul-cliente, Martinelli, Firenze, 1970.
Rossi B., Intersoggettivià e educazione, La Scuola, Brescia, 1992.
Rulli G. , Basile A. ( a cura di ), L’educazione come relazione d’aiuto ed etica professionale, I Congrsso Scientifico Nazionale, Roma, 10 –11 ottobre 1997.
S.Agostino ( a cura di Hans Urs von Balthasar), Le confessioni, Edizioni Piemme, 1993.
Salomè J., La relazione d’aiuto e la formazione al colloquio, Liguori, Napoli, 1996.
Salomè J., Parlami, ho tante cose da dirti. Saggio sulla non comunicazione nella coppia, Borla, Roma, 1982.
Santerini M., L’educatore tra professionalità pedagogica e responsabilità sociale, La Scuola, Brescia, 1998.
Savignano A., Bioetica delle virtù, Guida editori, Napoli, 1999.
Scaramuzzi O., Mi aiuti a uscire dalla notte? Problematiche e risorse del malato grave nei dialoghi di relazione d’aiuto, Edizioni Camilliane, 1996.
Schon D., Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, Dedalo, Bari, 1993.
Scurati C., Volti dell’educazione La Scuola, Brescia, 1996.
Singer P., Etica pratica, Liguori Editore, Napoli, 1989.
Spranger E., La vita educa, trad.it., La Scuola, Brescia, 1969.
Svignano A., Bioetica delle virtù, Guida editori, Napoli, 1999.
Taylor C., Il disagio della modernità, Editori Laterza, Bari, 1999.
Tramma S., Educazione degli adulti, Guerini Studio, Milano, 1997.
Vico G., I fini dell’educazione, La Scuola, Brescia, 1995.
Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, trad.it., Astrolabio Ubaldini, Roma, 1971.
Zattoni Gillini M., Tonni M., La cinquantaseiesima colonna. Uno strumento concreto di autoformazione per chi si trova in una relazione d’aiuto, Queriniana, 1992.
Indice
1 INTRODUZIONE_ 1
1.1 IL CONCETTO DI ALTRO_ 2
1.1.1 Lévinas, il primato dell’etica 7
1.1.2 Singer, un’etica “universale” 8
1.1.3 Taylor e il disagio della modernità 10
1.2 L’ALTRO AL DI LÀ DELL’ASSISTENZIALISMO_ 13
1.3 IL CONCETTO DI RELAZIONE_ 16
1.3.1 L’Io – tu di Buber 16
1.3.2 La relazione fra educatore ed educando_ 20
1.4 IL CONCETTO DI AIUTO_ 32
2 LA RELAZIONE D’AIUTO_ 36
2.1 LA RELAZIONE D’AIUTO COME TENSIONE AL CAMBIAMENTO_ 36
2.1.1 Alcune relazioni d’aiuto_ 41
2.2 LA RICERCA DI SENSO_ 62
2.2.1 La speranza 67
2.2.2 L’autobiografia: autoriflessione e retrospezione 70
2.3 CRESCITA RECIPROCA_ 78
2.3.1 Il lavoro dell’educatore 78
2.3.2 Il coinvolgimento dell’educatore 81
2.3.3 Burnout 82
3 L’AGIRE EDUCATIVO. 87
3.1 LE COMPETENZE_ 87
3.1.1 La progettazione 87
3.1.2 Interdisciplinarieta’ e approccio olistico_ 89
3.2 I “VALORI” EDUCATIVI 92
3.2.1 L’educatore come strumento_ 93
3.2.2 L’ascolto_ 98
3.2.3 Il comprendere: entropatia 106
3.2.4 La comunicazione 112
4 LAVORO SUL CAMPO_ 130
4.1 AGGANCIO FRA TEORIA E PRASSI 130
4.2 CONFRONTO SUL CAMPO: CONTRIBUTI E RIFLESSIONI 132
4.2.1 Riflessione sul volontariato_ 134
4.2.2 Presentazione del centro di aiuto alla vita 135
4.2.3 Incontro con le educatrici: il colloquio d’aiuto sul campo_ 141
5 CONCLUSIONE_ 166
5.1 LA “SCOMPARSA” DELL’EDUCATORE_ 167
5.2 CONTINUARE A IMPARARE_ 170
Appendice 173
Bibliografia_ 207
Indice 212
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Scurati C., ( a cura di ) Volti dell’educazione, La Scuola, Brescia,1996.
[2] Bauman Z., La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999.
[3] Nanni C., La guida spirituale in Scurati C., cit., pp. 286, 287.
[4] in greco nel testo: “conosci te stesso”.
[5] Formenti L., Ricercare il senso in La formazione autobiografica, Guerini Studio, Milano, 1998, pp. 134-139.
[6] Per la lettura del pensiero di Rogers, cfr. Reale G., Antiseri D., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi ( vol 3), La Scuola, Brescia, 1994, pp. 717 – 719.
[7] Fiche J.G. Sullo spirito e la lettera, Rosenberg & Sellier, Torino, 1989, p. 99, nota 43. La citazione si riferisce a “Lezioni su Platener”, GA II 4, p. 159.
[8] In Fiche J.G., ibid., p. 98.
[9] Delors J., Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo, Armando Editore, Roma, 1996.
[10] Per la lettura del pensiero di Mounier, cfr. Reale G., Antiseri D., cit., pp. 569 – 576.
[11] Per questa e le successive citazioni sul personalismo il testo di riferimento è Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, trad. it., Ecumaica, Cassano, 1976.
[12] Fra gli altri, i concetti di possibilità, rischio, responsabilità sono parole chiave della pedagogia, “direzioni di senso” nell’esperienza e dell’operato educativo. Cfr Lineamenti di Pedagogia Generale – Studium Educationis n° 2, CEDAM, Padova, 1999.
[13] Rossi B., Intersoggettività e educazione, La Scuola, Brescia, 1992. “…tutt’altro che infrequentemente è dato di assistere alla affermazione e alla moltiplicazione di tendenze narcisistiche, ad una specie di rinsecchimento dei flussi interattivi e all’incapacità di dialogo e di ascolto decentrato, alla enfatizzazione dell’io rispetto al tu e al noi, alla dilatazione dei fenomeni della solitudine e dell’emarginazione, della ghettizzazione e della incomprensione, alla assenza di solidarietà, ad una diffusa disposizione alla comunicazione egocentrica con quello che di indifferenza, competizione, prevaricazione essa comporta nei confronti dell’altro e degli altri”, p.9.
[14] Nella Critica della Ragion pratica, Kant distingue i principi pratici (determinazioni generali della volontà o regole pratiche) in massime e imperativi. Fra gli imperativi, gli “ipotetici” sono regole d’abilità, consigli di prudenza: il se vuoi…devi; i “categorici” sono leggi pratiche e morali: il devi perché devi.
[15] Levinàs E., Totalità e infinito, Jaka Book, Milano, 1992.
[16] Per la lettura del pensiero di Lèvinas, cfr. Reale G., Antiseri D., cit., pp. 614-616, da cui anche questa citazione è stata tratta.
[17] Nell’opera Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Lévinas giunge a considerare che per il soggetto essere responsabile nei confronti dell’Altro vuol dire ricoprire un posto assegnatogli: vede nella responsabilità “un’assegnazione a rispondere all’Altro”. “Il termine Io significa eccomi” .
[18] Singer P., Etica pratica, Liguori Editore, Napoli, 1989. Singer in realtà è esponente del neoutilitarismo, corrente che riprende l’utilitarismo classico.
[19] E’ possibile risolvere i problemi di etica pratica ( fra quelli che Singer tratta nel proprio libro: omicidio, aborto, eutanasia, povertà), sulla base dell’eguale considerazione degli interessi, che rappresenta la chiave di lettura della dottrina utilitarista. Questo principio, deriva dall’affermazione secondo la quale gli interessi devono essere considerati in sé, indipendentemente dal fatto che siano i nostri o quelli degli altri: bisogna pesarli in modo imparziale. Fare solo il proprio tornaconto è l’unico interesse che non è interessante.
[20] Bentam J. è considerato auctor perché portò l’utilitarismo alla pienezza del suo sviluppo.
[21] Savignano A., Bioetica delle virtù, Guida editori, Napoli, 1999, pp. 97-108.
[22] Taylor C., Il disagio della modernità, Editori Laterza, Bari, 1999.
[23] Ibid., pp. 6, 7.
[24] Ibid., pp. 35, 36.
[25] Ibid., pp. 37 - 48.
[26] Ibid.,, pp. 51 - 81.
[27] Ibid., pp. 83 - 92 , 109 e seg.
[28] Organizzazione Mondiale della Sanità.
[29] De Leo G., La devianza minorile, La Nuova Scientifica, Roma, 1997, p.127-128.
[30] Canevaro A., Chieregatti A., La relazione d’aiuto, Carrocci, Roma, 2000, pp. 201 – 217.
[31] De Leo, cit, p. 201.
[32]Ibid., pp. 101 – 116.
[33] Bertolini P., Ragazzi difficili, Scandicci, Firenze, 1994. Il tema relativo al superamento dell’ottica eziologico-deterministica viene affrontato in modo approfondito nel paragrafo 2.2, “La ricerca di senso” , p. 60 e seg.
[34] Milan G., Educare all’incontro, Città Nuova Editrice, Roma, 1994. Da questo testo sono anche estrapolate le citazioni di Buber con riferimento alle rispettive pagine in nota.
[35] Ibid., p. 34.
[36] “Non esiste educazione se essa non è intenzionalmente orientata a un fine verso cui tendere; e il fine dell’educazione, sostiene Buber, deve essere la persona nella sua totalità, compresa sia nella sua presente concretezza sia nelle sue possibilità future; deve essere – come troviamo scritto più volte nei saggi pedagogici del filosofo tedesco – la formazione del grande carattere”. Ibid., p.51.
“Il grande carattere non è un individuo autosufficiente e originariamente isolato, come lo vide Freud, né un membro di una collettività organica”. Ibid., p.54, 55.
[37] Ibid., p. 55.
[38] Ibid., p. 65.
[39] Ibid., p. 124.
[40] Per le citazioni presenti nel paragrafo, cfr. Salomè J., La relazione d’aiuto e la formazione al colloquio, Liguori, Napoli, 1996, pp. 6, 7.
[41] Ibid.
[42] Corsi M. , Il consigliere, in Scurati C., I volti dell’educazione, La Scuola, Brescia, 1996, p. 172.
[43] Le informazioni sono ricavate da Ragazzi al margine. Emergenze e aree a rischio nella devianza minorile, a cura di CARITAS ITALIANA, Elle Di Ci, Torino, 1998, pp 33 – 36.
[44] Benozzo A. - citato successivamente a proposito dei metodi qualitativi, p. 70 - usa il termine “guardare con i suoi occhi”, che rende l’idea dello sforzo e della capacità empatica richiesti.
[45] Miodini S., Zini M.T., L’educatore professionale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1992, pp. 66, 67.
[46] Questi temi vengono trattati nello specifico nella seconda parte del terzo capitolo.
[47] La presente citazione è tratta da Reale G., Antiseri D., cit, vol. 1, pp. 70, 71.
[48] Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani.
[49] Verdoscia L, La pedagogia e la cultura del self - help, in Rulli G., Basile A. ( a cura di ), L’educazione come relazione d’aiuto ed etica professionale, I Congrsso Scientifico Nazionale, Roma, 10 –11 ottobre 1997.
[50] Ibid., pp. 203 – 207.
[51] Knowles M.S., La formazione degli adulti come autobiografia,. Il percorso di un educatore tra esperienza e idee, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, pp. 47 – 53.
[52] Ibid., p. 47.
[53] Lo schema è stato interamente ricavato da quello proposto da Knowles, ibid., p. 48. Si sono evidenziate in corsivo le parti ritenute particolarmente rilevanti anche nel contesto della relazione d’aiuto.
[54] Rosenthal e Jacobson, 1968.
[55]I riferimenti a Platone e a Pascal sono di Pellerey M., L’agire educativo. La pratica pedagogica tra modernità e postmodernità, Las, Roma, 1998, p. 45.
[56] Per la costruzione dello schema ho fatto riferimento ai contenuti di Milani L., Competenza pedagogica e progettualità educativa, La Scuola, Brescia, 2000 e alla dispensa di Blezza F., Scritti di pedagogia professionale, Ts-Pn, a.a. 1998/99.
[57] E’ una grande scoperta per l’azione educativa il concetto di “eterocronia” (termine che deriva dal greco ??teros cro´nos, ” altri tempi ” ) , garantisce il rispetto dei tempi di apprendimento e di crescita nel percorso educativo: ci sono tempi diversi nello sviluppo, sia tra un individuo e l’altro, sia nello stesso individuo.
[58] CARITAS, cit., p.50.
[59] Ibid., pp. 66 – 68.
[60] Il tema relativo viene affrontato in modo approfondito nel paragrafo 2.2, “La ricerca di senso” , p. 60 e seg.
[61] Salomè, cit, pp. 155, 156.
[62] Nanni C., La guida spirituale, in Scurati C., cit, p. 277.
[63] Pellerey M., cit., p. 8.
[64] Demetrio D., Manuale di educazione degli adulti, Laterza, Bari, 1999.
[65] Caracciolo E., Rovetto F. ( a cura di ), Ritardo mentale, Franco Angeli, Milano, 1997, pp. 118 – 123.
[66] Chieregatti A., L’aiuto, in Canevaro A., Chieregatti A., cit.
[67] Ibid. pp. 165, 166.
[68] Ibid., p. 248.
[69] Salomè J., cit., pp. 26-36.
[70] Ibid., pp. 37, 49.
[71] Ibid., pp. 61, 62.
[72] Pellerey M., cit., p. 34.
[73] Blezza F., cit., pp. 12, 49.
[74] Frabboni F., Guerra L., Scurati C., Pedagogia. Realtà e prospettive dell’educazione, Bruno Mondatori, Milano, 1999, p. 16.
[75] De Natale M. L., Devianza e pedagogia, Editrice La Scuola, Brescia, 1998, p.16.
[76] Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.
[77] Ibid., p. 83.
[78] Ibid., p. 126.
[79] Ibid., p. 14.
[80] Donadi P., Tempo per sé e costruzioni artistiche in I luoghi della salute delle donne, F.Angeli, 1996. Rivolge un’attenzione particolare alla condizione delle donne, che può essere utile, anche se da uno specifico punto di vista, per comprendere nella sua totalità, in campo educativo, il fenomeno del disagio che vivono le perone “tagliate fuori”. Anche le donne vivono ai margini, in un certo senso, e soprattutto le donne di cui la Donadi mette in luce la vita alternativa, da senza fissa dimora.
In questo caso il tema del lavoro su di sé rappresenta una “tecnica” di intervento perché la donna possa fronteggiare la società, acquisendo la consapevolezza e i saperi necessari per la propria “sopravvivenza”, per non lasciarsi sopraffare.
[81] Demetrio D., Presentazione in Tramma S., Educazione degli adulti, Guerini Studio, Milano, 1997, pp. 11 – 16.
[82] Miodini S., Zini M. L., cit., pp. 37 – 46.
[83] E’ necessario sottolineare che le classificazioni non vogliono categorizzare l’uomo, inquadrandolo in schemi precodificati, ma l’intento è quello di cercare di cogliere i tratti essenziali dell’agire educativo, riassumendone le peculiarità, senza voler generalizzare. Si deve essere consci che al di là di tutte le classifiche c’è l’Uomo e ogni singolo uomo con la sua storia, i suoi problemi, le sue difficoltà che chiedono di essere affrontate e risolte.
[84]Santerini M., L’educatore tra professionalità pedagogica e responsabilità sociale, La Scuola, Brescia, 1998.
Sviluppa un’articolata lettura del contesto, inteso non solo nell’accezione più ampia di ambiente sociale nel quale il soggetto si muove e dal quale è condizionato, ma anche come insieme di persone che affiancano il soggetto quotidianamente.
[85] Caracciolo E., Rovetto F., cit., pp. 299 – 317.
[86] Soresi S., Il coinvolgimento della famiglia in Caracciolo E., Rovetto F., ibid., p. 303. Si evidenzia come, contrariamente al passato in cui non si dava spazio ai genitori nella partecipazione alla riabilitazione dei figli perché si riteneva mancassero di competenze, oggi se ne valorizzino i vantaggi – come per esempio quelli garantiti dal fatto che un genitore si presuppone conosca meglio il proprio figlio rispetto all’educatore – e il diritto dei genitori a essere formati in merito alla salute e allo sviluppo del proprio figlio, e a essere coinvolti. In cambio ai genitori è richiesta una certa “sensibilità al training”, motivazione a migliorare, eliminazione di atteggiamenti di rigidità di fronte ai nuovi metodi e di atteggiamenti pessimistici nei confronti del figlio.
[87] Tramma S., cit., pp. 67 – 79.
[88] Bauman Z., cit.
[89] Per la lettura del pensiero di Erikson, cfr. Inghilleri S., Psicologia dello sviluppo, Guerini Studio, Roma, 1994, pp. 56 – 60.
[90] Tramma S., cit., p. 136.
[91]In Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 32 e seg., si sviluppa, oltre che ad un più ampio riferimento ai paradigmi citati, anche una riflessione sulle critiche rivolte alle loro radicalizzazioni. In particolare, parlando di interpretativismo il rischio è di cadere nell’incomunicabilità più totale, aspetto per il quale il costruttivismo, nella sua accezione più radicale, è stato messo in discussione.
[92] Demetrio D, Manuale di educazione degli adulti, cit., pp. 21 – 27.
[93] Oltre a questi aspetti che sono stati messi in evidenza da Demetrio, secondo Desinan, non si può prescindere da un ulteriore canale dell’educazione: la riflessione personale sul vissuto, come un’attività individuale, solitaria, unica.
[94] Inghilleri P., cit, pp. 119 - 138.
[95] De Natale, cit, pp. 54 – 65.
[96] Il tema della motivazione viene affrontato anche nell’ultimo paragrafo del quinto capitolo, nel quale si spiega la distinzione fra le sue due varianti, la motivazione intrinseca ed estrinseca.
[97] De Natale, cit, p. 55.
[98] Crepet P., Non siamo capaci di ascoltarli. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza, Einaudi Editore, Torino, 2001, pp. 32 – 35.
[99] Ibid., p. 75.
[100] Ibid., pp. 81, 82.
[101] CARITAS, cit, pp. 89 – 139.
[102] Guerra L., ( Parte terza ) L’educazione fuori dalla scuola, in Frabboni F., Guerra L., Scurati C., Pedagogia. Realtà e prospettive dell’educazione, Bruno Mondatori, Milano, 1999, pp. 119, 120.
[103] Desinan C., Orientamenti di educazione interculturale, Franco Angeli, Milano, 1997.
[104] Cecchini R.T., Bordogna M.T., Migrare, Franco Angeli, Milano, 1992.
[105] Ibid., p. 20.
[106] Ibid., p. 114.
[107] Ibid., pp. 18 – 20.
[108] Ibid., pp. 23, 24.
[109] E’ stato Taylor ad aver rivoluzionato il concetto di cultura, definita in questi termini: “ comprende qualsiasi capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società”. Il relativismo si propone come lezione di tolleranza e modestia per la libera convivenza di diverse culture. Si contrappone all’etnocentrismo che pur essendo atteggiamento naturale di amore-preferenza per i propri costumi, nella sua radicalizzazione diventa teoria della supremazia e dell’imposizione.
[110] Malaguti E., Il volto dell’AIDS, in Canevaro A. – Chieregatti A., cit., p. 246.
[111] Ibid., pp. 245 - 257, da cui sono tratte le citazioni presenti nel paragrafo.
[112] Nel paragrafo 3.2.3, “Il comprendere: enteropatia”, p. 104 e seg.
[113] Groppo M. ( a cura di ), Professione: educatore. L’operatore socio-psico-pedagogico, Vita e Pensiero, Milano, 1994, pp. 95 – 115.
[114] Svignano A., cit., pp. 29–49.
[115] Nanni C., La guida spirituale, in Scurati C. ( a cura di ), Volti dell’educazione, La Scuola, Brescia, 1996, pp.263– 291.
[116] Ibid., p. 268. Si sono evidenziate in corsivo le parole ritenute chiave.
[117] Ibid., p. 288.
[118] La proposta costruttivista spiega in questi termini le capacità di pensiero umane. Viene trattato anche nel paragrafo 3.2.3, “Il comprendere: enteropatia”, p. 104. Cfr anche nota 194.
[119] Bertolini P., Ragazzi difficili, La Nuova Italia, Firenze, 1993.
[120] Canevaro A, Chieregatti A., cit., p. 47.
[121] Ibid., pp. 44, 45.
[122] Ibid., p. 46.
[123] Nel paragrafo 2.1.1, “Alcune relazioni d’aiuto”, p. 40. e seg.
[124] Mi riferisco ad alcune lezioni del corso di Educazione degli adulti del prof. Desinan, a.a. 1999/2000.
[125] Bauman Z., cit.
[126] Alberoni. F., La speranza, Rizzoli, Milano, 2001.
[127] Ibid., p. 19 e seg.
[128] La differenza fra apprendimento e concettualizzazione viene approfondita in Caracciolo E., Diagnosi funzionale e accessment nel ritardo cognitivo: due facce della medesima medaglia, in Caracciolo E., Rovetto F., cit., p. 26. Qualora si verificasse un apprendimento passivo e mancante di riflessione e assimilazione critica, i concetti verrebbero solo temporaneamente incamerati, rendendo vano l’insegnamento.
[129] Alberoni F., cit., p. 43.
[130] Ibid., p. 204.
[131] Eccezione fatta per S.Agostino che non tramanda una semplice teoria, ma è lui stesso l’uomo che racconta Le Confessioni e che ha vissuto l’iter di conversione il quale può diventare emblematico per tutti gli uomini e per l’educando in particolare.
[132] Per la lettura della tripartizione della vita dell’uomo e il suo superamento, cfr Tramma S., cit.
[133] Bruner J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997.
[134] Il significato e l’etimologia del termine sono presentati a p. 37 del presente testo.
[135] Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, cit.
[136] La successiva caratterizzazione dell’autobiografia, della quale sono elencate le tre caratteristiche principali, è ricavata dalla lettura che ne dà Formenti L., cit..
[137] Benozzo A., Etnografia organizzativa: una proposta di metodo per l’analisi delle organizzazioni come culture, Cortina Editore, Milano, 1996.
[138] Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, cit. pp. 14 e seg.
[139] Demetrio D., Presentazione in Tramma S., cit., p. 14 e seg. La frammentazione dell’identità soggettiva e il ruolo dell’ “io tessitore” sono in realtà concetti che attraversano il testo nella sua totalità.
[140] Formenti L., cit, p. 63.
[141] Il termine deriva da “gruppo di ricerca sull’educazione degli adulti”, che si trova in Francia. Formenti L., La formazione autobiografica, pp. 47 – 53.
[142] Il convegno “Esplorare il mondo della vita” si è tenuto il 17 novembre 2000, presso la sede in via Tigor dell’Università degli Studi di Trieste, con la collaborazione dell’ “Associazione La Ricerca“ di Trieste.
[143] Giusti M., Il desiderio di esistere, La Nuova Italia Editrice, Scandicci, Firenze, 1999.
[144] Ibid., p. 5.
[145] Ibid., p. 6.
[146] Sono: Sotto l’occhio dell’orologio, di Christopher Nolan; Babette,Handicappata cattiva, di Elisabeth Auerbacher; Il mio piede sinistro, di Christy Brown; Vita !, di Claudio Imprudente; Nato così, di E. R. Carlson; Io, sirena fuor d’acqua, di Mirella Santamato.
[147] Giusti M., cit., p. 142.
[148] Ibid., pp. 147, 148.
[149] Tramma S., cit. Attraversa brevemente la storia dei concetti educazione e formazione, riferendosi in particolare al campo di lavoro con e per gli adulti. Negli anni ’70 la formazione era intesa come attività di carattere aggiuntivo; mentre all’educazione, fino ai tempi più recenti è stata attribuita facoltà compensativa, ritenuta per lo più rivolta agli svantaggiati. Oggi cambia il rapporto fra questi due concetti e si ritiene possibile considerare educazione e formazione come pratiche che si compensano vicendevolmente, ”…l’una comprende l’altra: l’educazione come azione specializzata...viene compresa all’interno del più vasto campo delle azioni formative o, viceversa, la formazione può venire compresa all’interno di una strategia educativa come azione specializzata, progetto delimitato e riconoscibile”, p. 50.
[150] De Natale, cit., pp. 78 – 88.
[151] Santerini M., Livelli di interpretazione della realtà, in Santerini M., cit.
[152] Magro G., Rossati A., Stress e burnout, Carocci Editore, Roma, 2000, pp. 68, 69.
[153] Nel testo di Magro - Rossati viene affrontata più da vicino la problematica del burnout negli insegnanti. Dal momento in cui i riferimenti specifici agli educatori extrascolastici sono esigui rispetto all’attenzione rivolta al corpo docente, ho ritenuto necessario ampliare il discorso al contesto educativo più ampio, oltre a quello scolastico, nel rispetto dello schema di base del libro, in cui, pur riferendosi più da vicino ad una particolare realtà, si considera il burnout “patologia tipica delle helping professions” in generale.
Questa precisazione vale in particolare per quanto riguarda le classificazioni di Maslach ed Edelwich – Brodsky che seguono.
[154]I nostri antenati primitivi dovevano prepararsi per utilizzare le energie necessarie alla lotta o alla fuga rispetto alle minacce esterne di natura fisica. Oggi l’uomo moderno conduce una vita in cui, per la società dell’Occidente in particolare, la lotta per la sopravvivenza e per il recupero dei beni primari è un pericolo superato.
[155] Le citazioni, mantenute così come si presentano nel testo, sono di Contessa (1981-82).
[156] Le successive elencazioni che caratterizzano il discorso sulla progettazione sono fatte in riferimento alla dispensa del corso di Didattica generale della prof. Grassilli B., Questioni di didattica generale. Azione didattica, Progettazione, Ricerca, a.a. 2000/01, pp. 16-22.
[157] Miodini S., Zini M.T., cit., pp. 27 – 34.
[158] Recenti studi in campo psicologico (Gardner, 1983 – Goleman, 1995) hanno messo in evidenza che non esiste un’unica forma di intelligenza, vale a dire quella cognitiva, ma si devono riconoscere le possibilità umane di esprimere le proprie capacità in diversa maniera. Gardner propone una nuova concezione dell’intelligenza, intesa non come facoltà unitaria, bensì come una pluralità di abilità distinte: esisterebbero più intelligenze. Egli individua sette varietà fondamentali: intelligenza linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, intrapersonale e interpersonale. Goleman arricchisce ulteriormente il lavoro di Gardner, il quale trascura un altro aspetto umano, restando ancora legato a un modello di mente ancora troppo cognitivo: per Gardner si deve tenere conto anche delle emozioni. Esiste un’intelligenza presente nelle emozioni, chiamata intelligenza emotiva - le cui caratteristiche fondamentali sono autoconsapevolezza ed empatia – che influenzerebbe tutte le altre, facilitandone l’espressione o interferendo con esse.
L’aspetto importante di questi studi consiste nell’acquisizione della consapevolezza, anche in ambito scolastico, che gli interventi educativi debbano mirare al riconoscimento e alla valorizzazione delle diverse intelligenze di ogni alunno-educando. Questa interpretazione rende ragione del fatto che l’uomo non è solo razionalità, ma anche sentimento, è capace di gusto estetico, musicale, in generale, di capacità espressiva.
[159] Rovetto F., Verso un approccio multimodale al trattamento del ritardo mentale, in Caracciolo E., Rovetto F., cit.
[160] De Natale, cit., pp. 129 – 206.
[161] Rossi B., cit., p. 129.
[162] Acone G., Scuola dell’impegno o del disimpegno axiologico e l’insegnamento come promozione dei valori, in Galli N., ( a cura di ) Quali valori nella scuola di stato, La Scuola, Brescia, 1989, p.125.
[163] Ibid., p. 128.
[164] Si fonda sul concetto di persona come soggetto unico irripetibile originale, capace di realizzare nel proprio ambiente i valori della civiltà etica, dell’arte, della scienza, della religione. A Trieste questa corrente è fortemente connotata anche di aspetti sociali e non è solamente rivolta al soggetto.
[165] De Natale, cit., pp. 109-118.
[166] Spranger E., La vita educa, trad.it., La Scuola, Brescia, 1969, p.25.
[167] Rossi B., Il genitore, in Scurati C., I volti dell’educazione, cit.
[168] Ibid., pp.11 - 45.
[169] Cfr. Paragrafo 1.1.3, p. 9 su Taylor. Entrambi gli autori fanno riferimento al contesto, connotato nel senso più drammatico, per orientare la riflessione sull’uomo: egli possiede il grande privilegio e potere di far fronte anche ai disagi più insormontabili, viste le potenzialità riflessive e interpretative.
[170] Scurati C., Volti dell’educazione, cit., pp. 121 – 152; 155 - 180.
[171] Ibid., p. 127.
[172] Ibid., p. 132.
[173] Ibid., p. 171.
[174] In “La relazione dal punto di vista dell’educando” cfr. cit. di Pellerey M., p. 31, nota 63.
[175] Groppo M., cit., pp 110, 111.
[176] Salomè J., cit., p. 110.
[177] Ibid, pp. 26 - 28, 48 - 58.
[178] Ibid, pp. 165 - 169.
[179] Dal testo di Salomè sono ricavati gli spunti per la rappresentazione degli schemi precedenti e seguenti, pp.76 – 79.
[180] Apel K.O., Personalismo sociale, Studium, Roma, 1979, p.50.
[181] Rossi B., Il genitore, in Scurati C., I volti dell’educazione, cit., pp. 28, 29.
[182] De Natale, cit., p. 44.
[183] Bauman Z., cit. pp. 96-97.
[184] Si rifà all’affermazione di Freud, il quale ritiene ogni società, ogni epoca si caratterizzino per aver vissuto forme particolari di paura.
[185] Salomè J., cit., p. 5.
[186] Canevaro A., Chieregatti A., cit., pp. 105 - 118.
[187] Ibid., p. 55.
[188] Ibid., p. 109.
[189] Per la lettura del pensiero di Dilthey , Weber e del costruttivismo cfr Corbetta P., cit.
[190] Corrente della quale fa parte Weber. Precisamente fa parte di uno dei due “blocchi storici” che lo costituiscono, risalente agli inizi del 900, chiamato “sociologia comprendente”, per sottolineare l’implicazione del tema della comprensione.
[191] Per la lettura del termine, oltre a Corbetta, cfr Grassilli B., Questioni di didattica generale, cit. e Formenti L., cit., pp. 89 – 120 ( da cui è stata tratta la citazione).
[192] Ne deriva un ulteriore contributo per scoprire i perché dell’individualismo: non è solo strumento che l’uomo usa per non mettersi in discussione ( come precedentemente evidenziato a p. 102, 103), ma è anche insito nella sua natura per il punto di vista unico attraverso il quale ognuno guarda il mondo.
[193] Rossi B., cit.
[194] Canevaro A., Chieregatti A., cit., p. 87.
[195] Ibid., pp. 90, 91.
[196] Krikemans A., Trattato di pedagogia generale, trad.it., La Scuola, Brescia, 1971, pp.67-68.
[197] Bastide G., Méditations pour une éthique de la personne, p. 191.
[198] Blezza F., cit., pp. 16, 43, 59.
[199] Ibid., p. 16.
[200] Bertolini P., L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze, 1988, p. 104.
[201] Salomè, cit., 88.
[202] Macchietti S.S., Pedagogia del personalismo italiano, Città Nuova Editrice, Roma, 1982, p. 66.
[203] Salomè J., cit., p. 53.
[204] Ibid., p. 1.
[205] Ibid., p. 14, nota 10.
[206] Mizzau M., Prospettive della comunicazione interpersonale Il Mulino, Bologna, 1974, p. 83.
[207] Alcuni spunti ( prospettiva contrattuale, modelli di analisi dei contenuti della comunicazione, i punti di vista di Ghiglione, Grice, Ader, Sternberg e Gardner e, nel paragrafo successivo, le funzioni del linguaggio non verbale) che rientrano nel presente discorso sulla comunicazione sono tratti dalla lezione su questo tema tenuta dalla prof. Sclaunich all’interno del corso di Didattica generale della prof. Grasselli, a.a. 2000/01
[208] Aranguren J., Sociologia della comunicazione, trad. it., Il Saggiatore, Milano, 1967, p. 138.
[209] Gusdorf G., Filosofia del linguaggio, trad it., Città Nuova Editrice, Roma, 1970, pp. 60 - 61.
[210] Rossi B., cit. p.34.
[211] Ibid., p. 36.
[212] Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, trad.it., Astrolabio Ubaldini, Roma, 1971, p.71.
[213] Rossi, cit., pp. 56 - 62.
[214] Gusdorf G., cit..
[215] Jaspers K., Filosofia, trad.it., UTET, Torino, 1978, p. 545.
[216] Orlando Cian D., Il primato della lingua come strumento di educazione, p. 84.
[217] Per la lettura degli studi di Skinner e Catania, cfr Caracciolo E.,Rovetto F., cit., pp. 114 - 127.
[218] Salomè, cit., pp. 130 - 132.
[219] Chieregatti, cit., pp. 159 -161.
[220] Salomè, cit., pp. 133, 134.
[221] Reale G., Antiseri D., cit., vol. 3, p. 719.
[222] Per la lettura di espressione e comunicazione, cos’ com’è presentata in questo paragrafo, ho fatto riferimento alle lezioni del corso di Filosofia del linguaggio del professor Lantier, a.a.1999/2000.
[223] Rossi B., cit., p. 42.
[224] Gusdorf G, cit, pp.60 – 61.
[225] Ong W. J., La presenza della parola, trad.it., Il Mulino, Bologna, 1970, p.334.
[226] Le citazioni sono ricavate da Grassilli, cit.
[227] Crepet P., Non siamo capaci di ascoltarli. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza, Einaudi Editore, Torino, 2001.
[228] Ibid., p. 84.
[229] Ibid., p. 28.
[230] Ibid., p. 5.
[231] Bocca G., Il volontario, in Scurati C., ( a cura di ) Volti dell’educazione, La Scuola, Brescia, 1996, pp. 185 – 219.
[232] Ibid., p. 185.
[233] Si è precedentemente fatto riferimento a proposito dell’autobiografia, p. 73, nota 142.
[234] Sono i temi trattati successivamente, nell’analisi dei dati.
[235] Cfr. paragrafo “Relazione d’aiuto con gli immigrati”, p. 51 e seg.
[236] In questo paragrafo e di seguito vengono presentati i concetti ritenuti fra i più rilevanti per le volontarie, intervallati da alcuni agganci – in corsivo – con la dimensione teorica della relazione d’aiuto, trattata nei precedenti capitoli.
[237] Cfr. paragrafo “Il presupposto della relazione d’aiuto: la libera adesione”, p. 20 e seg.
[238] Cfr. paragrafo “Il concetto di altro”, pp. 4, 5.
[239] Cfr. paragrafo “La ricerca di senso”, p 60 e seg.
[240] Cfr. paragrafo “La speranza”, p. 65 e seg.
[241] Cfr. paragrafo “ Burnout”, p. 80 e seg.
[242] Cfr paragrafo “ La relazione fra educatore ed educando”, p. 19 e seg.
[243] Cfr. paragrafo “Interdisciplinarietà e approccio solistico”, p. 87 e seg.
[244] Cfr. ibid, p. 87.
[245] Nel corso di tutto il testo si sottolinea la caratteristica peculiare della pedagogia di credere nelle possibilità di recupero e miglioramento umane: in questo senso “scommette sull’uomo” .
[246] Cfr. paragrafo “L’educatore come strumento”, p. 91.
[247] Cfr paragrafo “L’ascolto”, p. 96 e seg.,Il riferimento esplicito riguarda p. 99, fig. 4.
[248] Cfr. paragrafo “La comunicazione”, pp. 113, 114.
[249] Cfr. paragrafo “La comunicazione autentica di Rogers”, p. 122, nota 221.
[250] Sul ruolo e la portata del silenzio, fra gli altri riferimenti cfr. paragrafo “La scuola di Palo Alto”, p. 117.
[251] Cfr paragrafo “La scuola di Palo Alto”, pp. 116 – 118.
[252] Cfr. ibid., pp. 121, 122.
[253] Rossi B., Il volontario, in Scurati, cit., p. 184.
[254] Knowles M.S., cit, p. 50.
[255] Frabboni F., Guerra L., Cesare S., cit., p.16.
[256] De Natale M.L., cit., p. 210.
[257] Tramma S., cit., pp. 83 – 84.
[258] Demetrio D., Manuale di educazione degli adulti, cit.
[259] Alberoni F., cit., pp. 141 - 142.
[260] Tramma S., cit., p. 83.
[261] “La vita umana…prima meraviglia!” è un opuscolo che spiega che cosa accade durante gravidanza e come affrontare la gravidanza stessa, distribuito gratuitamente dal Centro alle donne che desiderano e abbisognano di conoscere il processo di crescita del piccolo, fin dal primo giorno di vita.
webmaster Fabio D'Alfonso