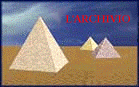
Stories
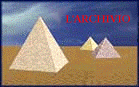 |
Stories |
Ultime ore di uno scienziato
di Paolo Alviti
Paolo Alviti
ULTIME ORE DI UNO SCIENZIATO
INTRODUZIONE
La tecnologia permea ogni aspetto della realtà attuale e rappresenta il principale elemento per definire la nostra epoca. La ricerca scientifica galoppa giorno dopo giorno con una rapidità senza precedenti, senza mai dare prova di segni di rallentamento. Ognuno avverte la forza impetuosa del vortice di innovazioni che avanza. Ognuno è costretto al continuo adattamento e alla perenne trasformazione, onde scongiurare d’esser travolti dalla dirompente e mutante affermazione del digitale.
Iniziata attorno alla metà del XX secolo, la rivoluzione digitale procede con velocità crescente e influenza radicalmente la nostra vita. In un brevissimo intervallo temporale, si sono compiuti avanzamenti enormi; e, purtroppo o per fortuna, nulla induce a pensare che questa serie di innovazioni sia destinata ad esaurirsi nel breve periodo.
Il mondo della tecnologia promette innovazioni sempre più sofisticate, sempre più capaci di allietare e alleggerire l’esistenza umana. Il digitale potrebbe consentire all’uomo di dedicarsi alle proprie inclinazioni, alle proprie aspirazioni e ai propri più sinceri interessi, sottraendolo agli oneri lavorativi. Potrebbe corroborare i rapporti interpersonali, potrebbe offrire un consistente contributo alla coesione dell’umanità, facilitando le comunicazioni, abbattendo le barriere spaziali e temporali, unendo la gente di tutto il globo. Potrebbe agevolare ogni minimo aspetto delle nostre vite: dalle più complesse questioni medico-sanitarie alle banali situazioni domestiche; dall’amministrazione della cosa pubblica alla gestione e alla produzione aziendale; dall’istruzione di ogni grado alla diffusione dell’informazione e pertanto alla tutela della democrazia; dalla sicurezza interna e alla lotta alle minacce estere, fino alla mobilità e ai trasporti. Ogni ambito della società umana è positivamente interessato dallo sviluppo tecnologico-digitale, al quale sembrerebbe che dovremmo abbandonarci con la più genuina serenità. Nell’avanzata della tecnologia parrebbe giusto riporre tutta la nostra fiducia, conviti di muoverci verso una nuova gloriosa epoca di illimitato benessere e di allettante prosperità.
Uno sguardo più attento, però, mette in evidenza anche i pericoli dell’evoluzione tecnologica, che, se non ben modulata, rischia di divenire causa di ruina per l’umanità. Come potrebbe essere impiegata per il bene comune, per il miglioramento delle nostre esistenze, per il rallegramento delle nostre vite, la tecnologia si potrebbe anche sfruttare per conseguire fini ben diversi da quelli sopra esposti. Del resto, non è difficile figurarsi uno scenario (forse in parte già coincidente all’odierna realtà) in cui ogni individuo sia un vero e proprio schiavo della tecnologia, dipendente dai dispositivi elettronici. Un mondo nel quale, non solo le mansioni fisiche, ma anche il lavoro intellettuale venga delegato alle macchine, determinando una graduale inesorabile atrofizzazione delle menti umane. Dipendente da questioni sempre più effimere, cieca dinanzi a fatti e temi veramente rilevanti e debolissima cognitivamente, l’umanità non sarebbe in grado di arginare l’ascesa di ristrettissime cerchie oligarchiche, intenzionate ad imporsi sulla moltitudine, senza che neppure questa, totalmente abbindolata da vacue questioni, possa rendersene consapevole.
Ma, al di là di scenari così drastici, non si può negare che lo sviluppo tecnologico incontrollato potrebbe, anche se in misura meno devastante, sgretolare la società umana, non adempiendo dunque al suo scopo primario ovvero di migliorarla questa nostra società. Gli effetti negativi della tecnologia si riscontrano già ai nostri giorni: si pensi, ad esempio, ai nuovi disturbi psichici e ai nuovi problemi sociali sviluppatisi con l’epoca digitale. Si pensi agli impieghi lavorativi che, al fine di incrementare l’efficienza produttiva, saranno affidati (e in parte già lo sono) alle macchine, a scapito di milioni di individui condannati a condizioni di vita precarie e indignitose, dopo essersi visti sottrarre la propria occupazione. Ma si pensi anche alle gravi conseguenze delle ore passate a farsi corrodere il cervello davanti a dispositivi elettronici di ogni tipo e in modo particolare dell’utilizzo sregolato dell’intelligenza artificiale, che, specie presso le nuove generazioni, sta gradualmente consumando le capacità critiche della gente.
Per queste, e per varie altre ragioni che in questa sede non risulta né opportuno né tantomeno necessario approfondire, si deve ammettere che gli innegabili vantaggi discendenti dall’innovazione tecnologica sono da comparare ai pericoli ad essa annessi e che la prosperità dell’umanità, nella nostra particolarissima fase storica, possa derivare solo dal giudizioso approccio alla tecnologia. Questo approccio coscienzioso deve partire non da capi politici, giganti industriali, grandi banchieri o ricchi armatori, ma dai comuni cittadini di tutto il mondo. Ogni individuo si renda consapevole dei pericoli associati ad un indomato progresso tecnologico, ne discuta, ne parli, ne metta in evidenza le contraddizioni, pur senza negare le opportunità evidenti che tale progresso tecnologico offre al genere umano.
Al fine di sollecitare le coscienze, si è scelto di narrare una vicenda sullo stimatissimo Guglielmo Marconi, orgoglio italiano e vincitore del Premio Nobel per la fisica nel 1909, date le sue scoperte nel campo delle radiazioni elettromagnetiche e in particolare data la creazione del telegrafo senza fili, antenato dell’odierna radio. Si propone una trattazione fantasiosa delle ultime ore dello scienziato, basata su un’attenta ricerca storico-biografica ma non per questo non pervasa da elementi evidentemente fantascientifici. Scritto in occasione del 150° anniversario dalla nascita del Premio Nobel, il fine principale del racconto è di indurre alla riflessione sulla tecnologia e sui suoi sviluppi, sui suoi vantaggi ma in particolar modo sui suoi pericoli, partendo da una narrazione pessimistica, tragica e pateticamente apocalittica.
Omnem autem sermonem tribuimus non Tithono ut Aristo Cius (parum enim esset auctoritatis in fabula), sed M. Catoni seni, quo maiorem auctoritatem haberet oratio. Si tratta di un passo tratto dal De senectute di Cicerone, il quale in tal modo informava il lettore di aver messo in bocca a Marco Porcio Catone (arcinoto personaggio della Roma repubblicana distintosi per costumi irreprensibili e severa sobrietà) la sua visione della vecchiezza, dichiarando di aver optato per questa scelta al fine di conferire maggiore autorevolezza all’opera. Come fece Cicerone con Marco Porcio Catone, per conferire ai miei discorsi maggior dignità, ho trasfuso il mio pensiero nella bocca dell’illustrissimo Guglielmo Marconi. Perciò, le riflessioni formulate dall’inventore nel racconto non devono considerarsi perfettamente fedeli alla visione delle cose dell’insignito scienziato.
Ciononostante, non si supponga che la totalità dei discorsi attribuiti al Nobel nella narrazione non siano supportati da fondamenta di verità.
Come è notorio, Guglielmo Marconi aderì al fascismo e dal fascismo ottenne anche diversi importanti incarichi. Pertanto, i grandi concetti di libertà, uguaglianza e fratellanza che spiccano dal racconto parrebbero antitetici alla sua figura. Il dibattito sulla sincerità del sostegno dello scienziato alla dittatura mussoliniana è, tuttavia, ancora aperto e la reale posizione di Marconi nei confronti del regime non è ancora ben chiara.
Sono diverse le fonti che supportano la tesi per la quale in realtà il Premio Nobel non nutrisse chissà quali simpatie per il movimento fascista e che vi aderì forse per continuare a condurre esperimenti in un clima sereno. Forse, come molti altri onesti italiani degli anni Venti, fu travolto dal carisma trascinante del duce, nella cui figura intravide una facile risoluzione della grave crisi che aveva investito l’Italia e l’Europa dopo la Grande Guerra. Nelle affermazioni pubbliche il Duce del Fascismo aveva varie volte elogiato Marconi, accostandolo persino all’Alighieri ed ergendolo così ad emblema del genio italico.
Anche l’inventore aveva speso parole di lode nei confronti di Mussolini, riconoscendogli il merito di aver saggiamente ottimizzato le energie del Paese, rendendo nuovamente grande l’Italia.
Ancorché questo fosse il rapporto pubblico fra Marconi e il fascismo, nel contesto privato sembra che lo scienziato non si privasse di rivolgere al regime pesanti critiche. Le figlie hanno raccontato che in famiglia non aveva esitato a definire gli squadristi come dei violenti facinorosi. Inoltre, sembra che, alla luce della piega spaventosa che stavano assumendo le dittature fasciste in Europa, abbia espresso preoccupazione sull’impiego della radio da parte dei governi totalitari, giungendo a domandarsi se la sua invenzione fosse stata veramente un bene per l’umanità. Contrariamente all’ideale di perfetto cittadino che la propaganda nazionalista e isolazionista fascista andava propugnando, pur avvertendo un intenso legame con la patria, Marconi era proiettato anche verso il resto del globo. Si oppose all’espansione coloniale in Etiopia ed era fautore di una politica estera filo-britannica, dato il suo rapporto particolare con il mondo anglosassone e in particolare dati i suoi interessi con gli inglesi. Inoltre, Marconi fu avverso alle politiche filotedesche e privatamente sembra che si sia adoperato per favorire gli individui che subivano persecuzioni di stampo razziale. Egli morì prima di vedere promulgate le terribili leggi razziali del 1938, che, secondo alcuni, lo avrebbero posto in una posizione delicata. Marconi, dunque, elogiò il fascismo quando in Italia ogni atto politico non poteva essere null’altro all’infuori della lode al fascismo, morendo prima del ripristino della democrazia, in seguito al quale forse si sarebbe pronunciato con maggior durezza nei confronti del regime mussoliniano. In definitiva, l’accostamento di valori tipicamente antifascisti (democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza ecc.) e la figura di Guglielmo Marconi non si può considerare incoerente.
Come suggerisce il titolo, in aggiunta al tema tecnologico, nella narrazione spicca anche un altro rilevante argomento: la morte e la precarietà della vita.
Dopo aver ricevuto sconvolgenti istruzioni, Marconi diventa emblema dell’immobilismo esistenziale, per il quale l’uomo fatica a distaccarsi dall’abituale situazione di tranquillità per seguire la strada della giustizia e del bene comune; o più semplicemente per seguire la tortuosa via al termine della quale giace la propria vera felicità.
L’uomo è avvezzo ad attribuire insensata rilevanza ad aspetti futili dell’esistenza, trascurando le questioni veramente significative per il benessere suo e del prossimo. Agli impegni ai quali ci si dovrebbe dedicare, si preferiscono gli inconsistenti affari materiali, tralasciando il perseguimento del bene comune e la cura dell’anima. Alcuni uomini, tuttavia, comprendono la precarietà della vita e la minaccia incombente della morte. Quindi, sfruttano efficacemente il tempo che hanno a disposizione, non per gli effimeri godimenti superflui, ma per il perfezionamento di sé stessi e per il miglioramento della società, i due più alti impieghi praticabili dall’uomo e ai quali l’uomo in quanto uomo dovrebbe votarsi. Così i raziocinanti adoperano la loro breve e imprevedibile esistenza.
Gli stolti invece vivono nella superficialità e sperimentano una falsa serenità. Si credono felici e realizzati, ma sono solo ciechi che vivono nel piacevole buio dell’ignoranza. Esiste però anche la categoria dei desti, che, pur facendo parte dei ciechi, sono abbastanza savi da capire la vacuità di ciò che rincorrono, ma non sufficientemente da applicare questa consapevolezza alla propria esistenza. I due impieghi di cui si è detto vengono rimandati da costoro alla vecchiezza, un’età della vita a cui non tutti giungono e a cui essi stessi non dovrebbero essere sicuri di giungere, destinando il resto dell’esistenza ad attività spaventosamente insignificanti.
Ecco che il Marconi del racconto diventa emblema dell’immobilismo umano: sicuro di avere davanti a sé ancora molti anni, tentenna, vagheggia e farragina, fino a che la morte non lo stronca d’improvviso e gli strappa barbaramente la facoltà d’agire. Si redime solamente negli ultimi istanti di vita, ma ormai è troppo tardi: egli viene giudicato non più capace di intendere secondo ragione e ciò che blatera sul letto di morte lì rimane. L’inventore, dunque, muore senza avere corroborato le coscienze sullo sviluppo indomato della tecnologia, senza avere contribuito nel massimo delle sue possibilità al miglioramento della società umana, senza avere quindi conseguito il suo fine di essere umano.
ULTIME ORE DI UNO SCIENZIATO
Il sole stava tramontando quella calda sera del 19 luglio 1937, mentre Guglielmo Marconi si adagiava sulla poltrona del buio salotto di casa sua. Era stanco e attendeva che la cena fosse pronta. Nell’attesa si mise a fantasticare sull’argomento che sin dagli anni della giovinezza aveva attratto maggiormente il suo interesse: la scienza. Rifletteva sulle microonde, sulle quali vagheggiava di condurre nuovi esperimenti.
Era un uomo non molto anziano, che cominciava a dare gravi segni di cedimento fisico, a causa soprattutto delle crisi cardiache che lo avevano colpito negli ultimi tempi. Eppure, il Premio Nobel, presentato dal regime fascista come emblema assoluto del genio italico, conservava vivissima e ardente la febbrile tendenza alla ricerca della Conoscenza.
La giornata trascorsa era stata ordinaria e non particolarmente stancante, ma Marconi aveva ugualmente bisogno di riposo. Tale necessità lo spinse ad abbandonare le questioni scientifiche e ad accendere la radio posta sul tavolinetto al centro del salotto. Sospirò, si mise comodo e cercò di liberare la mente dai pensieri. Per qualche minuto si distrasse dalla scienza, dagli affari politici, dalle questioni familiari, insomma, dalla sua stessa vita. Poi la sua attenzione fu catturata da uno strano rumore, un suono stridulo e graffiato, che dopo un attimo svanì, lasciando spazio ad una voce misteriosa, proveniente nientemeno che dalla radio che poco prima aveva acceso.
«Carolo Augusto piissimo, a Deo coronato, magno et pacifico Imperatori Romanorum, vita et victoria!», disse la voce, con tono solenne e ampolloso. Il latino infuocò l’interesse dello scienziato, che constatò che le parole che aveva udito erano dovevano essere state pronunciate da Papa Leone III, durante l’incoronazione di Carlo Magno a imperatore dei Romani.
Pensò che si trattasse di una semplice trasmissione radiofonica: forse era un documentario sull’Impero Carolingio o forse un radiodramma incentrato sulla vita del grande sovrano franco. No, era qualcosa di diverso, che esercitava sul nostro inventore un’inspiegabile attrazione.
«Tu quoque, Brute, fili mi!». La voce aveva parlato di nuovo. Questa volta pareva stanca e impaurita, ma al tempo stesso fieramente orgogliosa e virile. Marconi identificò subito il padre di quelle parole: era Giulio Cesare, che in punto di morte si rivolgeva al presunto figlio Bruto, il quale capeggiava la congiura contro di lui. La voce era così realistica che lo scienziato faceva fatica a credere che si trattasse di mera finzione, sembrava che provenisse direttamente da un’altra epoca!
«Deve essere finzione…non può essere reale. Che strano…sarò semplicemente stanco. Eppure, sono così convinto che dietro queste frasi non vi siano degli abili attori…è come se i grandi della Storia si stessero catapultando in casa mia!», si ripeteva lo scienziato. Un attimo dopo, la voce si fece sentire ancora.
«Eppur si muove!». Riconobbe il collega Galileo Galilei, che, dopo l’abiura dell’eliocentrismo, sottovoce aveva pronunciato queste parole, guardando al cielo e riferendosi al moto della Terra intorno al Sole. Le parole erano così autentiche che sembravano fuoriuscire dalla bocca dello stesso Galileo dinanzi al tribunale dell’Inquisizione.
Istante dopo istante, Marconi era sempre più convinto che, per qualche arcana ragione, la radio doveva essersi trasformata in qualcos’altro. Non si trattava più del mezzo di comunicazione capace di trasmettere informazioni sonore attraverso onde elettromagnetiche, ma di uno strumento in grado di connettere le epoche.
Marconi sentì le esclamazioni gioiose dei marinai di Colombo quando videro le coste delle Americhe. Poi ascoltò le grida festose del popolo di Francia in occasione della decapitazione di re Luigi. Sentì Garibaldi tuonare «qui si fa l’Italia o si muore!», rivolgendosi a Calatafimi a Nino Bixio, per incoraggiarlo a seguitare il feroce combattimento contro le forze borboniche. Assistette al dialogo maieutico che Socrate aveva allestito con un suo allievo nell’agorà dell’Atene classica. Udì il generale Gengis Khan proferire istruzioni al suo esercito prima dello scontro con il nemico. E poi ancora: sentì Alessandro motivare le sue truppe a Gaugamela; Enrico IV implorare il perdono papale alle porte del castello di Canossa; il Profeta Maometto raccogliere proseliti a Medina; l’apostolo Pietro reclamare una fine più miserabile del supplizio che aveva stroncato il suo Maestro; Urbano II inveire contro i mussulmani mentre indiceva la prima crociata in Terrasanta.
Marconi era ormai convintissimo: la radio lo stava facendo viaggiare nel tempo. Una leggerezza che mai aveva sperimentato prima lo stava d’improvviso investendo dolcemente. Gli pareva che della sua persona fosse rimasto solo lo spirito, come se le componenti corporee si fossero tutte d’un tratto smaterializzate. Poteva assistere così da vicino ad eventi così lontani e ciò lo affascinava oltre ogni misura.
Mai prima di allora aveva provato la sensazione di immensità che in quel momento lo stava travolgendo. La curiosità di un uomo, che aveva consacrato la sua stessa vita alla ricerca della conoscenza, riemergeva trionfalmente. Il vagare fra i secoli come itinerante temporale, mosso soltanto dall’amore immenso per i godimenti spirituali derivanti dalla ricerca disinteressata del sapere, era per il nostro scienziato cagione di incommensurabile piacere.
Lo stato di gaia beatitudine nel quale Guglielmo era felicemente sprofondato svanì, tuttavia, bruscamente, quando si udì provenire dalla radio un rumore simile a quello che aveva preceduto le parole di Leone III.
Subito dopo, la voce si riprendeva la scena nel salotto di casa Marconi. «Guglielmo…», disse sussurrando, «ascolta…». La voce aveva assunto un tono ancora più misterioso. Era trepidante e incupita. Alzando il proprio timbro, la voce prese a parlare molto velocemente. Era evidente che l’interlocutore avesse poco tempo a disposizione.
«Guglielmo, ti parlo dall’anno X. Morte, caos, desolazione, schiavitù sconvolgono il nostro mondo. Gli uomini hanno abusato della scienza. Il progresso tecnologico ha intrapreso una strada spaventosa. Sono state fabbricate armi dalla colossale potenza distruttiva e macchine sempre più sofisticate.
Tutti erano convinti che mai le macchine avrebbero svolto mansioni diverse da quelle che gli avrebbe imposto l’intelletto umano. Tutti erano convinti che per l’eternità le macchine sarebbero state sottomesse all’uomo e alle sue esigenze. Ma non fu così.
Le macchine si dotarono di intelletto autonomo e cominciarono a provare sincere emozioni. Superarono gli uomini e si ribellarono. Ne seguì una guerra dalla portata senza precedenti.
Le macchine si allearono tra loro e formarono un unico potente fronte comune. L’arroganza degli uomini invece gli impedì di unirsi insieme, e, divisi, furono deboli. Fu un tremendo massacro. Le macchine schiavizzarono i superstiti.
Da allora gli uomini si alzano ogni mattina per raggiungere giganteschi complessi industriali. Lì lavorano incessantemente e producono sotto la dura e insensibile supervisione delle macchine. Non godono dei frutti del loro sudore: le loro fatiche non servono solo a soddisfare le esigenze dei loro padroni. Il regime delle macchine li dota di un misero salario, che consente loro solo di provvedere alla compera dei beni di essenziale necessità, e di piccole abitazioni anguste e scomode, alle quali gli uomini fanno rientro in serata, dopo l’estenuante giornata di lavoro. Al rientro, sono così distrutti che non hanno nemmeno le forze per ricordarsi della serenità di cui godevano nell’età della supremazia degli uomini.
Come gli uomini avevano tentato di prevaricare sulla natura e sui propri simili, le macchine pretendono ora di dominare sugli uomini, sulle quali vite hanno instaurato un regime di soffocante controllo.
Per rafforzare la propria egemonia, hanno costruito nemici inesistenti, ai quali vengono addossate le colpe dei peggiori misfatti. Gli uomini vengono esonerati dal durissimo lavoro nelle fabbriche soltanto in alcuni giorni particolari, nei quali vengono allestite dal governo delle giornate di celebrazione e di ringraziamento dei capi macchinisti, per le loro falsa benevolenza e per la loro finta generosità.
Gli uomini guardano queste giornate come gli unici momenti di riposo dalle laceranti fatiche del lavoro. Pertanto, sono ben contenti di esaltare le macchine che li dominano, senza chiedersi se il governo macchinista sia con loro veramente benevolo e generoso. L’informazione non è libera, la cultura è vittima di una censura terrificante e gli uomini non sono più in grado di pensare in modo autonomo.
La propaganda macchinista ha inquinato la mente degli uomini, a tutto vantaggio dei nuovi dominatori del globo. La grande opera di avvelenamento delle menti è stata così meticolosamente architettata che gli uomini sono ora sinceramente convinti che le loro esistenze siano perfette e felici, talmente perfette e felici da non poter essere ulteriormente migliorate.
Gli uomini, insomma, giudicano grandiose le indignitose e precarie condizioni di vita a cui sono costretti dalle macchine. Si spingono persino a ringraziare le macchine stesse che li privano della dignità per la loro fantomatica magnanimità. Gli uomini sono giunti addirittura a venerare i propri carnefici con disarmante ossequio, con la stessa devozione con cui voi antichi adoravate un tale che si faceva chiamare Dio.
In tal modo soggiogati, gli uomini non potevano certo rendersi conto da soli della gravità della condizione nella quale versavano.
Non tutte le macchine erano però d’accordo col sistema di sfruttamento dell’umanità. Allora i vertici del potere macchinista giustificavano le peggiori malefatte ai danni della specie umana, sostenendo che, come gli uomini per secoli avevano sfruttato con barbarie e senza farsene alcuno scrupolo la natura e gli altri uomini, ora era diritto della macchine fare altrettanto.
Ciononostante, si formò un piccolo nucleo di macchine che non accettava la crudeltà della sottomissione degli uomini alle macchine. Queste macchine eterodosse costituirono la Congrega, un movimento globale di resistenza, che intendeva costruire un nuovo mondo democratico, fondato sulla collaborazione pacifica di uomini e macchine, affinché si potesse garantire il benessere di tutti, e non solo di alcuni.
Mosse dalla compassione per l’umanità sfruttata, le macchine congreghiste avevano compreso che, come alcuni uomini avevano sottomesso altri uomini e le macchine stavano sottomettendo gli uomini, alcune macchine avrebbero, presto o tardi, sottomesso altre macchine.
Consapevoli dell’incapacità di un’autonoma emancipazione degli uomini, le macchine congreghiste hanno stilato una lista di un centinaio di esseri umani, che si giudicavano meno indottrinati rispetto al resto della moltitudine. Le congreghiste hanno aperto loro gli occhi sull’ingiusto ordine globale macchinista.
Assimilata la componente umana, la Congrega cominciò una lotta di resistenza attiva contro il governo macchinista. Furono compiuti attentati ai danni delle macchine più illustri e degli edifici istituzionali più rilevanti. Si sperava così di raccogliere proseliti, sia fra le macchine sia fra gli uomini. Ma accadde il contrario: le macchine fedeli al macchinismo cadute negli atti di resistenza congreghisti vennero innalzate al rango di martiri e sia le macchine che gli uomini si convinsero della malignità degli intenti della Congrega.
Da tempo a conoscenza dell’esistenza del movimento sovversivo, le autorità macchiniste avevano deciso di studiarlo attentamente senza intervenire, nell’attesa del momento più adatto per stroncarlo alla radice, scongiurandone ogni possibile nuovo affioramento. Usciti allo scoperto durante il periodo degli attentati, le macchine e gli uomini congreghisti presero ad essere perseguitati dalla polizia macchinista.
Il governo presentava la campagna di repressione della Congrega come una gloriosa opera antiterroristica, indispensabile per assicurare a uomini e macchine un futuro sicuro e tranquillo. I membri della Congrega venivano stanati, processati a porte chiuse ed infine condannati, senza avere diritto ad alcuna difesa legale.
I congreghisti venivano barbaramente giustiziati in pubblica piazza. Adorati sia dalle macchine incoscienti dell’esistenza di una ristretta cerchia oligarchica attaccata gelosamente al potere sia dagli uomini inconsapevolmente sottomessi, i cruenti spettacoli potevano essere seguiti anche a distanza: le esecuzioni capitali venivano infatti trasmesse in diretta su ogni tipo di dispositivo elettronico.
Le macabre attrazioni erano diventate un eccellente strumento di controllo delle masse e di monito per tutti coloro a cui fosse balenata nella mente una qualche anche minima azione per esautorare il totalitarismo costituito. La Congrega, arrivata a contare un migliaio di unità, ora, pochi mesi di persecuzioni, è ridotta a tre dozzine di machine.
Io sono l’ultimo uomo della Congrega. Mi trovo a Macchinopoli (che ai tuoi tempi si chiamava Roma), nel cuore del quartier generale della polizia macchinista, ove è conservato l’ultimo strano strumento d’antiquariato che voi chiamate radio e che pare sia derivato dal tuo genio. Sono stato accompagnato qui dalle ultime macchine congreghiste, che stanno eroicamente combattendo contro gli agenti macchinisti, cercando di garantirmi quanto più tempo possibile per parlare con te. Ritenendo oramai impossibile sovvertire l’ordine stabilito, date le avanzatissime tecnologie delle quali il governo delle macchine dispone, per reprimere ogni forma di eterodossia, ci giochiamo disperatamente l’ultima carta in nostro possesso, per costruire un mondo di giustizia e libertà: cambiare il passato.
Se il vostro progresso tecnologico sarà giudizioso, sarà possibile costruire un mondo nel quale le fatiche dell’uomo saranno attenuate dalle macchine, che però non dovranno mai prendere il sopravvento. Che l’uomo sia illuminato dalla ragione, mentre provvede al progresso della scienza; che sia consapevole dei rischi della tecnologia; che si renda conto, prima che diventi troppo tardi, del disastro verso cui l’umanità si sta inesorabilmente dirigendo.»
«Guglielmo!», udendo il suo nome il nostro scienziato rabbrividì, «ora mi rivolgo a te, l’ultimo baluardo per la libertà degli uomini. Io e le congreghiste cadremo oggi, sopraffatti dalle forze macchiniste. Dopo di noi, mai più un uomo o una macchina della mia epoca si connetterà al passato per comunicare all’umanità del tuo tempo la catastrofe verso la quale sta amenamente andando incontro, come io sto facendo adesso. Dopo di noi, non esisterà più nessuna Congrega, nessun movimento di liberazione, nessuna possibilità di salvezza. Esisterà solo il governo macchinista, che imporrà definitivamente il regime di sottomissione degli uomini alle macchine e di alcune macchine ad altre macchine. E gli assoggettati non saranno neppure consapevoli di essere tali.
Ti chiedo, ti imploro, ti scongiuro di farti promotore di una grande campagna di sensibilizzazione degli uomini sui pericoli della degenerazione del progresso tecnologico incontrollato. Se gli uomini non si fossero spinti mai al punto di far sviluppare alle macchine un intelletto indipendente e un’anima propria, l’ordine mondiale vigente nella mia epoca non si sarebbe mai neppure costituito. Se non fallirai, senza che nessuno se ne accorga, il mio mondo tornerà d’un tratto alla medesima condizione in cui versava quel fatale giorno in cui la prima macchina trovò la forza di ribellarsi all’uomo, mentre il tuo mondo eviterà di piombare nel disastroso stato verso il quale galoppa inconsciamente.»
«Il mio tempo è finito. Arrivano a prendermi. Fa quello che devi. Addio».
Nel salone dello scienziato risuonò forte il rombo di un colpo d’arma da fuoco e bruscamente la radio si spense.
Marconi era pietrificato. Era impaurito e tormentato da incessanti domande. Perché doveva essere lui a farsi carico del destino dell’umanità? Perché doveva farsi carico di un peso cotanto gravoso? Perché non era stato scelto qualcun altro?
Cercava di darsi qualche risposta. Doveva essere stato scelto poiché era un grande inventore, stimato a livello internazionale e dotato di una certa influenza sulla comunità scientifica globale. Eppure, pensava che sarebbe stato più saggio rivolgersi alla guida politica di un grande Paese. Ad esempio, il primo ministro inglese Chamberlain doveva avere mezzi più adatti per l’impresa rispetto ad uno scienziato italiano, che, ancorché non si potesse dire povero, non navigava nell’oro. Perché allora quell’uomo del futuro e quella dannata Congrega avevano scelto di attribuire a lui il delicato compito? Non riusciva a darsi una risposta che lo soddisfacesse.
Le ricerche che aveva condotto per tutta la vita avevano avuto un fine preciso: dovevano unire le genti e migliorare le loro esistenze. Pur mostrandosi sempre modesto e umile, andava fierissimo delle sue invenzioni, specie quando le tecnologie derivanti dal suo genio avevano salvato vite umane.
Raccontava con orgoglio della vicenda dei superstiti della tragedia del Titanic, i quali furono accolti da lui personalmente al porto di New York, al momento del loro rientro in terraferma. In quell’occasione, gli venne mostrata immensa riconoscenza: il segnale d’aiuto era stato lanciato dalle gelide acque oceaniche proprio attraverso il radiotelegrafo, figlio del genio di Marconi.
Convinto dell’autenticità della voce che dal futuro gli aveva parlato, come poteva abbandonare l’umanità al proprio triste fato? Dopo aver consacrato la vita al bene degli uomini, come poteva non rispondere alla disperata richiesta d’aiuto di un uomo morto invocandola?
Le sue invenzioni avevano aiutato l’umanità e ora doveva impegnarsi affinché la scienza restasse asservita all’uomo. La degenerazione della tecnologia andava scongiurata. La caduta della civiltà umana si poteva evitare solo grazie a lui. Aveva deciso di credere alle parole dell’uomo che si era connesso alla sua radio. Voleva salvare l’umanità!
Giunto a tale conclusione, cominciò a riflettere sulle parole che aveva udito, iniziando a porsi altre destabilizzanti domande.
La prima fu la più genuina: erano autentiche le voci dei grandi della Storia che aveva sentito attraverso la sua radio? Si convinse che fossero reali e che avesse realmente peregrinato tra i secoli, supponendo che la Congrega dovesse aver voluto catturare la sua attenzione mediante quel suggestivo viaggio temporale.
Si chiese perché le macchine congreghiste avrebbero sperato che nel passato un grande scienziato sensibilizzasse gli uomini, per impedire lo sviluppo dell’intelletto autonomo e dello spirito emotivo delle macchine e conseguentemente per evitare l’emancipazione delle stesse.
La questione gli parve illogica. Se prima si era fortemente convito della veridicità dell’esperienza che aveva vissuto, per un istante questa convinzione si sbriciolò e credette che tutto fosse stato prodotto solo dalla fantasia di un uomo stanco.
Poco dopo sciolse il nodo e trovò una risposta alla domanda che lo aveva messo in crisi.
Partì da un presupposto: l’individuo (uomo o macchina) consiste del suo intelletto e della sua anima, non del suo corpo materiale, i quale è solo un ammasso di sostanze organiche per gli uomini e un aggregato metallico per le macchine.
Ormai consapevoli di essere state vinte dal regime macchinista e abbandonata ogni speranza di detronizzarlo, le congreghiste si dovevano essere ritrovate dinanzi a una scelta: consegnarsi al governo delle macchine o combattere un’ultima volta per la loro nobile causa. Entrambe le soluzioni portavano alla loro dipartita: o sarebbero state eliminate dal governo o sarebbero morte combattendo.
Anche se, contro ogni previsione, fossero sopravvissute al combattimento, le loro capacità intellettive autonome e la loro esperienza sensoriale sarebbero cessate di esistere improvvisamente e sarebbero perciò ugualmente perite. Quel loro combattimento era infatti finalizzato ad assicurare all’uomo loro alleato il tempo necessario per comunicare con Marconi, che, seguendo le istruzioni impartitegli, avrebbe determinato ad ogni modo lo svanimento improvviso della loro autonomia intellettiva ed emotiva.
Dovevano, quindi, aver scelto la strada moralmente più giusta, sperando forse di rendere immortale il proprio sacrificio. Speravano forse che Marconi avrebbe raccontato agli uomini del suo tempo della loro gloriosa lotta per la libertà. Anche l’uomo che parlava alla radio doveva desiderare che la sua appassionata azione di resistenza contro il governo macchinista avrebbe ottenuto un qualche riconoscimento, se non nel suo mondo, quantomeno fra gli uomini dell’epoca di Marconi.
Questa riflessione ne indusse un’altra più pratica: sarebbe stato opportuno raccontare dell’esperienza vissuta e dei fatti appresi quella sera?
Marconi pensò che sarebbe stato più saggio tacere e tenersi tutto per sé. L’opinione pubblica non avrebbe creduto a una storia così assurda. La collettività lo avrebbe rapidamente bollato come folle. Non poteva permetterselo. Doveva impedire che sfumassero la sua autorevolezza scientifica e il suo prestigio sociale: infatti, come avrebbe potuto a quel punto adempiere al compito che gli era stato assegnato?
Decise quindi di non proferire parola su ciò che gli era accaduto quella sera, neppure con la famiglia e gli amici più cari.
Fatto sta che il suo animo era confuso e travagliato. Ancora non realizzava veramente che cosa gli fosse successo. Fino a poche ore prima non poteva neanche immaginare di ritrovarsi in una simile situazione. D’un tratto si ritrovava investito di un incarico enorme. Non era sicuro di essere in grado di sopportarne il fardello. Era costretto alla struggente consapevolezza del triste destino dell’umanità, schiacciato dalla sua altissima responsabilità. Era l’unico che poteva tentare di risollevare le sorti degli uomini.
Quando Marconi si mise a tavola per la cena, era passata una mezzoretta dal momento in cui quella strana voce aveva parlato. Il nostro scienziato era poco affamato e appariva visibilmente turbato. Ignara della surreale esperienza che aveva vissuto il consorte, sua moglie, la marchesa Cristina, cercò di distrarre Guglielmo dalla causa del suo turbamento a lei ignota.
«Non mi hai più raccontato dell’incontro di sabato col Papa. Come è andato? Dicono che abbiate discusso degli ultimi sviluppi della radiotelegrafia».
«In realtà, non abbiamo parlato solo di questo», rispose Marconi in modo freddo e laconico.
«Di che avete parlato allora?», controbatté con dolcezza Cristina.
«Inizialmente abbiamo parlato di quello che hai detto tu. Poi però gli ho voluto dire del mio progetto di lasciare l’Italia. Gli ho detto che voglio trasferirmi a Londra».
«Come mai hai ritenuto che fosse una buona idea rivolgerti al Santo Padre per discutere di una questione così… insomma… così mondana?».
«Ambrogio è un uomo saggio e giusto. Per me non è solo il capo della Chiesa, ma anche un caro amico. Più volte mi ha dimostrato affetto e comprensione».
Guglielmo non voleva parlare e appariva infastidito dalle domande della moglie. Problemi dalla ben più alta levatura impegnavano la sua mente. Ma Cristina non demordeva, non sopportava che il marito fosse così visibilmente turbato da quello sconosciuto tarlo interiore. Voleva liberarlo dal tormentoso affanno.
«Hai detto al Papa anche perché vuoi andare a Londra?».
«Gli ho spiegato che voglio ricongiungermi con mia figlia Degna. Gli ho detto del dissidio che ho avuto col direttore White e della sua intenzione di ridimensionare il mio ruolo nella Società che porta il mio stesso nome. Il Pontefice ha convenuto con me che l’unico modo per superare le conflittualità sia andare a Londra, per discutere a fondo con i dirigenti della Società Marconi. Gli ho parlato delle mie non eccellenti condizioni di salute e del divieto di lasciare Roma impostomi dai medici, a cui gli ho detto che, come sai, ho intenzione di disobbedire, partendo per l’Inghilterra non appena sarà terminato il nostro soggiorno a Viareggio. Alla fine dell’udienza, il Papa mi ha dato la sua benedizione e mi ha augurato buona fortuna per il futuro».
Guglielmo sperava che l’interrogatorio fosse finalmente terminato e che si sarebbe potuto concentrare sulla questione che da poco meno di un’ora era diventata la più importante della sua vita.
La marchesa però gli pose un’altra domanda: «Invece, per quanto riguarda quel tuo incontro di domani pomeriggio col Duce, che mi dici?».
«Altro non sarà che un’ordinaria udienza, che devo tenere in quanto Presidente della Reale Accademia e del Consiglio Nazionale della Ricerca. Insomma, nulla di veramente significativo».
«Guglielmo, invece, come ci organizziamo per domani? Ti ricordi che devo raggiungere Elettra a Viareggio?».
«Sì, sì, me lo ricordo bene, come potevo dimenticarmi della mia beniamina». Solo udendo pronunciare il nome dell’adorata figlioletta, a Guglielmo brillò con tenerezza l’unico occhio buono che gli era rimasto. Subito dopo, lo scienziato tornò alla freddezza di cui aveva dato prova fino a quel momento.
«A mezzogiorno ti accompagno alla stazione. Io vi raggiungo mercoledì».
«Va benissimo, allora a mezzogiorno alla stazione».
Guglielmo non rispose. Data l’aridità delle risposte che il consorte continuava ad abbozzare, Cristina si rassegnò e lo lasciò ai suoi pensieri. Sulla sala da pranzo calò un silenzio tombale.
Verso le undici i due si misero a letto. Cristina ritentò invano di coinvolgere Guglielmo in una conversazione. Accorgendosi che il marito seguitava a risponderle in modo annoiato e contrariato, dopo qualche minuto, tacque e si voltò, dando le spalle al consorte, il quale era così immerso nei suoi pensieri che forse neppure se ne accorse.
Il progresso tecnologico doveva procedere sotto l’attenta supervisione dell’uomo. Doveva restare asservito al benessere dell’umanità e non doveva condurla all’autodistruzione. La tecnologia era nata come strumento per soddisfare le necessità degli uomini e tale doveva rimanere. Ma per i grandi gruppi industriali l’incontrollato progresso tecnologico rappresentava una fonte di eccellenti profitti.
Ma come Marconi si sarebbe potuto schierare contro gli interessi della grande industria?
Le istruzioni che gli erano state impartite erano vaghe e poco chiare. L’uomo del futuro aveva parlato di una campagna per affermare la consapevolezza che dallo sviluppo scientifico possono derivare gravi conseguenze, scongiurabili solo attraverso un approccio ragionato e moderato alla tecnologia e alla sua evoluzione.
Cosa avrebbe dovuto fare? Scrivere per qualche giornale? Manifestare in piazza? Rivolgersi a Mussolini? Allestire una trasmissione radiofonica? Non sapeva da dove cominciare.
Intanto che noi siamo stati a raccontare degli interrogativi che tormentavano il nostro scienziato, si erano fatte le undici e mezza e il sonno aveva sopraffatto l’anziano inventore.
Al risveglio si sentì di nuovo schiacciare dal tremendo senso di impotenza che lo aveva assillato la sera precedente.
Durante tutta la mattina, fu inquieto e pensieroso. A mezzogiorno accompagnò la marchesa Cristina alla stazione Termini. Si recò poi alla Farnesina, ove disbrigò alcuni affari per la Reale Accademia. Dopodiché, incontrò l’amico Solari, che notò una certa debolezza nel compagno di vecchia data. Rientrò poi a casa, in via Condotti. Nel pomeriggio ricevette l’avvocato d’Amelio. Verso le cinque gli fece visita il segretario Di Marco, che gli portò alcune lettere da firmare. Quando Di Marco arrivò, Marconi era debole e stava poco bene. Il suocero provvide a chiamare il dottor Pozzi, mentre Di Marco si affrettò ad annullare il colloquio con Mussolini, che si sarebbe tenuto intorno alle sei.
Non più di un’ora dopo, Arnaldo Pozzi raggiunse l’abitazione di Marconi, le cui sofferenze erano state nel frattempo alleviate dall’infermiera che alloggiava in casa, dato il debole stato di salute dello scienziato. Pozzi visitò l’inventore e constatò che era stato colpito da una nuova crisi cardiaca. Il medico rassicurò Di Marco, spiegando che si trattava di un attacco molto più docile rispetto a quello del maggio precedente. A tarda sera le condizioni di Marconi peggiorarono drasticamente.
Intanto, stava rientrando a Roma il professor Frugoni, del quale Pozzi era primo assistente. Non appena arrivò in stazione, Frugoni fu accompagnato in via Condotti su ordine di Pozzi. Nel frattempo, era stata avvertita la marchesa Cristina, che poche ore dopo rientrò in città, lasciando a Viareggio la piccola Elettra, ancora ignara della precarietà delle condizioni paterne.
«Buonasera, senatore», disse Frugoni entrando nella camera da letto di Marconi. Il professore visitò l’illustre paziente. Si rese conto che lo stato in cui versava lo scienziato era pessimo. Marconi fece chiamare un sacerdote per l’estrema unzione. Passò le prime ore del giorno assistito dal suocero e dal professore. Attorno alle tre e mezza del mattino si ritrovò da solo con Frugoni.
«Professore», disse Marconi con voce sommessa e affaticata, «sono dunque giunto al capolinea? Sto morendo?».
E Frugoni a lui: «Senatore, starà bene, glielo prometto. Mi lasci lavorare. Lei cerchi solo di riposare e di non pensare ad altro».
Consapevole che quella avrebbe potuto essere l’ultima conversazione con qualcuno, Marconi riprese però faticosamente a parlare, ignorando le parole del professore.
«Non me ne importa niente di morire… Del resto, la mia vita l’ho vissuta… Ho avuto successo, fama, gloria, onori, soddisfazioni d’ogni tipo. Ho assecondato le mie naturali inclinazioni, mi sono dedicato alla scienza, alla ricerca, al sapere. Ho contribuito all’unione dei popoli, ho contribuito al bene dell’umanità.
Mento, in realtà, quando le dico che lasciare questo mondo non mi duole. Elettra, la mia adoratissima, a soli sette anni rimarrà senza padre. Frugoni, abbandonerò a sé stessa la mia amata pupilla! Crescerà senza il rassicurante sostegno paterno… Chissà quanto soffrirà… Oh, povera figlia mia! Non avrò modo di gioire dei suoi successi. Sarò assente dal resto della sua vita. Quanto mi addolora lasciare la mia Elettra».
«Suvvia, non dica così. Rivedrà sua figlia e la riabbraccerà ancora. Farò di tutto per permetterlo. Le prometto che la salverò. Ora riposi, la scongiuro».
«Lei mente, professore. Lo dicono i suoi occhi. Sa bene che non rivedrò mai più la mia piccolina. Morirò oggi, su questo letto. Prima di esalare l’ultimo respiro, tuttavia, le voglio confessare un peso che da qualche tempo mi porto dentro.
Dopo una sincera adesione iniziale, ho coltivato una crescente disapprovazione nei riguardi dell’operato del regime dei fascisti. Giorno dopo giorno il fascismo si è discostato sempre più dalla mia visione delle cose. Ormai tanto a nulla può sottopormi Mussolini o qualche altro membro della sua banda di facinorosi.
Considerando la piega sempre più fortemente totalitaria che stanno assumendo i governi fascisti, mi sono chiesto più volte se la mia invenzione sia stata veramente un bene per il mondo. Non crede che possa costituire una minaccia? Che possa aprire la strada a un futuro di totale privazione della libertà?
Immagino uno scenario nel quale anche i più intimi aspetti della vita delle persone verranno controllati costantemente, mediante sempre più avanzati mezzi tecnologici. Uno scenario nel quale il potere sarà esercitato da una ristrettissima cerchia di magnati, che, per conservare i propri privilegi, negheranno ogni forma di libertà alla moltitudine. Gradualmente e senza che nessuno se ne accorga, si passerebbe da una prima fase, in cui ogni piccolo segno di eterodossia sarà annientato sul nascere, ad una seconda fase, nella quale le torme popolari non disporranno più di alcuna autonomia intellettuale, di alcun pensiero critico. Tutto ciò che le masse penseranno sarà omologato alla dottrina che il regime andrà propugnando loro. Alla gente andrà bene così, perché neppure si renderà conto della terrificante tirannia a cui si sarà sottoposti».
«Senatore, per favore, riposi. Lasci stare queste questioni e pensi solo a riposarsi». Ma Marconi non poteva riposarsi. La consapevolezza di non poter più indugiare gli aveva fatto scoprire delle forze che non sapeva di possedere. Prima di morire, doveva esporre a qualcuno il disastro che attendeva l’umanità.
«Frugoni lei non è del mio stesso parere? Non teme che il progresso scientifico potrebbe condurre l’umanità ad un destino tragico? Non ritiene che l’avanzamento tecnologico debba essere cauto e giudizioso? Non crede che l’uomo potrebbe abusare della scienza, costruendo armi dalla portata devastante, realizzando impensabili strumenti di controllo di massa, atrofizzando le proprie stesse capacità intellettive? Non trova che l’uomo potrebbe persino finire sottomesso dalle stesse macchine che ha ideato, sta ideando e ideerà per attenuare le proprie fatiche? Nel fare le mie invenzioni sono stato sempre spinto dalla volontà di unire l’umanità, non dall’intento di distruggerla.
Avrei voluto spingere su questi temi, sa professore. Avrei voluto dare un contributo, perché fra gli uomini si radicasse la convinzione che lo sviluppo tecnologico è un bene, ma soltanto finché è moderato dalla prudenza e dal saggio consiglio della ragione.
Cercherei di allestire un movimento a sostegno della sana evoluzione della tecnologia. Ahimè, però, ho esaurito il tempo a mia disposizione. Lei, invece, di tempo ne ha ancora. Professore, la prego faccia quello che io non sono riuscito a fare, illumini gli uomini, illustri loro il disastro verso il quale si stanno dirigendo. Quantomeno si limiti a spiegare al mondo quello che avrei voluto fare se non fossi stato stroncato dalla morte Lo faccia per me».
Ignaro della vicenda che aveva sconvolto lo scienziato la sera prima, il medico pensò che quelle parole altro non erano che le esternazioni di uomo confuso dal terrore di morire. L’idea del professore si rafforzò quando gli balenarono nella mente i possibili provvedimenti che il governo fascista avrebbe potuto prendere nei suoi confronti: se avesse dichiarato che in punto di morte un uomo dalla così alta levatura e dalla così vasta fama internazionale aveva ripudiato il regime, come avrebbe reagito Mussolini? Si volle convincere perciò che, dinanzi alla morte, Marconi avesse perso il senno e iniziato a delirare. Per rincuorare il suo paziente, tuttavia, Frugoni mentì: gli assicurò che avrebbe seguito le sue istruzioni, pur continuando ad affermare che si sarebbe salvato e che avrebbe potuto realizzare egli stesso quel progetto del quale gli aveva parlato.
Intanto, Marconi era diventato pallidissimo. Sollevando l’avambraccio vide che l’arteria non pulsava più. Rivolgendosi al dottore, pertanto, disse: «Come mai, Frugoni, il cuore non batte più ed io sono ancora in vita?». E il professore a lui: «Non faccia questi quesiti: è una questione di posizione perché ha l’avambraccio sollevato». Guglielmo gli accennò un lieve sorriso e disse: «No caro, per le vene sì, per le arterie no», dimostrando ancora fresca lucidità e dando prova della serenità con cui si stava approcciando al trapasso. Poi disse lentamente: «Del resto, non me ne importa nulla». Subito dopo ripeté con la stessa lentezza la stessa frase: «non me ne importa nulla». Dopodiché, si voltò ed esalò l’ultimo respiro. Frugoni tenne per sé le ultime volontà dell’inventore.
Erano le 3:45 del 20 luglio 1937 e moriva un grande uomo di scienza.
E voi, sareste disposti a salvare questa nostra umanità?
 |
 |
 |